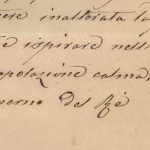Parma, 23 Febb. 1899
Cara Cognata,
Ho bisogno di un piccolo favore da te e te ne anticipo i ringraziamenti.
ecco di che si tratta: come saprai la mia matrigna dopo essersi impegnata, presente ancora la salma del mio povero Padre, a rispettare ed eseguire tutte le volontà di mio Padre compresa quella di continuarmi l’assegno mensile che egli mi faceva (godendo essa, che è ricca e non ha figliuoli né parenti, la pensione) venuto il momento di mantenere la promessa, dichiarò di non essere obbligata a nulla, di non aver preso nessun impegno, e invocando la legge, nulla mi diede, né mi darà. Dinnanzi a questo ingiusto deprecabile trattamento io allora le feci richiedere che almeno mi volesse far avere quegli oggetti che in varie occasioni di miei traslochi avevo lasciati presso mio Padre, per comodità mia e per evitare che si guastassero o si rompessero.
A questo essa oppose che occorrevano le prove che quegli oggetti erano di mia proprietà. anzi ora, per farmi recedere da ogni rivendicazione, minaccia e si dice disposta a far pubblicare il destamento di mio Padre, per volere la sua quarta parte di usufrutto, alla quale, nota, essa aveva già a voce e per iscritto rinunciato.
Come andrà questa storia non posso prevedere; patrocinio, perché per avere dieci sarebbe stoltezza esporsi a spendere cento.
A questa istanza vanno unite le prove della mia proprietà di questo o quell’oggetto.
Mi occorrerebbe che tu mi facessi una dichiarazione o attestazione che:
1° Una fruttiera di maiolica antica traforata con piatto pure traforato furono dati a tua sorella Emilia e sono dell’eredità materna; (ti ricorderai che codesti oggetti furono comperati da tuo Papà a Emilia quando fummo a Venezia.)
2° che ti consta di certa scienza che tua sorella Emilia comperò a Milano poltroncina bassa imbottita (già coperta di stoffa verde) dalla Signora Giuseppina Ballerini, e che l’hai sempre veduta in casa di me, tuo cognato, a Milano;
3° che tu hai sempre visto in casa mia una piccola etagere a tre piani, sulla quale tenevo dei libri a Milano (ricordi?) – e una coppa di maiolica colorata da deporvi giace sul lavabo; (la ricordi? era di questa forma ….segue disegno…, alta una ventina di centimetri).
Per redigere questa dichiarazione fatti assistere dall’Avv. to Crescini, pregandolo anche a mio nome e facendogli leggere la presente. Ti pregherei di farmi avere la dichiarazione con qualche sollecitudine perché debbo unirla alla domanda.
Ed ora, dati passo a queste noiose brighe, ti do notizia di noi.
Io lavoro come un mulo, potrei star meglio di salute, ma non dubito di star bene quando mi sarò levato dallo stomaco questi ed altri affari con i miei parenti, i quali tutti, pare, mi considerano un delinquente perché sono loro creditore e cercano di non soddisfarmi o di strozzarmi o di darmene insomma meno che possono.
Vostra sorella – povera cagna, dite voialtri, ha il suo da fare coi grandi e coi piccoli e sta perfino trentacinque, quaranta, quarantatre giorni senza uscire di casa. Non so come faccia a durarla così, e sempre ben messa, ma in questi ultimi tempi disturbata moralmente anche lei per tutte queste boierie che ti ho detto.
E veniamo ai tuoi nipoti: ho voluto tenerli per ultimi perché Dulcis in fundo:
n°1 – Tullia, la tua Tullia che hai tanto viziato, bellina, alta, sana, fa la quinta ginnasiale con molto onore, anzi insieme al n° 2, è la più brava della classe.
n°2 Carlo, al quale tu favoristi sempre tutti i capricci, bel ragazzo, vivacissimo bravissimo a scuola, una tempesta in capa, ma con suo Padre sta in riga; legge sessanta volumi al mese, a battuto tutti i suoi compagni maggiori di lui di tre quattro anni, e diventerà qualche cosa.
(Il n°1 e il n°2 sono sempre in contrasto fra di loro per ragioni di studi.)
n°3: Federico, bellissimo e carissimo bambino, che tutti vogliono per la sua soavità di carattere che ruba il cuore, destinato a diventare grande ingegnere edilizio, affettuosissimo, benché poco espansivo.
n°4: Pina, detta anche Pani, o Ingosoni, avvocato dei poveri etc. etc. viziata da tutti; peso Kg. 22 e forse più; sana; affettuosissima e molto espansiva: In complesso di tutta questa marmaglia non possiamo lamentarci, anzi ne abbiamo molte e vive compiacenze. Se con questa definizione sommaria ti ho fatto venir la voglia o, dirò meglio, ti ho aumentata la voglia di rivederli, sappi che anche loro, e ach’io, abbiamo voglia di rivedere te e ci auguriamo che ciò possa avvenire.
Ma debbo per un momento tornare agli affari: Tu fosti a trovarci in Adria: ti ricordi che nel mio tinello c’era una credenza di noce chiara a bordi neri? Se sì, aggiungi una dichiarazione anche per questa.
Ed ora chiudo pregandoti di salutarci caramente Bepi e i suoi figluoli e di darci stesse notizie di voi quando mi risponderai.
Frattanto ti saluto e ti ringrazio.
Fate di star bene, abbiate i saluti affettuosi di vostra sorella e baci dai ragazzi e credimi
tuo aff. mo cognato
Tullo[1]
1,00
20
44
44
30
10
—————
2,48
15
————-
2,53
16
————-
2,79
1,00
1,80
67
35
12
Note
[1] Tullo era figlio di Gaetano Bazzi (22.12.1832 – 28.11.1897) e di Giuseppina Sopransi (morta prima del 1884). Tullo Bazzi (2.12.1860 -19.03.1905) sposa nel 1884 Emilia Caonero (29.04.1861 – 22.11.1946). Era cugino di primo grado di Emilio De Bono(fonte)
Il figlio Carlo (03.06.1885) che sposa il 6.11.1913 Irene Basch subirà la perdita della cittadinanza italiana e nel 1932, questa verrà revocata:
REGIO DECRETO Ti novembre 1932, n. 1510.
Revoca di precedenti decreti con i quali si era inflitta la perdita della cittadinanza italiana a diciassette persone.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Visti i Nostri decreti: 126 marzo 1926, n. 500, con cui ò stata inflitta la perdita della cittadinanza italiana a …
…
3° – 30 settembre 1926, n. 1711, con cui è stata inflitta la perdita della cittadinanza italiana a Bazzi Emilio Carlo fu Tullio e di Caonero Emilia, nato a Milano il 2 giugno 1885;(fonte)
Antifascisti privati della cittadinanza.
Per stroncare l’attività dei partiti democratici che si erano riorganizzati in esilio – in Francia, in modo particolare – nel 1926 il governo fascista decise di privare della cittadinanza alcuni tra gli esponenti più autorevoli del mondo antifascista.
Con decreto del 26.3.1926 fu «inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti» a Vincenzo Vacirca, Angelo Tonello e Francesco Frola.
Vacirca era un militante del PSI nato in Sicilia ed eletto deputato nel 1919 a Bologna. Tonello era un maestro elementare veneto, pure lui iscritto al PSI, che aveva svolto un’intensa attività politica a Bologna nel primo ventennio del 1900.
Con decreti del 30.9.1926, pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia”, n.243 del 19.10.1926, la cittadinanza fu revocata, con la confisca dei beni, ad Emilio Carlo Bazzi, Ettore Cuzzani*, Alceste De Ambris, Giuseppe Donati, Arturo Giuseppe Fasciolo detto Benedetto, Giulio Armando Grimaldi, Adelmo Pedrini*, Mario Pistocchi, Massimo Rocca, Cesare Rossi, Aldo Salerno, Gaetano Salvemini, Francesco Scozzese Ciccotti e Ubaldo Triaca. Cuzzani e Pedrini erano due anarchici bolognesi.
La “Gazzetta” del 2.12.1932, n.278, pubblicò il decreto n.1.510 del 17.11.1932. Il documento, dopo avere richiamato i decreti relativi alla revoca della cittadinanza emessi nel 1926, recitava testualmente: «I Nostri decreti predetti sono revocati a tutti gli effetti».
Il governo fascista non motivò la decisione di revocare i decreti del 1926. Nel decreto di Cuzzani si legge che a Tolosa, sul giornale “Il Mezzogiorno”, aveva «in una serie di articoli, firmati con lo pseudonimo di “Cadetto di Guascogna”, esercitato una violenta, calunniosa campagna contro il Governo Nazionale e le patrie istituzioni, dipingendo la nostra situazione coi colori più foschi, facendo le insinuazioni più orrende, con gran detrimento del nostro buon nome, e con offese al nostro sentimento nazionale». In quello di Pedrini si legge che in Francia «divenne uno dei più attivi esponenti della campagna antinazionale, sia come redattore del giornale edito a Tolosa “Il Mezzogiorno”, famigerato per la sua intonazione violenta e sistematicamente denigratrice dell’Italia, sia in pubblici comizi, come quelli tenuti il 7 marzo u.s. a Tolosa ed il 30 maggio 1926 a Muret, nei quali lanciò le più volgari contumelie contro il Regime nazionale dipingendolo, all’occhio dello straniero, come un pericolo per la pace europea, incitando i governi democratici di Francia e degli altri stati ad unirsi per combatterlo ad oltranza, eccitando i contadini italiani, che sono in gran numero emigrati nel mezzogiorno della Francia, a diffidare dell’assistenza delle nostra autorità consolari, gettando sempre il sospetto e il discredito sulle nostre istituzioni». (fonte)
Su Emilio De Bono
Emilio De Bono. Nacque a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, il 19 marzo 1866 da Giovanni ed Emilia Bazzi. La sua famiglia, di origine lombarda, aveva “penato sotto il giogo austriaco” e tutti avevano combattuto nelle guerre d’Indipendenza (E. De Bono, La guerra…, p. 302).
Allievo del collegio militare di Milano nel 1878 e successivamente della Scuola militare, raggiunse il grado di sergente e nel 1883 quello di sottotenente del 12° reggimento bersaglieri; nel 1884 prestò giuramento a Verona e iniziò così il suo lungo viaggio attraverso l’esercito italiano. Volontario nella campagna d’Africa nel 1887-88 – in Eritrea -con il grado di tenente, al suo rientro in Italia il D. si sottopose a un periodo di addestramento militare alla Scuola di guerra alla fine del quale, nel 1896, fu tra i prescelti per il corso di abilitazione allo Stato Maggiore, idoneità che otterrà l’anno successivo.
Per tutto il primo decennio del 1900 il D. prestò servizio in diverse unità militari e nel 1907 fu decorato con la croce di cavaliere nell’Ordine della Corona d’Italia e nominato capo di Stato Maggiore della divisione di Novara. Qualche anno più tardi (1912) venne inviato in Libia come capo di Stato Maggiore di quella intendenza con il compito di “impiantare le basi logistiche a Misurata Marina”; partecipò alla guerra italo-turca e fu nuovamente decorato “per l’intelligenza e lo zelo” oltre che per “l’adempimento dei doveri della sua carica” (V. Araldi, p. 16).
Allo scoppio della guerra mondiale, di fronte alla dichiarazione di neutralità dell’Italia, il D. annotava in un suo libro di ricordi: “da un lato n’ebbi un primo senso di sgomento, la paura che dovessimo (sic) rimanere spettatori; dall’altro ne ebbi un senso di soddisfazione per non dovere fare la guerra a fianco dell’Austria” (La guerra, p. 31). Nonostante queste considerazioni la “necessità”, di entrare nel conflitto e di combattere si radicava sempre più nell’animo di un “soldato nato”, di un “uomo d’arme”, di un “guerriero”, come il D. amava definirsi.
Nel 1915 comandò il II corpo d’armata che operava sull’Isonzo, ma la sua grande “aspirazione” era la direzione di un reggimento, “meglio se di bersaglieri”; per intercessione di un amico, “che occupava un posto molto importante al Comando supremo”, non solo la sua richiesta venne esaudita, ma egli ebbe anche l’incarico di formare tale reggimento con tre battaglioni di milizia autonoma (ibid., p. 73).Per la sua azione valorosa in trincea fu decorato con una medaglia d’argento al valor militare e nel 1916, questa volta per intercessione dei duca d’Aosta, divenne comandante della brigata Trapani.
Pur essendo stato nominato maggiore generale -per meriti di guerra e nuovamente decorato nell’agosto del 1916 “per il valore personale” e “l’intelligente comando”, a causa dei contrasti insorti con il generale della divisione, fu destinato sul fronte albanese.
“Nel mio intimo – scriverà più tardi commentando la nuova destinazione – vi è sempre stato un certo amore per l’avventura; ho sempre riscontrato nel fondo di me stesso qualchecosa del soldato di mestiere. Non me ne vergogno. Cambiare, andare incontro al nuovo mi è sempre piaciuto”. Il fronte albanese non doveva però offrirgli quelle sperate emozioni e dopo, una prima ispezione la delusione era cocente: “Quando tornai a casa ero mortificato. Quell’essere stato sulle prime linee senza sentire né un colpo di cannone, né una fucilata, né il canto della mitragliatrice, mi aveva l’aria di qualcosa di falsificato” (ibid., pp. 225 s.).
Con la ripresa dell’offensiva in Italia, ai primi dell’agosto 1917, tale sensazione di malcontento si complicava di preoccupazioni legate alla carriera. “Per conto mio particolare poi sapevo che generali di me meno anziani avevano già avuto l’incarico del comando di un corpo d’armata. Dovevo considerarmi saltato, silurato? Tutto questo non mi teneva i nervi a posto” (ibid., p. 238).
In Albania il D. scrisse due composizioni teatrali: un dialogo veneziano (Minuetto) e una rivista (Albaneide) per sollevare il morale della truppa e “per fare opera di distrazione” (ibid., p. 236).
Rientrato in Italia all’inizio del 1918, assunse il comando del IX corpo d’armata sul monte Grappa e nel giugno ottenne la commenda dell’Ordine militare di Savoia per aver respinto un violento attacco austriaco.
Alla fine della guerra venne nuovamente decorato e nel 1919 ebbe il comando del XXII corpo d’armata con giurisdizione su tutta la Carnia fino al Tarvisio; da questa postazione militare il D. commentava da soldato le difficoltà delle trattative di Parigi e l’effettiva disparità dei vantaggi che le potenze alleate trassero dalla conclusione vittoriosa del conflitto: “Noi eravamo mobilitati; sentivamo quindi tutta la nostra responsabilità e dignità guerresche. Certo a chi era lì alla frontiera ancora contestata venivano i traversi di bile nel vedere e sentire così frustrati tutti i nostri sanguinosi sacrifizi” (ibid., p. 303).
È di fronte a tale situazione che il D. come tanti altri militari reduci dalla guerra, comincia ad “occuparsi” di politica; egli ricorda infatti come fino allo scoppio del conflitto non avesse mai badato alle varie crisi ministeriali e come conoscesse, per puro caso, il nome del presidente del Consiglio (Nell’esercito…, p.189); così mentre vietava la diffusione tra le truppe del “rinunciatario” Corrieredella sera, definito un “giornale sovversivo”, non poteva rimanere indifferente alla larga ospitalità che Il Popolo d’Italia offriva invece ai problemi dei militari, soprattutto degli ufficiali.
Il Popolo d’Italia, d’altronde, non senza qualche significativo incoraggiamento, si era attribuito pubblicamente il ruolo di portavoce dei problemi dei militari e nel febbraio 1919 Mussolini rivelava compiaciuto una confidenza del generale Caviglia: “[egli] … mi ha detto che legge sempre Il Popolo d’Italia per tenersi al corrente del pensiero e delle necessità dei soldati” (Il generale Caviglia e il Popolo d’Italia, in Il Popolo d’Italia, 1° febbr. 1919).
Particolarmente sfruttata dalla propaganda nazionalista era la questione di Fiume che i trattati di pace non avevano assegnato all’Italia e che divenne presto il simbolo di quella “vittoria mutilata” e della necessaria reazione “alla politica supina del nostro povero paese”, come scriverà più tardi il D. ricordando quei momenti; il generale plaudiva istintivamente all’occupazione della città da parte di D’Annunzio e dei suoi legionari: “Era un fatto d’importanza storica. Se non ci andava Lui chissà quando ci avremmo potute mettere il piede! Come soldato deploravo l’atto impulsivo dei reparti che avevano seguito il guerriero poeta; ma in cuore lo esaltavo. Ho passato notti poco tranquille con la coscienza in subbuglio. Vado, o non vado? Il pensiero della prossima inazione; le incertezze sempre crescenti per il prossimo avvenire; l’impresa superbamente patriottica, D’Annunzio stesso con il quale avevo combattuto alla 45 divisione… tutto mi attraeva; ma vinse l’abito disciplinare e mi adoperai perché non avvenissero diserzioni” (Laguerra, pp. 310 s.).
Dopo aver assunto nel marzo del 1920 il comando del corpo d’armata di Verona, il D., nel giugno, chiese ed ottenne di esser collocato in posizione ausiliaria speciale “per ragioni sue personali e di carattere politico”; uno dei motivi va probabilmente individuato nel rifiuto del governo Nitti di disperdere manu militari gli scioperanti dei Polesine, come proponeva il De Bono.
Ricostruire i suoi atteggiamenti politici prima dell’avvento del fascismo, i suoi primi contatti con Mussolini o con altre personalità del nascente movimento non è facile, poiché le fonti appaiono in molti casi incerte e contraddittorie.
L’elemento che maggiormente colpisce, leggendo i suoi ricordi di quegli anni, è il senso di disorientamento per la smobilitazione, la separazione dai combattenti, gli scioperi, l’incertezza del domani; qualcosa rende tristi questi giorni del gennaio 1920, annoterà nel suo Diario, “… l’opera nostra svalutata, l’Esercito messo in non cale ancora peggio che prima della guerra; il disagio … le incertezze del prossimo e del lontano avvenire. … In fondo, in fondo questa guerra per me è stata una larga messe di affetti, profondi e sinceri, mietuti e dispensati. Quanta, quanta tenerezza nel cuore è tutta dovuta alla guerra!… E adesso più niente; perché è inutile, nulla varrà a potermi riempire la vita, perché la mia vita era questa”; e ancora, alla data del 20 genn. 1920 aggiungeva “Viva la guerra, perdio, viva solo e sempre la guerra”. Si trattava di considerazioni dettate dal momento, scritte sull’onda del sentimento, istintivamente, ma che certo dovevano rispecchiare il carattere del personaggio, se lo stesso D. riprendendo, nel gennaio 1924, quegli appunti scriveva: “Dopo quell’epoca si sono maturati gli eventi che mi hanno portato dove sono. Riprenderò questi appunti della mia vita, perché rileggendo oggi… quello che ho scritto fin qui ne sono rimasto soddisfatto” (La guerra, pp. 313 s.).
Il D. non aveva legami o precedenti politici prima che il fascismo lo portasse alla ribalta; più tardi, negli anni Trenta, dichiarò che fin dai primi momenti della guerra, leggendo la “prosa di fuoco sprizzante volontà da ogni parola” firmata Mussolini, aveva manifestato tutto il suo entusiasmo per “quell’uomo”; nel luglio del 1917 avrebbe poi “vaticinato” Mussolini a un “caro amico generale” e dall’agosto del 1918 avrebbe stabilito con Mussolini stesso un contatto epistolare.
Secondo alcune fonti il D. avrebbe cercato di mettersi in contatto anche con socialisti e popolari, almeno fino a pochi mesi prima della marcia su Roma. L’unico dato certo è che il futuro quadrurriviro scrisse su Il Mondo, tra il febbraio e il giugno 1922, articoli fortemente conservatori che reclamavano aumenti di spese e di organico per l’esercito; una sua lettera del 12 ag. 1922 al cugino Carlo Bazzi – futuro direttore del Nuovo Paese -,massone, una delle figure di quel groviglio politico giornalistico sulle quali l’istruttoria per l’uccisione di Matteotti cercò di far luce, chiarisce in parte il suo avvicinamento al fascismo.
Il D. si rimproverava di esser rimasto troppo in disparte: “Io non conoscevo alcuno ed era mio torto ed una mia debolezza. Adesso qualcuno mi conosce… Hai visto anche in guerra? Avrai letto raramente il mio nome su perle gazzette; se lo vedevi lo trovavi storpiato”; avrebbe inoltre voluto che Mussolini lo associasse come “collaboratore militare” e continuava: “I capoccia fascisti mi accolgono bene; ma … ma mi pare che temano di vedere in me un concorrente e perciò mi tengono volentieri alla larga” (Arch. centr. d. Stato, Segreteria particolare …).
Il D. era uscito dal conflitto come comandante di corpo d’armata, era stato più volte decorato, ma nessuna peculiarità lo caratterizzava come un militare di sicuro rilievo. Balbo lo ricordava per il suo “sdegnoso atteggiamento allorché, per non accettare una transazione coi rossi che il Governo richiedeva”, aveva preferito lasciare i ruoli effettivi dell’esercito e porsi in posizione ausiliaria speciale (I. Balbo, Diario 1922, p. 142); comunque, la scelta del suo nome come “terzo camerata” per il comando della milizia risultò frutto di un complesso di circostanze fortuite.
Da un lato va tenuta presente la mutata situazione del fascismo nell’estate 1922, rispetto all’anno precedente; Mussolini puntava ora sull’elemento militare e si rallegrava che l’organizzazione fosse militare nei quadri, nel funzionamento e nello spirito, come un vero e proprio “esercito d’occupazione”. Il passaggio dalle squadre in milizia era già stato organizzato con un primo regolamento del gennaio 1922, ma l’esercito fascista doveva essere perfezionato e disciplinato, era dunque “necessario” che al comando ci fosse anche un generale, un militare dello Stato. La coalizione di interessi che Mussolini andava rafforzando consigliava di avere dalla propria parte anche un gruppo di alti ufficiali e il D., in particolare, poteva vantare, attraverso l’amicizia con il duca d’Aosta, dei contatti con la casa reale.
Nella riunione del comitato centrale del Partito naz. fascista (P.N.F.) del 13 ag. 1922, vennero scartati i nomi di Teruzzi, già vicesegretario del partito, e di Gandolfo, che era allora gravemente ammalato e con una difficile situazione familiare. Balbo ricorda nel suo Diario come, nel corso di un incontro con alcuni amici del Fascio milanese, fosse venuto fuori il nome del D., “che durante il recente concentramento di Milano [aveva] sfilato come un semplice gregario, confuso nella massa dei fascisti” (ibid., p. 142). Queste notazioni e il modo stesso con il quale emerse il nome del D., ci confermano nell’ipotesi che fino ad allora i rapporti del D. con il fascismo non dovevano essere stati né frequenti né facili.
Il D. si era iscritto al Fascio di Cassano d’Adda nel luglio 1922, così che, quando il suo nome, insieme con quello di Balbo e De Vecchi, venne portato alla direzione del partito per la ratifica, “pochi lo conoscevano personalmente” anche se il suo nome godeva di un certo prestigio e De Vecchi si era dimostrato entusiasta della scelta.
Se certo la milizia doveva presentarsi come uno degli “strumenti” della conquista del potere, Mussolini non voleva né poteva precludersi l’utilizzo di qualsiasi situazione politica favorevole, mentre le legioni, inquadrate e disciplinate, dovevano essere pronte a ogni comando per affermare che l’organizzazione armata alle sue spalle avrebbe continuato ad imporlo al di là della fiducia miracolistica nella breve vita dell’esperimento fascista.
In settembre il D. preparò con De Vecchi il nuovo regolamento della milizia a Torre Pellice, dove pare si trovasse anche il futuro ministro della guerra, il generale Diaz. Il nuovo ordinamento venne pubblicato il 3 ott. 1922 sul Popolod’Italia; tale pubblicazione, come è stato da più parti notato, può considerarsi l’atto politico più importante nella preparazione della marcia su Roma, sintomo di intenti e preparativi che si svolgevano pubblicamente come le dimostrative e imponenti adunate di Udine e Cremona e prima ancora l’azione su Trento e Bolzano. Nel regolamento di Torre Pellice si proclamava ufficialmente non solo la formazione di un esercito di parte, ma si rivendicava la necessità di usarlo per “costituire” le nuove gerarchie del futuro d’Italia.
Dalle Memorie di Marcello Soleri emergono tutte le perplessità e le cautele che lo stesso ministro dimostrò di fronte all’atteggiamento del D., responsabile di aver dato un ordinamento “decisamente militare” a un esercito di parte, pur essendo ancora in attività di servizio.
Soleri sottopose il comportamento del futuro quadrumviro alla direzione generale, che confermò “l’evidente violazione al regolamento di disciplina, per il che non rimaneva che di deferire il generale De Bono ad un Consiglio di disciplina. Prima di farlo – scriveva ancora Soleri – volli però usare un riguardo a quell’ufficiale, che aveva un bel passato militare e, mandatolo a chiamare, lo invitai a rassegnare le sue dimissioni, per evitargli quella misura. Gli aggiunsi che sarei stato lieto se avessi potuto tenere nel mio cassetto quelle dimissioni e che me ne sarei valso solo nel caso che il suo comportamento o le circostanze lo richiedessero” (Memorie, pp. 156 s.).
Il D. non solo non si dimise, ma gli avvenimenti successivi e le alte cariche alle quali fu preposto tra il 1922 e il 1924 fecero sì che fosse reintegrato nei ruoli dei militari in servizio attivo permanente. Tra l’agosto e l’ottobre del 1922 fu Molto attivo, ispezionò le legioni e prese contatto con gli uomini delle squadre, trasformate in milizia. Alla riunione di Milano del 16 ott. 1922, nella quale fu decisa la strategia della marcia su Roma e alla quale Mussolini, oltre agli uomini del comando della milizia e a Michele Bianchi segretario del P.N.F., invitò “senza avvertire nessuno” anche i generali Fara e Ceccherini, il D. mostrò da un lato tutti i suoi timori per un possibile allargamento del comando della milizia ad altri due militari, dall’altro affermò, d’accordo con De Vecchi, che le camicie nere non erano ancora pronte e che era opportuno aspettare qualche tempo. Il D. guardava dunque con sospetto a chiunque si facesse avanti nelle fila del fascismo, temeva una dilatazione del vertice militare e un’ulteriore suddivisione del comando, ma nello stesso tempo esitava, preoccupato per la preparazione delle squadre che gli sembravano ancora male organizzate dal punto di vista militare; il D. non condivideva inoltre la “spontaneità” delle squadre e già di fronte all’azione dei fascisti su Bolzano, che si svolse al di fuori delle direttive dei comando generale della milizia, e alla quale parteciparono le personalità più in vista del fascismo, aveva espresso a Balbo tutto il suo disaccordo: “così non si fa la guerra” e “neppure la rivoluzione”, gli scriveva (Balbo, Diario, p. 164).
Il D. era un moderato, ma in questo caso il suo atteggiamento attendista doveva scontrarsi con il parere opposto di Balbo e Bianchi al quale Mussolini dette poi il consenso finale.
Prima della marcia su Roma, il D., massone di piazza del Gesù, ricevette una forte sovvenzione dalla massoneria di palazzo Giustiniani, che doveva servire a finanziare il movimento fascista. Senza pretendere di dare alcuna versione o significato definitivi all’episodio va rilevato che, nell’ambito del più ampio legame tra massoneria ed esercito, il D. rappresentò uno dei possibili anelli, anche se forse non uno dei più importanti (G. Rossini, Ildelitto…, pp. 53 ss.; G. Vannoni, Massoneria…, pp. 101 s.).
Al convegno di Napoli il D. fu solo uno spettatore e il 26 ottobre ripartì per Perugia per esercitare il suo comando. Dal suo diario di campagna alla data del 29 ottobre è possibile individùare tutto il nervosismo, il senso di disagio di fronte alla mancanza di organizzazione, l’incertezza e le preoccupazioni che il D. aveva sottolineato e che, secondo lui, puntualmente si presentavano in tutta la loro gravità; ma alla fine della serata la tensione si attenuava, dopo la revoca dello stato d’assedio, e il D. scriveva: “Il dramma prende già la piega di una pièce a lieto fine” (cfr. Gerarchia, VII [1927], 10, pp. 960 ss.).
Il D. fu uno dei militari di grado più elevato a partecipare direttamente alla preparazione e alla direzione della marcia su Roma, anche se non ebbe alcuna influenza diretta sugli avvenimenti che portarono Mussolini al governo. L’unico gesto di una qualche importanza, ma scarsamente significativo dal punto di vista politico, fu di apporre la propria firma in calce a un documento del quadrumvirato nel quale si affermava che “l’unica soluzione politica accettabile” era un ministero Mussolini, nel quale il D. sperava di avere il dicastero della Guerra, che Mussolini ritenne però più opportuno affidare al generale Diaz, il “duca della vittoria”, un nome più prestigioso.
Nelle sue incertezze, contraddizionì e timori, nella sua unica ed autentica vocazione per la vita militare, fu questo il personaggio che Mussolini scelse come capo della Pubblica Sicurezza l’11 nov. 1922 e qualche mese più tardi, inserita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) nel corpus dello Stato e ordinato l’immediato scioglimento di “qualsiasi altra formazione a carattere o inquadramento militare” (r. d., 14 genn. 1923, art. 9), nominò anche comandante dell’esercito fascista.
Quella “febbre di ordine e di disciplina”, come ha definito Gioacchino Volpe il periodo successivo alla marcia su Roma, comportava la trasformazione e la modificazione delle squadre armate in milizia quale “salda organizzazione autonoma… sottratta alle oscillazioni di partito” e investita delle funzioni di “grande polizia politica”, secondo una direttiva che il D. impartiva al prefetto di Bologna (Arch. di Stato di Bologna, Prefettura, Gabinetto cat. 7, 1923).
Per tutto il 1923 il D. inviò ai prefetti e ai comandi di zona della M.V.S.N. ordini precisi di controllo e centralizzazione delle squadre, per l’eliminazione dei contrasti e degli abusi, mentre la “prevenzione” e la “repressione” erano le coordinate entro le quali le forze di polizia avrebbero dovuto agire.
Si trattava in quest’ultimo caso di un ordine che non doveva rivolgersi unicamente contro gli individui che potevano tramare a danno del governo, ma si indirizzava anche contro tutti coloro che sotto la camicia nera si rendevano colpevoli di “azioni di prepotenza”. “Se fascisti o sedicenti tali – si legge in un telegramma del luglio 1923 della direzione di Pubblica Sicurezza – commettono azioni inconsulte o atti di provocazione e prepotenza si colpiscano senza riguardo gli autori o i ritenuti responsabili. Quando poi con la bandiera fascista si coprono beghe personali o camarille si colpiscano senza indugio i responsabili, specialmente se capi” (Arch. centr. dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di P.S., Divisione Affari Generali e Riservati, 1923, busta 47, circolare del 31 genn. 1923, firmata De Bono).
Si trattava di una direttiva che cercava di controllare il fenomeno del dissidentismo, il persistere delle squadre ai margini della M.V.S.N. come strumento personale dei vari capi locali nel tentativo di “normalizzare” la situazione interna. Bisognava esercitare una violenza “ordinata” che reprimesse e colpisse al momento opportuno, dunque un’arma “razionale” non “sportiva e caotica”. Mussolini voleva una milizia disciplinata, pronta soltanto al suo comando, svincolata dai legami politici regionali, nei quali per altro trovava la sua forza e la sua coesione, unica formazione armata permessa, mentre tutte le altre venivano messe fuori legge.
Alla riunione del Gran Consiglio del luglio 1923 nella quale il D. riferì sulla forza e sulla situazione della M.V.S.N., l’esercito delle camicie nere veniva definito una forza indispensabile almeno fino a quando non si fosse realizzata, in tutte le amministrazioni ed istituti dello Stato, la successione della classe dirigente fascista. Mussolini, per quanto riguardava la fisionomia politica della M.V.S.N. e del rapporto che quest’ultima doveva stabilire con le istituzioni militari, puntava su una divisione di compiti e di ruoli; come sostenne più volte, fin dal gennaio 1923, se l’esercito e la marina dovevano prepararsi alla salda difesa degli interessi della nazione, vi era pur sempre la necessità di difendere il fascismo dal punto di vista politico.
In una prospettiva d’integrazione con lo Stato, il fascismo creò a tal fine una serie di istituzioni parallele: al Consiglio dei ministri faceva riscontro il Gran Consiglio, al prefetto il federale, all’esercito la milizia. È in questo parallelismo, in questo “correre insieme” mantenendo però le proprie caratteristiche e le proprie finalità, che va probabilmente ricercato e inserito il rapporto tra esercito e milizia. In quest’ottica il progetto dei D. del luglio 1923, che proponeva la trasformazione della M.V.S.N. da forza di polizia politica in organizzazione preposta all’educazione premilitare delle giovani generazioni, avrebbe sicuramente peggiorato la diffidenza e la rivalità fra i due corpi e venne infatti, per il momento, accantonato. Nel gennaio era stato inoltre approvato il nuovo ordinamento dell’esercito che sanciva la fine di qualsiasi istanza innovatrice e dava larga autonomia alle gerarchie militari.
La crisi che iniziò a profilarsi all’indomani del discorso di Matteotti alla Camera sull’andamento delle elezioni dell’aprile 1924 e che esplose al momento dell’uccisione del deputato socialista, per l’ampiezza e le responsabilità che poneva, costrinse il D. alle dimissioni dalla direzione generale della Pubblica Sicurezza.
Il ruolo del D. nell’assassinio di Matteotti non è mai stato chiarito completamente, certo è che egli non avrebbe mai preso una tale iniziativa senza una precisa autorizzazione. Il D. fu comunque responsabile del clima d’intimidazione nel quale si svolsero le elezioni dell’aprile; egli autorizzò infatti l’impiego di militi della M.V.S.N., raccomandando però che fossero scelti “elementi idonei, calmi ed energici” (Arch. centr. d. Stato, Min. Int., Dir. Gen. P. s., Div. Affari Generali e Riservati, busta 87, 25 genn. 1924).
Alla fine di giugno le accuse contro il D. si intensificarono e pur non essendo ancora formalmente indiziato, egli sentì la necessità di difendersi, in un’accorata lettera agli amici Balbo e Sacco, dalle accuse di aver organizzato o di esser semplicemente implicato neglì episodi contro Misuri ed Amendola o nell’assalto al villino Nitti.
In ottobre il D., amareggiato dalla nuova via crucis alla quale si sarebbe dovuto sottoporre nei mesi successivi, come scriveva in una lettera alla moglie, nella quale affermava inoltre che non aveva mai voluto fare “politica”, rassegnava le dimissioni da primo comandante della M.V.S.N. Consegnava in quell’occasione a Mussolini centocinquanta legioni alle quali, affermava, aveva cercato di “istillare il più alto spirito di disciplina”. Mussolini, accettando le dimissioni del quadrumviro, sottolineò il carattere “spontaneo” di questo gesto e propose il D. per la carica di governatore della Tripolitania: si trattava di un impegno nel quale, affermava Mussolini, egli avrebbe potuto impiegare utilmente le sue “attitudini di vecchio coloniale”. Mussolini cercava in tal modo di isolare il caso De Bono. L’istruttoria sull’uccisione di Matteotti stava per concludersi ed entro poco tempo il D., che nel marzo 1923 era stato nominato senatore, avrebbe dovuto presentarsi al Senato, riunito in Alta Corte di giustizia, per rispondere dell’accusa di aver organizzato e diretto un nucleo di polizia politica con compiti speciali, la “Ceka” fascista, che la denuncia Donati identificava con il comando generale della M.V.S.N.
Il processo si chiuse dopo sei mesi con l’assoluzione dei D.; la sentenza non poteva essere d’altra parte diversa dopo il discorso del 3 genn. 1925 nel quale Mussolini, chiudendo il periodo d’interregno istituzionale, rivendicava l’assunzione piena delle responsabilità “storiche”, “morali” e “politiche” e dichiarava che la “forza” rimaneva come dato peculiare del fascismo.
Il D. fu nominato governatore della Tripolitania nel luglio 1925 e fino al 1928 questa carica lo tenne lontano dal centro della attività politica.
Le pubblicazioni fasciste gli attribuirono il merito di aver ottenuto “brillanti risultati” nello sviluppo della agricoltura, nella creazione di scuole, nell’incremento del commercio in quelle regioni. Guardando da lontano la situazione politica italiana, confidava al suo Diario tutte le perplessità e le preoccupazioni sul “marcio” che continuava ad esserci nel partito e nella milizia, o E lui non ci mette riniedio”, scriveva il 22giugno 1928 (Diario, in Realtà illustrata, 19 sett. 1956).
Richiamato in patria alla fine del 1928, il D. fu nominato prima sottosegretario di Stato al ministero delle Colonie e nel settembre 1929, a seguito del rimpasto del governo voluto da Mussolini, titolare di quel dicastero. Fu questa la carica più alta che egli raggiunse nella gerarchia fascista. Per sei anni il D. esercitò così una grande influenza sulla politica estera fascista, che doveva culminare con l’attacco all’Etiopia.
A partire dal 1930, il D. prese sempre più apertamente posizione contro il negus Hailè Selassiè, favorendo i tentativi di disgregamento dell’Impero etiopico. Probabilmente non pensava ancora a una guerra contro l’Etiopia, ma la sua mentalità di militare gli ricordava che la disfatta di Dogali aspettava ancora una rivincita. Al di là di queste considerazioni, certo è che quando il D. visitò l’Eritrea, ai primi del 1932, dovette riconoscere che l’autorità del negus si era rafforzata tanto da far temere un ribaltamento dei rapporti di forza in Africa orientale. Pur essendo convinto che un intervento armato e un successo militare italiano avrebbero definitivamente stabilizzato la situazione, riteneva che un tale programma avrebbe avuto bisogno di una lunga preparazione e avrebbe comportato un’ingente spesa. Il D. mise comunque allo studio la possibilità di un’aggressione premeditata all’Etiopia, ma riteneva tuttavia che fosse necessario cercare l’assenso preventivo della Francia e dell’Inghilterra, secondo la tradizionale linea deglì ambienti coloniali italiani.
Alla fine del 1932, il ministro delle Colonie annotava nel suo diario: “Ho portato a Mussolini il progetto per un’eventuale azione in Abissinia. Gli è piaciuto. Comanderei al caso io. Sarebbe un bel canto dei cigno ! Dovrebbe essere pel 1935;ma io temo che non abbia ben calcolato spesa e conseguenze! Vedremo” (Realtà illustrata, 10 ott. 1956).
Il D. cercava in tal modo di concludere brillantemente la sua lunga carriera militare al comando di un esercito coloniale e il 16 genn. 1935 fu infatti nominato alto commissario per l’Africa orientale.
Mussolini era disposto ad ascoltare il parere dei militari e dell’esercito, ma era parimenti convinto che la guerra doveva essere fascista nel comando e nelle truppe; dette infatti ordini precisi affinché la maggioranza dei soldati venisse dalle camicie nere della M.V.S.N. (Arch. dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’esercito, filza 507, M.V. S.N.). “Dovrete sopportare fatiche e sacrifici e affrontare un nemico agguerrito” affermava il D. nel proclama del 2 ott. 1935 alle truppe italiane con l’ordine di avanzare oltre il Mareb. “Merito maggiore avrà la vittoria alla quale miriamo che sarà pura vittoria della nuova Italia fascista”.
Il 6 ottobre le truppe italiane raggiunsero Adua; si trattava di una conquista importante dal punto di vista psicologico e propagandistico, perché cancellava nell’opinione pubblica italiana tristi ricordi, ma non lo era altrettanto dal punto di vista militare. Alla metà del mese fu occupata Axum, città sacra per gli Etiopi che l’Inghilterra non voleva includere nei territori da cedere all’Italia, ma per i primi di novembre Mussolini ordinava di spingersi più avanti verso Macallè e ancora più a Sud verso l’Amba Alagi. La direzione stategica del D., in quel primo mese di operazioni militari, era percorsa da continui timori e da insistenti pressioni perché le truppe italiane si fermassero per consolidare le posizioni conquistate, stabilire un efficace sistema di comunicazioni ed approntare una serie di misure nei territori conquistati.
Il 9 novembre, nonostante tutte le esitazioni e le cautele, il D. si spinse verso Macallè, ma più oltre non riteneva di doversi inoltrare. A questo punto intervenne la decisione di Mussolini di sostituirlo nella carica con Badoglio.
Nella maggior parte della letteratura storica sulla guerra italo-etiopica e nel quadro delle opinioni correnti questa sostituzione avrebbe un’unica logica: Mussolini aveva bisogno di rapidi successi militari che accrescessero il suo prestigio, mentre il D., con la sua prudenza, non offriva più alcun tipo di garanzia in tal senso; inoltre non godeva la stima dello Stato Maggiore dell’esercito e dello stesso Badoglio. Il De Felice ha invece ipotizzato che la sostituzione del D. con Badoglio potesse essere dettata anche dalla necessità, conclusa la fase delle grandi operazioni militari, di contentare l’esercito, la Corona e gli ambienti tradizionalisti che si riconoscevano più volentieri in Badoglio, che per altro non faceva mistero di voler assumere il comando delle operazioni.Mussolini non pensava allora a un’iniziativa su vasta scala; lo confermerebbe il telegramma del 12 novembre al D., nel quale gli ordinava il rafforzamento della linea di Macallè, in attesa che si mettessero in moto le trattative politiche. Noi sappiamo ora che è dello stesso giorno la comunicazione al D. della sua sostituzione. Con Badoglio la guerra fascista poteva trasformarsi e concludersi come una guerra nazionale. La prima reazione del vecchio quadrumviro fu: “in sostanza sono contento”. Come ricompensa per l’attività in Etiopia ebbe poi il titolo di maresciallo.
Al suo rientro in Italia non ebbe però alcun tipo di incarico ufficiale di una certa rilevanza fino al 1939; nella carica di presidente per la formazione dell’esercito coloniale cercò di interferire con il lavoro del ministero della Guerra; per tutto il 1936 al nome del D. si accompagnarono voci sempre più insistenti di errori finanziari e nel 1937 la sua persona fu coinvolta in uno scandalo che attirò l’attenzione generale.
Il D. era amareggiato dall’atteggiamento distaccato che Mussolini aveva tenuto nei suoi confronti durante il 1937, ma provava anche una difficoltà crescente a riconoscersi ancora nel fascismo: “Non mi ci trovo più per tante cose che vanno a sfascio” scriveva nel suo Diario “parlarne al Principale. Ma mai! Sarebbe voce isolata. Tutti o quasi la pensano come me, ma chi ha il coraggio di parlare? !” (Arch. centr. d. Stato, Diario, quad. 43, 30 ott. 1938). Non si trattava di un atteggiamento isolato; infatti altre memorie, diari e testimonianze di collaboratori di Mussolinì sottolineano la difficoltà di stabilire con il duce un rapporto politico non completamente formale.
Per la votazione delle leggi antisemite l’atteggiamento del D. rispecchiò, ancora una volta, il suo innato senso della moderazione: si dichiarava antisemita, ma proponeva un’attenuazione dei provvedimenti contro gli ebrei.
Col il 1938 il D. assunse sempre più un atteggiamento che, se è eccessivo definire di “fronda”, segnava certamente la fine della sua incondizionata adesione al fascismo tanto è che ai primi del 1939 aveva augurato a Mussolini un “Caporettino”, affinché aprisse gli occhi sulla situazione politica all’estero come in Italia.
Da parte sua Mussolini, di fronte all’atteggiamento “tiepido” del D., rispondeva con durezza: “De Bono è un vecchio cretino” avrebbe affermato in occasione delle celebrazioni del ventennale della fondazione dei Fasci di combattimento. “Non a causa degli anni, che possono rispettare l’ingegno se c’è stato, ;na perché è sempre stato cretino ed ora è anche invecchiato” (G. Ciano, p. 272).
Alla fine del 1939 il D. assunse alcuni incarichi ufficiali: ispezionò le difese occidentali dell’Italia e presentò a Mussolini un rapporto molto pessimista sulla situazione morale e materiale dell’esercito; nonostante l’età avanzata, fu nominato ispettore delle truppe. d’Oltremare e nel giugno del 1940 assunse il comando delle armate del Sud.
Il D. fu sempre contrario all’entrata in guerra dell’Italia e ai primi del 1940 confidava al suo diario che Mussolini era ormai “spacciato”. Negli anni successivi continuò a viaggiare in Europa senza mai avvicinarsi alle linee del fronte e non partecipando alla guerra, circostanza della quale si lamentava continuamente.
Il D. fece parte del gruppo che chiese a Mussolini la riunione del Gran Consiglio e nella seduta del 25 luglio 1943 fu il primo a parlare dopo il duce. Il suo discorso era centrato principalmente sulla condizione delle forze armate e sulla difesa dell’operato dell’Alto Comando, e non avanzò alcuna richiesta diretta alla destituzione di Mussolini.
Il suo discorso risentiva dei clima fortemente teso che caratterizzò quella seduta ed egli stesso apparve “confuso” e privo di concentrazione (C. Scorza, La notte…, p. 38). Prese la parola una seconda volta e dette poi il primo voto favorevole all’o.d.g. Grandi, segnando in tal modo il suo destino.
Fino all’arresto, che avvenne il 4 ott. 1943, il D. godé di larga autonomia e libertà e visitò persino il ministero della Guerra. Fino al gennaio del 1944 rimase a Cassano d’Adda; fu poi trasferito a Verona, ma rimase separato dagli altri prigionieri. La sua difesa si svolse in due tempi: nell’interrogatorio preliminare, avvenuto in dicembre, affermò che non sì era mai occupato di politica e rifiutò decisamente la qualifica di traditore, una seconda volta il vecchio generale, che vestiva l’uniforme e le decorazioni, si presentò davanti al tribunale straordinario speciale con gli altri “colpevoli” di aver firmato l’ordine del giorno Grandi. Il D. ricordò, in quest’occasione, i servizi che aveva prestato al fascismo e giurò fedeltà a Mussolini. Il processo si chiuse con la sentenza di morte per tutti i principali imputati.
Nei mesi che precedettero il suo arresto il D. aveva pensato di fuggire all’estero, di abbandonare la sua casa e la sua patria; come militare riteneva di dover rimanere a salvaguardare il suo onore, non riuscì mai a capire la situazione politica e in fondo pensava che Mussolini non avrebbe permesso che gli facessero alcun male.
Nella sua ultima lettera alla famiglia riaffermò l’onestà della sua vita e del suo nome; la mattina dell’esecuzione, l’11 genn. 1944 a Verona, acconsentì, dopo una certa insistenza, a farsi bendare e morì gridando “Viva l’Italia”. Tra le opere di carattere militare del D. vanno ricordati: Nell’esercito nostro prima della guerra, Milano 1931; La guerra come e dove l’ho vista e combattuta io, ibid. 1935; Dal Mareb a Makallè, Roma 1936; La preparazione e le prime operazioni, ibid. 1937; Origini della milizia e suoi primi ordinamenti, in Le forze armate dell’Italia fascista, a cura di T. Siliani, Roma 1939.(fonte)