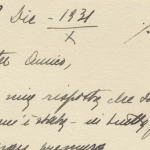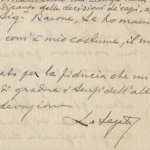Roma, 15 dic. 1931
Ill.mo sig Barone,
voglia scusarmi se rispondo in ritardo alla sua
gradita del I corr. La causa sta nel fatto che sono stato circa
tre settimane in campagna, e tornando ho trovato tutta la corri-
spondenza naturalmente ammucchiata ed arretrata. Comincio pertanto
con ringraziarla della citazione del mio nome fatta sul Giornale di
Genova nell’articolo su Corselli[1].
Non dimentico i documenti di cui le ho promesso copia e che
Le invierò al più presto: anche questo ritardo è stato causato da
un altro fatto accidentale: il mio avvocato presso cui stanno tut-
te le mie carte (una montagna) ha trasferito il suo ufficio, e quin-
di per un mese non si è parlato più di ricercare documenti.
Rispondo ora al quesito che ella allega alla sua cartolina,
circa la battaglia di giugno 1918.
I° – E’ esatto che il nostro C/S[2]. aveva preparato una offensiva
sul fronte della 6.a armata[3]. E’ vero che lo sforzo austriaco su
quel fronte fu stroncato sin dal primo giorno della battaglia (Fu
merito principalmente del comandante dell’art. dellla 6° armata; ge-
nerale Segre[4]: per compenso gli fu poi stato fatto un processo ignobile
ed ora è stato saltato alla promozione a Comandante di C. d’Armata – è una
delle principalissime figure messe in vista dalla guerra e naturalmen-
te ora, con il vento che tira, si cerca di mandarlo subito a casa)
2° – Si aggiunge che il servizio informazioni della 6° armata,
diretto in modo mirabile dall’allora T.Col. Finzi[5] (ora silurato ed
a casa) dette la sera stessa notizie precise sulla vera distruzione
che avevano subito le divisioni d’attacco austriache.
3° – Però, la nostra situazione sul Piave e soprattutto al Mo-
tello, era grave – Le armate Pennella[6] e Duca d’Aosta[7] avevano avuto
le prime linee travolte e sfondate su largo fronte. Specialmente
al Montello la situazione poteva divenire gravissima, e perciò non
furono di troppo tutte le riserve che il C.S. aveva –(comprese le 2
divisioni della Val Giudicaria che si fecero venire in autocarro)
per arrestare, poi respingere l’avanzata austriaca.
Ora, se noi avessimo attuata subito una controffensiva a Nord
non avremmo avuto certo le forze per parare alla minaccia che veni-
va dal Piave: la avanzata delle truppe del f.m. Boroevic[8] dal settore di
Meolo su Treviso, avrebbero arrestato il nostro movimento.
In una battaglia difensiva di grande stile come quelle del giu-
gno 1918, non si può assolutamente gettarsi in azioni controffensi-
ve prima di essersi assicurati le spalle: bisogna rammentare che
noi eravamo distesi in semicerchio e che la perdita di Treviso si-
gnificava la impossibilità in ogni caso di avznzare a Nord.
Si aggiunga che, a mio modo di vedere, l’avanzata a Nord sarebbe
stata sempre un errore. Se le cose fossero andate bene, si poteva
sperare di giungere a Cima XII: in caso di fortuna eccezionale, si
sarebbe giunti a Trento, e poi? Le cose restavano al punto di prima.
Nel 1918 il problema non era già di ottenere una vittoria tatti-
ca: era di vincere la guerra e cioè distruggere l’esercito a.u.
Ora, questo non si poteva ottenere con una vittoria sulle monta-
gne. E nemmeno con una avanzata sul Basso Piave. Se si esamina il
nostro problema strategico dopo la ritirata sul Piave, si è fatalmen-
te ricondotti all’idea di una avanzata in direzione di Vittorio Vene-
to, direzione che era la più efficace e che io ho sempre sostenuta.
Questa idea fu infatti adottata dal M. Caviglia[9] e fu in seguito
alle sue insistenze che si Addivenne poi al piano di V. Veneto.
– – – – –
Una controffensiva nostra non poteva quindi iniziarsi prima
di aver respinto definitivamente il Gruppo Boroevic: essa doveva
svolgersi in direzione di V. Veneto e mirare alla distruzione delle
armate a.u. della pianura.
Ecco i due punti essenziali che si debbono considerare se si
pensa ad una azione controffensiva di grande stile.
Se la sera del 22 giugno le nostre armate 8. a e 3.a opportunamente rafforzate avessero
avuto ordini in tal senso, la vittoria del Piave sarebbe stata certa-
mente una delle maggiori che la storia annoveri.
Era questo possibile?
Il C.S. ha cercato poi in tutti i modi di dimostrare di no, allegan-
do la stanchezza delle truppe e la scarsezza dei complementi. Ora,
questi due elementi non giustificano l’inazione. Le truppe erano
ultra esaltate dalla vittoria: era il momento di richiedere loro sforzi
sovraumani. Avevamo 200 mila complementi; tanti cioè da ripianare
largamente alle perdite della battaglia e di alimentare per qualche
tempo la nuova offensiva. Avevamo alla testa dell’8a armata un
generale di assalto e cioè il g. Caviglia: era quello il momento di
osare. Ma per osare occorre avere l’animo di un eccellente burocrate.
Se si pensa alla timidità d’animo del governo, alla poca fi-
ducia che i burocrati avevano nelle truppe (che non conoscevano) si
spiega perfettamente come ci si sia limitati di respingere l’attacco
austriaco, ringraziando il cielo e facendo voti ai santi perché era
stato respinto. Tuttavia, il C.S. sentì talmente la sua carence di
fronte all’entusiasmo dell’esercito vittorioso, che, tanto per fare
qualcosa, ordinò l’azione del Basso Piave; azione di nessuna impor-
tanto militare o politica, fatta per la stampa: per poter dire
che si era guadagnato “terreno” ( !!! )
Tale è la mia opinione sul quesito che ella mi pone, e sono
certo che in tal senso si esprimeranno coloro che nell’esercito capi-
scono qualcosa di strategia. Io ne parlai già a lungo col il G. Gra-
zioli[10] da cui dipendevo a quell’epoca, ed egli era precisamente della
mia opinione.
Ha seguito la polemica che si svolge vivissima in Belgio
circa l’impiego dell’esercito all’inizio della campagna del 1914?
Me ne ha scritto il gen. de Selliers de Moranville[11], già
capo di S.M. belga a quell’epoca, con il quale sono restato in rap-
porti dopo la mia partenza dal Belgio. I suoi libri sono di alto
interesse storico e le sue concezioni strategiche, perfettamente giu-
ste e giustificate.
Gradisca, illustre sig. Barone[12], l’espressione dei miei mi-
gliori sentimenti e mi creda
suo dev.mo
Montuori[13]
ROMA FERROVIA (B)
ROMA FERROVIA (B)
POSTE ITALIANE CENT. 50
GENOVA – CENTRO
GENOVA SEZIONI RIUNITE
Note
Una premessa sul memoriale:
Quello che nello scritto viene nominato “…quel Comandante di Divisione” è il Generale Edoardo Monti[14]. I memoriali dei vari Generali redatti su sollecitazione del Barone Lumbroso in merito alla questione sollevata dal Generale Monti, relativa alla mancata controffensiva italiana in grande stile la sera del 15 giugno 1918 contro il gruppo Conrad, non rivelano mai il nome del Generale al quale rispondono. Il nome appare nel biglietto privato che il Generale Vannutelli acclude al suo memoriale.
[1] Corselli Rodolfo (Generale dell’esercito)
Nato il 16 agosto 1873 e morto a Roma il 17 gennaio 1961
Frequenta’ l’Accademia militare di Modena e percorse tutti i gradi di una brillante carriera. Partecipò alla guerra italo-turca e al primo conflitto mondiale, riportando 4 medaglie d’argento e moltissime onorificenze.
Nel 1921 diventa’ capo di Stato maggiore del X Corpo d’armata di Palermo e nel 1924 ebbe affidato l’incarico di comandare la Scuola allievi ufficiali di Palermo.
Nel 1934 fu promosso generale di Corpo d’armata e assunse il comando della difesa territoriale di tutta l’Italia centrale.
Studioso di tecnica e di storia militare, lasciò numerose pubblicazioni ricche di ricordi e di valutazioni dei vari conflitti di cui era stato protagonista. Si ricordano alcuni titoli: “L’arte della guerra nelle varie epoche della storia” (1897); “Le vicende della nostra guerra” (1919); “La grande guerra” 1915-18 alle fronti italiane (1942); “Cinque anni di guerra italiana nella conflagrazione mondiale 1939-’45”, Roma, Tip. Regionale 1951, pp. 280. (fonte)
Corselli Rodolfo nelle celebrazioni della prima guerra mondiale di Miranda Pampinella
…
Una testimonianza interessante della Grande Guerra la lascia il palermitano Generale C. A. Rodolfo Corselli, allora Colonnello di Stato Maggiore, in una Conferenza dal titolo “Le vicende della nostra Guerra” tenuta a Palermo il 6 aprile 1919 nella grande aula della Storia Patria.
A tal proposito, in occasione delle celebrazioni della prima guerra mondiale, la famiglia del prof. Manlio Corselli ha voluto far dono al Generale B. Claudio Minghetti, Comandante Militare Esercito “Sicilia”, di un quadro collocato nella Caserma Rosolino Pilo che raffigura S. E. il Generale C. A. Rodolfo Corselli, che ha onorato Palermo come Comandante dell’Accademia Militare di Modena, studioso di Storia Militare e autore di opere su Cadorna e Diaz.
“Questo dono è per non dimenticare Rodolfo Corselli, che fu decorato nel 1915 della Croce di Ufficiale nell’Ordine della Corona d’Italia dell’Ordine dei Santi S.S. – spiega Manlio Corselli – e nel 1917 decorato della Croce di Ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; nel 1918 fu decorato della Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. Fondò il gruppo “Arditi Corselli” che si occupavano dell’offensiva contro gli austriaci. La Commissione d’inchiesta, riferiva il Corselli, presieduta dal senatore Mortara incaricata di accertare le violazioni delle norme di guerra compiute dagli Austriaci, riportava i dati della mortalità nelle terre italiane occupate da quella che il Carducci, trent’anni prima, aveva chiamato “micidial masnada”.
Per farci un’idea della reale situazione, riportiamo taluni raccapriccianti episodi resi noti dalla Commissione d’inchiesta e consultabili sul libro “Lampi di memoria – La Grande Guerra a Palermo” della giornalista Melinda Zacco e tratti dal Giornale di Sicilia del 6 – 7 aprile 1919: il generale comandante della 26^ divisione honved, a una madre presentatasi a lui con tre piccoli figli affamati, invocante soccorso, rispondeva “Se avete fame, mangiate prima il più piccolo, e poi gli altri”; ancora, un governatore austriaco disse alle autorità: “Datemi la popolazione nella piazza, che la sfamerò con le mitraglie”.
“Le informazioni riportate dal generale Corselli sono state preziose per ricomporre una parte della storia che non viene raccontata solitamente sui libri. La Grande Guerra, questa inutile strage, ha prodotto in Italia 650.000 morti, 947.000 feriti e oltre 600.000 dispersi. Ma nessun dice che il 90% di queste vittime era gente del Sud – spiega Melinda Zacco – a cui avevano promesso terre e condizioni migliori di vita. Come la Gran Bretagna ha usato indiani e afgani, e la Francia algerini e i tunisini, così l’Italia ha usato i popoli meridionali, l’ex Regno delle Due Sicilie. In tutti i nostri paesi del Sud troviamo lapidi con centinaia di nomi caduti per la Guerra, un’intera generazione. Eppure i meridionali lasciarono le proprie case, i campi, le proprie famiglie per rispondere alla chiamata alle armi ed irrobustire le file di un esercito forse per la prima volta veramente nazionale, che avrebbe dovuto difendere un confine e la Patria. Morirono in tanti, pensate che i meridionali impiegati nella Grande guerra furono il 51,3% dei soldati contro il 48,7% impiegato dall’Italia Settentrionale. Ben 5.903.000 uomini chiamati alle armi. Nelle forze dell’ordine istituzionali furono impiegati oltre 158.000 uomini, tutti di origini meridionali. Ma le vere vittime della guerra, oltre il 56% , furono i civili e i contadini che dovettero lasciare a casa la zappa per inforcare la baionetta che non sapevano nemmeno come fosse fatta. I siciliani erano pronti a tutto: avevano affrontato ogni sorta di fatica, avevano superato ogni sorta di difficoltà e, mentre dall’altro lato gli avversari bestemmiavano, i siciliani cantavano; mentre dall’altro lato l’ufficiale spingeva avanti i suoi uomini con la pistola in pugno, i siciliani bisognava invece frenarli col quotidiano crescere dell’entusiasmo patriottico”.
Credo che la Grande Guerra ci insegna che con fede e con sacrificio si rinnovano i destini dei popoli, con la speranza che possa essere una lezione per la nostra generazione che sta vivendo oggi una guerra piena. (fonte)
Rodolfo Corselli era un Generale dell’esercito, nato a Palermo il 16 agosto 1873 e morto a Roma il 17 gennaio 1961. Frequentò l’Accademia militare di Modena e partecipò alla guerra italo-turca e al primo conflitto mondiale, ottenendo 4 medaglie d’argento e moltissime onorificenze.
Nel 1921 venne nominato capo di Stato maggiore del X Corpo d’armata e nel 1924 fu incaricato del comando della Scuola allievi ufficiali di Palermo. Promosso generale di Corpo d’armata nel 1934, assunse il comando della difesa territoriale di tutta l’Italia centrale.
Studioso di tecnica e di storia militare, scrisse diverse opere.
Questa avrebbe dovuto comprendere due volumi, il primo (questo), con gli avvenimenti che hanno preceduto la guerra, arriva fino all’armistizio con la Francia (25 giugno 1940), escludendo la parte della guerra italiana. Il secondo, che non risulta mai pubblicato, avrebbe dovuto comprendere gli avvenimenti successivi e la parte italiana. (fonte)
Il Generale Rodolfo Corselli, nipote di un ex garibaldino, ebbe modo, all’età di soli 8 anni, di conoscere il Generale Garibaldi, nel 1882 durante una parata celebrativa in onore dell’Eroe dei due Mondi, all’epoca in visita a Palermo in occasione del Centenario dei Vespri, che egli considerava un esempio eccelso dell’eroismo del popolo siciliano verso il quale nutriva ammirazione e rispetto. All’epoca già vecchio e malato, Garibaldi fu tuttavia acclamato a voce di popolo da una folla festante. L’episodio rimase indelebile tra i ricordi più cari dell’A. che volle anche lui, come molti altri, commemorare l’Eroe, simbolo dell’Unità d’Italia, narrandone le gesta.(fonte)
[2] Il Comando Supremo Militare Italiano era l’organo di vertice delle forze armate italiane, tra il 1915 e il 1920, durante il Regno d’Italia.
Istituito durante la prima guerra mondiale, il 24 maggio 1915, con sede operativa a Villa Volpe a Fagagna e dal mese di giugno nel Liceo classico Jacopo Stellini di Udine. Il Comando Supremo del Regio Esercito fu sciolto il 1º gennaio 1920 e parte delle sue competenze passarono allo Stato Maggiore del Regio Esercito.
Tra il 1941 e il 1945 fu istituito il Comando Supremo italiano.
Era suddiviso in tre organi principali, l’Ufficio del Capo di stato maggiore dell’Esercito Italiano Tenente Generale Luigi Cadorna, il Riparto Operazioni e il Quartier generale, composti da un certo numero di uffici ciascuno.
L’8 novembre 1917, dopo la Battaglia di Caporetto, la sede, dopo aver ripiegato dal 27 ottobre a Palazzo Revedin di Treviso, poi a Palazzo Dolfin di Padova, poi nella villa di Bruno Brunelli Bonetti a Tramonte di Teolo è stabilita all’Hotel Trieste di Abano Terme agli ordini del Generale Armando Diaz.(fonte)
[3] Sesta Armata (Regio Esercito). Le origini della grande unità risalgono al 28 maggio 1916 quando venne costituito il Comando truppe altipiani, che venne posto alle dipendenze tattiche della 1ª Armata e immediatamente impiegato per arginare l’offensiva austriaca in Trentino, la cosiddetta Strafexpedition o Frühjahrsoffensive (“offensiva di primavera”). Fortemente voluta e pianificata dal Capo di Stato maggiore dell’Imperial regio Esercito austro-ungarico, feldmaresciallo Franz Conrad von Hötzendorf, l’offensiva aveva il dichiarato intento di annientare l’Esercito Italiano scatenando una poderosa offensiva attraverso le linee della 1ª Armata, per prendere di rovescio l’intero schieramento italiano. Successivamente il Comando truppe Altipiani venne schierato tra la Val d’Astico e la Valle del Brenta.
Il 1º dicembre 1916 il Comando truppe altipiani fu trasformato nel Comando della 6ª Armata, prendendo parte, dal 10 al 29 giugno 1917, al comando del generale Ettore Mambretti alla battaglia del monte Ortigara sull’altopiano dei Sette Comuni, attaccando in forze il settore austro-ungarico difeso dall’11ª Armata del generale Viktor von Scheuchenstuel. Il 20 settembre 1917 il Comando della 6ª Armata venne trasformato nuovamente in Comando truppe altipiani, che venne definitivamente sciolto il 1º marzo 1918, e venne ricostituito nella stessa data il Comando della 6ª Armata, al comando del Tenente generale Luca Montuori, distinguendosi particolarmente durante la battaglia del Solstizio e nel mese di ottobre in quella di Vittorio Veneto.
Alla vittoria nella battaglia del Solstizio contribuì notevolmente il comando artiglieria del Maggior generale Roberto Segre, grazie alla tattica della “contropreparazione anticipata”, con cui l’artiglieria della parte in difesa non si limita ad attendere il tiro di preparazione avversario, ma lo eguaglia o lo anticipa, non limitandosi al fuoco di controbatteria ma prendendo di mira anche i luoghi di adunata delle truppe avversarie, fiaccandone così la spinta offensiva. Questa tattica permise di bloccare sul nascere l’offensiva austro-ungarica sugli Altipiani, tanto che le artiglierie di Segre poterono essere distolte dal proprio fronte per intervenire in difesa del settore occidentale del Grappa..
Tra le file della 6ª Armata vi è stato, presso l’Ufficio informazioni, dal dicembre 1916 al luglio 1917, il Capitano pilota (ex del 6º Reggimento alpini e decorato anche nella Guerra italo-turca) Armando Armani futuro Capo di stato maggiore della Regia Aeronautica.
Il 10 maggio 1917 venne costituito il Comando Aeronautica che aveva alle dipendenze il VII Gruppo, poi 7º Gruppo Autonomo Caccia Terrestre. L’8 novembre successivo venne chiuso il Comando Aeronautica ed il 17 marzo 1918 venne costituito l’Ufficio di Aeronautica con il Maggiore Ermanno Beltramo che aveva sempre alle sue dipendenze il VII Gruppo. Dal 4 ottobre 1918 la 6ª Armata ricevette alle sue dipendenze il XXIV Gruppo aereo.
Al termine del conflitto, il 1º luglio 1919 la 6ª Armata venne definitivamente sciolta.(fonte)
[4] Roberto Segre. Nacque a Torino il 6 aprile 1872 da una famiglia ebrea originaria di Saluzzo. Il padre, Giacomo, si distinse nella presa di Roma del 1870 come ufficiale dell’esercito del Regno d’Italia; la madre si chiamava Annetta Segre.
Già nel 1885 fu al Collegio militare di Milano, quindi frequentò brillantemente l’Accademia di Torino, da cui uscì sottotenente di Stato maggiore di artiglieria (16 novembre 1890), l’arma di cui divenne un noto esperto. Dopo la formazione alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio e le prime assegnazioni a Genova, nel novembre del 1895 fu traferito all’Ispettorato delle costruzioni di artiglieria in Roma, dove poté dedicarsi alle prime ricerche (nel 1895-97 pubblicò studi su nuovi sistemi di sviluppo tecnologico e d’impiego dell’arma). Frequentò la Scuola di guerra di Torino (1897-1900) e si dedicò all’approfondimento delle lingue (fu in Germania nel settembre del 1900). Nel corso del 1900 fu al 3° reggimento di Bologna, allo Stato maggiore della 12ª divisione di manovra e, a Roma, presso il Comando del corpo di Stato maggiore. Nel maggio del 1901 fu trasferito a Napoli, al Comando artiglieria del X corpo d’armata. Promosso capitano nel dicembre del 1902, fu trasferito al 20° reggimento di Padova.
Il 6 aprile 1905 – da febbraio era presso il Comando della divisione militare di Perugia – sposò la contessina Paolina Corinaldi, da cui ebbe tre figli.
Nel novembre del 1907 poté tornare, non senza ostacoli, al suo incarico a Roma.
Seguirono anni di servizio effettivo, studio e lavoro editoriale, corsi di perfezionamento e attività addestrative. Alcuni studi teorici d’artiglieria trovarono applicazione tardiva durante la guerra di Libia (1912-13) e nella Grande Guerra, altri – nonostante le novità tecniche e operative – vennero osteggiati sia da colleghi sia dal governo italiano (Zarcone, 2014, pp. 17 nota, 21-23, 30 s.).
Dal 20 settembre 1911 – alla vigilia dell’intervento italiano in Africa – Segre fu in Tripolitania presso l’ufficio coloniale, dove predispose uno studio per il nuovo assetto difensivo delle località occupate dal corpo di spedizione italiano. Partecipò anche alle operazioni belliche dell’estate del 1913 (fu, comunque, in Italia da marzo a settembre del 1912).
Con l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra, nel maggio del 1915 il promosso maggiore (aprile 1914) raggiunse il fronte in qualità di capo di Stato maggiore della 23ªͣ divisione fanteria e, in settembre, ottenne il grado di tenente colonnello.
La competenza di Segre – che dovette, tuttavia, incontrare non pochi ostacoli in ordine alle promozioni – determinò l’efficacia delle azioni di fuoco in diversi frangenti del conflitto: durante la terza battaglia dell’Isonzo (novembre 1915), quale sottocapo di Stato maggiore d’artiglieria del duca Emanuele Filiberto di Savoia (qui sviluppò i criteri per un uso principalmente offensivo dell’arma), per la sesta battaglia dell’Isonzo (agosto 1916, con promozione a colonnello) e per la decima (maggio 1917) – a seguito di una sua missione osservativa sul fronte della Somme (Fondo F1, b. 97); nel 1917-18 fu capo di Stato maggiore del V corpo d’armata sugli Altipiani e, quindi, comandante della 6ª armata, ottenendo nel luglio del 1918 la promozione a maggiore generale per merito di guerra per la ‘battaglia del solstizio’ del giugno precedente.
Il nome di Segre è principalmente legato al comando della missione viennese del 1918-22 per il rispetto delle clausole dell’armistizio del 4 novembre 1918 (Fondo E8, bb. 147, 159; Fondo E15, bb. 38, 44). Gli fu consentita una grande libertà nelle modalità d’azione e nelle scelte operative, benché le clausole del protocollo di Villa Giusti prevedessero, principalmente, smobilitazione e disarmo dell’esercito nemico, amministrazione provvisoria delle aree occupate e rimpatrio dei prigionieri italiani. Di fatto, Segre intese svolgere un’effettiva rappresentanza diplomatica, con il tentativo di salvaguardare anche gli interessi commerciali italiani sui territori ex asburgici. Incontrò, tuttavia, ostacoli e inimicizie anche da parte dei commissari politici italiani in Austria, dei colleghi militari e della stampa progressista.
Dei diversi uffici svolti dalla missione alcuni rivestono, per le loro caratteristiche di novità, un certo interesse: la composizione di un ufficio stampa efficiente e l’organizzazione di una rete territoriale di delegazioni – al fine di significare e tutelare la presenza italiana; l’istituzione, per volontà dello stesso Segre, di una commissione artistica di persone qualificate (che determinò il rientro in Italia di migliaia di preziose opere d’arte trafugate nei decenni precedenti); le iniziative umanitarie per la popolazione bisognosa viennese.
Nell’ottobre del 1919 Segre fu coinvolto in un’inchiesta governativa, alquanto torbida nei procedimenti, relativa alla missione viennese (Direzione generale personale militare, ad nomen; cfr. anche Fondo E11 – Missioni militari varie), a proposito di affari illeciti che coinvolsero interi uffici (irregolarità riconosciute dallo stesso Segre), il cui scandalo fu poi sollevato dalla stampa austriaca e italiana (dicembre 1919). Due successive inchieste amministrative nel 1920 – Segre era stato rimosso dall’incarico in gennaio – ne decisero il deferimento al magistrato penale per gravi responsabilità (Direzione generale personale militare, ad nomen, Inchiesta Meomartini) e l’arresto, nel maggio del 1921, costringendolo ad abbandonare il comando del corpo d’armata di Milano. Benché scagionato per inesistenza di reato (2 aprile 1922) – e assolto anche da un Consiglio di disciplina (maggio-giugno 1923) – la sua carriera dovette interrompersi.
Il riconoscimento del grado di maggiore generale e la piena riabilitazione da parte della commissione voluta dal ministro della Guerra Armando Diaz (giugno 1923) non fermarono le polemiche precedenti relative alle graduatorie e le richieste di riparazione avanzate da Segre (ibid., per i lusinghieri giudizi dei superiori, ma anche per i vari contenziosi relativi agli avanzamenti di carriera).
Il 23 gennaio 1924 ebbe il comando della 7ª divisione militare territoriale di Brescia; seguirono due anni di polemica con il comandante del corpo d’armata di Milano. Il 19 dicembre 1926 fu collocato a disposizione per ispezioni e, negli anni successivi, si dedicò allo studio e alle pubblicazioni, di cui la più importante resta quella sulla missione viennese.
Ancora nel 1932-33 dovette essere coinvolto in una querelle giornalistica – protrattasi fino alla sua morte – con il maresciallo d’Italia Gaetano Giardino, a proposito della paternità del successo della ‘battaglia del solstizio’.
Dopo le ultime di numerose onorificenze, nel giugno del 1934 Segre fu collocato a disposizione e, nell’aprile del 1936 – con la promozione a generale di Corpo d’armata –, in ausiliaria per età.
Morì il 22 settembre 1936, evitando – lui ma non la famiglia, costretta in seguito a lasciare l’Italia – l’oltraggio delle leggi razziali (1938).(fonte)
[5] Aldo Finzi. Nacque a Legnago (Verona) il 20 apr. 1891 da Emanuele, proprietario di un’industria molitoria a Badia Polesine, e da Rosa Roggia. Studiò al collegio “Maria Luigia” di Parma e nel 1913 intraprese l’attività politica con l’elezione al Consiglio comunale di Badia Polesine. Nel 1915 si arruolò volontario; promosso per meriti di guerra sottotenente e poi tenente, entrò a far parte della squadriglia “Serenissima”, con la quale effettuò l’8 ag. 1918 il celebre volo su Vienna guidato da G. D’Annunzio. Ottenne una medaglia d’argento al valor militare e tre encomi solenni.
Laureatosi nel 1919 in giurisprudenza all’università di Ferrara, si stabilì a Milano, dove nel gennaio 1920 aderì ai Fasci di combattimento. Legato al “Gruppo Oberdan”, fu tra i più risoluti oppositori del patto di pacificazione tra fascisti e socialisti. Nel 1921 venne eletto alla Camera dei deputati nella lista fascista per il collegio Padova-Rovigo e al suo esordio parlamentare si segnalò per un grave atto di violenza: il 13 giugno, insieme con altri deputati fascisti, aggredì e trascinò fuori da Montecitorio il deputato comunista F. Misiano. Il 3 ag. 1922 il F. fu, insieme con Cesare Rossi, alla testa delle squadre fasciste che a Milano occuparono la sede municipale di palazzo Marino.
Nel generale clima di mobilitazione che segnò la vigilia della marcia su Roma, tra gli altri, il F. e il Rossi vennero incaricati di prendere contatti con i direttori dei principali quotidiani milanesi allo scopo di indurli con le minacce a sostenere l’iniziativa dei fascisti. La sera del 28 ott. 1922 il F. si trovava presso la sede del Popolo d’Italia insieme con Mussolini, allorché questi fu informato da C.M. De Vecchi che il re offriva ai fascisti quattro ministeri in un governo presieduto da A. Salandra. Di fronte agli indugi di Mussolini, il F. si adoperò per convincerlo che non v’era altra soluzione che la richiesta dell’incarico di presidente del Consiglio. Il giorno successivo il F. accompagnò Mussolini a Roma.
Il 31 ott. 1922 il F. venne nominato sottosegretario all’Interno nel primo governo Mussolini e in tale veste ebbe anche il compito di gestire i “fondi segreti” per il finanziamento della stampa.
Installatosi al potere, Mussolini era infatti deciso ad assumere il pieno controllo dei vari segmenti del movimento fascista, che obbedivano ai ras locali e disponevano di propri organi di stampa; l’elargizione di contributi ad alcuni e non ad altri di questi giornali di provincia era appunto finalizzata a questo obiettivo. Il F. era allora all’apice della sua fortuna politica e si giovava dello stretto rapporto instaurato con Mussolini, che nel febbraio 1923 fu presente al suo matrimonio con Maria Luisa (Mimì) Clementi, nipote del cardinale S. Vannutelli (per contrarre il quale il F., di famiglia ebrea, si convertì al cattolicesimo).
Membro del Gran Consiglio del fascismo, il F. cumulò le cariche di vicecommissario per l’Aeronautica e di presidente del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).
Ripudiato l’originale radicalismo, il F. divenne un fedele esecutore della linea normalizzatrice e s’impegnò nel tentativo di inglobare nel fascismo settori del mondo cattolico, della cooperazione e del sindacalismo confederale al fine di garantire la conservazione del vecchio assetto economico e sociale.
Maturò perciò il progetto di dar vita a un quotidiano fiancheggiatore del governo che fosse in grado di competere con le maggiori testate nazionali. Ai primi del 1923 il F., insieme con C. Rossi e F. Filippelli, prese contatto con alcuni esponenti di gruppi industriali e annatoriali – Ilva, Terni, Odero, Piaggio ed Eridania – allo scopo di procurarsi i necessari finanziamenti e il 14 apr. 1923 poté essere costituita la società “La Vita d’Italia editrice del Corriere italiano.
Il F., oltre a detenere una partecipazione azionaria della società editrice, entrò a far parte con Filippelli e N. Quilici dei comitato di direzione del giornale. Alla fine di ottobre tentò di approfittare di una crisi finanziaria del giornale per diventare l’unico titolare dell’impresa, ma la manovra fallì ed egli fu costretto dal Rossi ad abbandonare la sua quota azionaria.
L’estromissione del F. si spiegava anche con il nuovo assetto politico e organizzativo del partito fascista deciso dal Gran Consiglio del 12 ott. 1923. Egli era stato la punta avanzata nella polemica revisionista ed aveva esposto il Corriere italiano agli attacchi degli esponenti del fascismo intransigente ed ancora nella citata seduta del Gran Consiglio era intervenuto a sostegno delle posizioni revisioniste di Massimo Rocca. Con l’intransigentismo occorreva fare i conti, ma non certo con una sterile e pericolosa contrapposizione frontale, come sembrò invece evocare la linea del Corriere italiano tra agosto e settembre. La liquidazione di F. rispondeva a tali esigenze, e certamente avveniva con il consenso di Mussolini.
Nonostante questa battuta d’arresto il F. restava un autorevole esponente del vertice fascista e se ne ebbe conferma nel gennaio 1924, allorché fu chiamato a far parte – insieme con C. Rossi, F. Giunta, G. Acerbo e M. Bianchi – della commissione incaricata di formare le liste dei candidati per le elezioni del 6 aprile. In questa sede il F. fece di tutto per favorire le candidature degli elementi moderati e ciò non poteva che renderlo ancora più inviso agli intransigenti. Con la sua rielezione alla Camera si compì l’ultimo atto di un’ascesa politica destinata, di lì a poco, ad interrompersi bruscamente. Il F. venne infatti coinvolto nel delitto Matteotti, anche se non si è mai pervenuti ad individuare in modo certo quale ruolo effettivo egli vi abbia svolto.
All’indomani del rapimento di G. Matteotti fu il F. a stilare la minuta della comunicazione che il 12 giugno Mussolini lesse alla Camera e quello stesso giorno partecipò a un incontro notturno presso il Viminale con C. Rossi, G. Marinelli ed E. De Bono allo scopo di concertare una comune linea di difesa. Quando però i forti sospetti che gravavano sugli ambienti della presidenza del Consiglio e del ministero dell’Interno si tradussero in esplicite accuse, Mussolini decise di sacrificare i suoi più stretti collaboratori e il F. venne indotto a dimettersi dai suoi incarichi di governo.
In una lettera del 15 giugno a G. Acerbo il F. si disse “fiero” che il suo gesto fungesse “egregiamente da diversivo” per distogliere gli attacchi dalla persona dì Mussolinì (Arch. centr. dello Stato, Giacomo Matteotti… p. 364), ma al tempo stesso sembrò avvertire iì timore di essere ucciso e volle pertanto cautelarsi facendo sapere di aver depositato in mani sicure una lettera-memoriale. Non è dato sapere quale effetto ebbero le minacce del F., ma è significativo che un ordine d’arresto nei suoi confronti, vergato da Mussolini il 16 luglio, non ebbe seguito.
Da allora la condotta del F. fu ambigua e contraddittoria: sempre fermo nell’affermare la propria estraneità al delitto, prima fece trapelare e poi ritrattò rivelazioni sul diretto coinvolgimento di Mussolini; né alla commissione del Senato incaricata dell’istruttoria a carico di E. De Bono, né al processo di Chieti nel marzo 1926 il F. portò comunque elementi di fatto decisivi per l’accertamento della verità.
Intanto il suo comportamento lo aveva posto ai margini della vita pubblica e fatto oggetto di insistenti accuse circa indebiti arricchimenti e speculazioni affaristiche. Nel 1928 il F. non venne ricandidato alla Camera e visse nell’ombra fino al 1938, allorché manifestò la propria opposizione ai provvedimenti per la difesa della razza. Il contrasto sulla politica razziale determinò nel 1942 la sua espulsione dal partito e il suo riavvicinamento alla comunità israelitica.
Durante l’occupazione tedesca il F., che viveva in una villa nei pressi di Palestrina, si adoperò per trasmettere ai partigiani informazioni sui movimenti delle truppe tedesche (il comando nazista si era insediato nella sua villa). Questa attività clandestina venne scoperta e il F., tratto in arresto, venne rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli.
Il 24 marzo 1944 fu fucilato dai nazisti nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.(fonte)
[6] Giuseppe Pennella. Nacque a Rionero in Vulture (Potenza) l’8 agosto 1864 da Antonio e Maddalena Plastino.
Entrato come allievo alla scuola militare Nunziatella di Napoli nel 1877, ne uscì nel 1881. Proseguì gli studi all’Accademia militare di Modena, fino a conseguire il grado di sottotenente nel luglio 1883. Assegnato al 22º reggimento di fanteria, fu promosso tenente nel settembre 1886; dopo essere stato comandato temporaneamente al corpo di stato maggiore, il 18 ottobre 1896 fu promosso alla guida di una compagnia dell’11° reggimento di fanteria con il grado di capitano; fu promosso successivamente allo stato maggiore dell’11º reggimento di fanteria e destinato al comando del corpo. Dopo la nomina a cavaliere della Corona d’Italia nel 1902, venne inviato come addetto al comando dell’VIII corpo d’armata nel marzo 1904.
In quel periodo la figura di Pennella si impose nel dibattito pubblico grazie alla pubblicazione di alcuni articoli e saggi che ebbero un discreto successo, come testimoniato dalle molteplici riedizioni dei suoi scritti. Si era interessato soprattutto alle questioni legate all’organica militare, da cui nacque il pamphlet intitolato La questione urgente. Il problema dei quadri nel R. Esercito italiano (Roma 1902). Successivamente si concentrò sull’istruzione e sull’addestramento della fanteria; la formazione del soldato e dell’ufficiale diventarono i temi principali delle sue trattazioni che negli anni precedenti il primo conflitto mondiale confluirono in due libri: Studio comparativo fra i regolamenti di esercizi per la fanteria in Germania, Svizzera, Italia, Francia, Russia ed Austria (Roma, 1902) e Il nuovo regolamento di esercizi per la fanteria commentato e comparato a quello finora in vigore (Roma 1905). La maggior parte delle sue opere furono stampate dalla Casa editrice italiana, editore di spessore nel panorama delle pubblicazioni militari; il che diede buona diffusione al suo pensiero fra il ristretto pubblico competente e interessato alla materia. Pennella aveva uno stile lirico nella scrittura e un gusto particolare per la poesia, che lo aiutarono a guadagnarsi le lodi di molti militari e civili.
Nel giugno 1906 la promozione a maggiore e l’assegnamento al 1° reggimento granatieri di Sardegna segnarono il primo punto di svolta nella sua carriera. Il comando della brigata dei granatieri diede un forte impulso ai suoi studi in materia di military training e di tattica, oltre che a legarlo indissolubilmente a quella specialità dell’arma di fanteria.
L’anno successivo pubblicò Saggi di tattica applicata per minori reparti delle tre armi (I-III, Roma 1907), seguito nel 1908 dal suo più importante lavoro editoriale Il vademecum dell’allievo ufficiale di complemento (Roma 1908). Questo testo fu ristampato in oltre ventuno edizioni (con circa 125 mila copie vendute) e divenne uno dei più diffusi e utilizzati per l’addestramento degli ufficiali di complemento per tutta la durata della Grande Guerra. Nel vademecum emerse il carattere conservatore della visione tattica di Pennella: secondo l’autore «la parte disciplinare è quella veramente sostanziale da cui scaturisce l’attitudine all’azione collettiva» (ibid., p. 15) e per questo l’ufficiale, soprattutto se di complemento, doveva mantenere un distacco rispetto ai soldati e pretendere assoluta ubbidienza dai propri sottoposti. Per Pennella l’impatto della tecnologia bellica e della produzione industriale era ancora minoritario in una guerra dove l’elemento morale imperava su quello materiale: nella sua concezione tattica l’assalto all’arma bianca era giustificato in quanto «la baionetta è sovratutto un’arma morale; simboleggia la ferma decisione di andare fino in fondo» (ibid., p. 19). Pennella si schierò, quindi, con la scuola ‘offensivista’, maggioritaria nell’ambiente dello stato maggiore italiano e delle altre potenze europee in quegli anni, per cui la difesa poteva essere tollerata solamente se aveva la controffensiva come «suo obbiettivo supremo e finale» (ibid., p. 24).
Dopo un periodo nel corpo di stato maggiore della divisione militare di Bari fra il 1908 e il 1911, Pennella fu promosso colonnello nel luglio 1911. Nell’aprile 1915, a ridosso dell’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa, venne nominato capo ufficio dello scacchiere occidentale presso il corpo di stato maggiore, grazie anche ad alcune ricognizioni topografiche svolte in gioventù nell’area del confine italo-francese. All’ordine di mobilitazione del 23 maggio Pennella fu richiamato presso il comando supremo, prima, in quanto responsabile dell’ufficio armate, poi, come capo ufficio del generale Luigi Cadorna nel luglio 1915. La vicinanza e il rapporto stretto con Cadorna gli permise, nel novembre dello stesso anno, di farsi assegnare come comandante della brigata granatieri di Sardegna, che mantenne, dopo essere stato promosso maggiore generale nel marzo 1916, fino al maggio 1917. In quel periodo si distinse per il comando nella battaglia di Monte Cengio, svoltasi fra il 29 maggio e il 3 giugno 1916, e nei combattimenti attorno al Lenzuolo Bianco, nei pressi di Gorizia nell’agosto dello stesso anno, dove rimase gravemente ferito al viso, perdendo l’occhio destro. Durante l’esperienza bellica al fronte Pennella mantenne una fitta corrispondenza con la moglie Elisa e le figlie Maria e Antonietta.
Sulla sua esperienza durante quella prima fase della Grande Guerra, Pennella scrisse altresì un lungo memoriale intitolato Dodici mesi al comando della brigata granatieri (Roma 1923).
Nel maggio del 1917 gli venne conferito il comando della 35ª divisione di fanteria, che combatteva al fianco delle altre truppe dell’Intesa nel Montenegro. A causa di evidenti disaccordi con il comando francese del corpo di spedizione, fu rimpatriato in Italia e, dopo la promozione a tenente generale nell’agosto 1917, fu assegnato al comando dell’XI corpo d’armata. Nel marzo 1918 fu messo al comando della 2ª armata, poi rinominata 13ª armata, e nel giugno 1918 si distinse per la difesa del Montello, durante la battaglia del Solstizio; in quello scontro Pennella e i suoi uomini riuscirono a contenere lo sfondamento dell’offensiva austro-ungarica anche a costo di notevoli perdite e di un utilizzo draconiano della disciplina. La sua fama crebbe molto per la vittoria riportata, superando i confini della penisola fino a essere indicato l’8 settembre 1918 dal quotidiano francese Le Petit Journal, assieme a Giuliano Ricci, come il vincitore della battaglia del Solstizio.
A causa di profondi dissapori con il capo di stato maggiore Armando Diaz, Pennella fu esonerato dal comando della 13ª armata e fu ricollocato alla testa del XII corpo d’armata il 25 giugno 1918. Durante l’offensiva di Vittorio Veneto Pennella e le sue truppe liberarono i paesi di Pergine Valsugana e Giavera del Montello, dove rimase forte la memoria dell’evento e dove, dopo la sua morte, fu eretta una statua in suo onore.
Nell’agosto 1919, a guerra finita, fu assegnato al comando della zona militare di Trieste e, successivamente, gli fu conferito il comando del corpo d’armata di Firenze. Nel primo dopoguerra mantenne per un periodo limitato contatti con uomini politici, tra i quali Leonida Bissolati, ma successivamente fu emarginato da Diaz e dai nuovi comandi. A causa di questo allontanamento e della conseguente marginalizzazione, la sua salute fisica deteriorò velocemente; Pennella si rinchiuse in uno stato di quasi isolamento nella sua villa di Fiesole. Per questo motivo molti dei suoi ex commilitoni lo soprannominarono ‘il generale silenzioso’.
Morì a Firenze il 15 settembre 1925.(fonte)
[7] Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta. Amedeo Umberto Lorenzo Marco Paolo Isabella Luigi Filippo Maria Giuseppe Giovanni di Savoia nacque il 21 ottobre 1898 a Torino.
I suoi genitori, sposatisi tre anni prima, erano Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta (figlio di Amedeo, re di Spagna tra il 1871 e il 1873, e di Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna) ed Elena – propr. Hélène-Louise-Françoise-Henriette – d’Orléans (figlia di Louis-Philippe-Albert d’Orléans, conte di Parigi ed erede al trono di Francia tra il 1842 e il 1848, e della cugina di questi, María Isabel d’Orléans, infanta di Spagna).
Come figlio primogenito appartenente a un ramo cadetto (i Savoia Aosta) della famiglia regnante in Italia, Amedeo avrebbe avuto un proprio ruolo dinastico solo nel caso in cui il ramo principale (i Savoia Carignano) fosse rimasto privo (com’era negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento) di un erede al trono maschio; qualunque possibile speculazione in tal senso fu però messa a tacere dalla nascita, nel settembre 1904, di Umberto di Savoia (il futuro Umberto II, il ‘re di maggio’). L’anno successivo, gli Aosta di Emanuele Filiberto traslocarono a Napoli – nel palazzo reale di Capodimonte –, quindi lontano da Torino e Roma, ovvero dalla culla della tradizione sabauda e dal centro politico della nazione.
Sin da ragazzo Amedeo crebbe in un ambiente meno rigido e soffocante di quello della corte sabauda, nonché culturalmente più aperto, grazie al profilo internazionale della madre. Si mise in evidenza per un carattere spigliato, dinamico se non proprio irrequieto, poco rispettoso delle rigide regole proprie della classe a cui apparteneva. Fu forse anche per questo che nel 1907, all’età di nove anni, fu inviato in un collegio di Londra, il St. Andrew, dove apprese a ubbidire, ma riuscì anche a formarsi una personalità indipendente; imparò inoltre a parlare in modo fluente la lingua inglese, cosa inconsueta a quel tempo non solo negli ambienti della corte sabauda ma più in generale nella classe dirigente italiana.
Una formazione militare era a quel tempo normale per un principe di casa regnante, pur se di ramo cadetto, per cui, una volta tornato in Italia, nel 1913 Amedeo – che in quegli anni, in quanto erede del ducato d’Aosta, aveva il titolo di duca delle Puglie – fu iscritto alla Scuola militare della Nunziatella, a Napoli. Per tradizione, se il figlio del re serviva in fanteria, il primogenito degli Aosta era destinato all’artiglieria.
Il 24 maggio 1915 l’Italia entrò in guerra. Il 2 giugno Amedeo, non ancora diciassettenne, fece domanda di arruolamento come soldato volontario; fu assegnato al reggimento artiglieria a cavallo (detto ‘voloire’, ‘volante’ in dialetto piemontese), e quattro giorni dopo era già in zona di guerra. Per due anni e mezzo si trovò sulla linea del fronte, nell’altopiano del Carso (monti Santo, Sabotino, Vodice, Hermada) e in quello – in generale più tranquillo dal punto di vista bellico – di Asiago (Val d’Astico, Monte Cengio); infine – dopo la rotta di Caporetto dell’ottobre-novembre 1917 – venne spostato in una zona più sicura, presso il comando dell’artiglieria del XXVII corpo d’armata, che si trovava nelle retrovie.
Nel corso del conflitto Amedeo conobbe una rapida ascesa di grado: nel 1915 passò in un solo semestre prima da soldato volontario a caporale (agosto), poi ad aspirante ufficiale (ottobre), infine a sottotenente in servizio permanente effettivo ‘per merito di guerra’ (dicembre); nel 1916 venne nominato capitano, di nuovo ‘per merito di guerra’. Guadagnò una medaglia di bronzo e una d’argento. Ma soprattutto, quando si trovava sul fronte colpì la sua tendenza, poco ‘gerarchica’, a stare con i suoi uomini del 34° reggimento di artiglieria da campagna, a mangiare assieme a loro, a partecipare con loro alle durezze della vita di trincea: insomma a condividere e non solo a comandare. Era un atteggiamento inconsueto per un ufficiale italiano di allora, e ancor più per un componente della casa regnante. Tutto ciò iniziò a creare attorno a lui un alone di leggenda.
Amedeo lasciò il teatro delle operazioni solo il 6 settembre 1919, quando i combattimenti erano ormai finiti da quasi un anno; fu quindi fra gli ultimi a essere smobilitato. Fu, quella, solo la prima delle ragioni che lo tennero lontano dal clima infuocato del dopoguerra. Il suo temperamento irrequieto, lontano dalle mondanità e poco amante delle pompe reali, non gli permetteva di restare fermo a lungo. Affascinato da tempo dai racconti dello zio Luigi – duca degli Abruzzi, ma soprattutto esploratore africano e imprenditore coloniale –, a partire dall’autunno del 1919 lo accompagnò in un lungo viaggio in Somalia. In quella colonia, e più in generale in Africa, Amedeo vedeva una possibilità di vita esotica e una frontiera di libertà (bianca) lontana dalle formalità europee e dai drammi della guerra.
Tornò in Italia nell’ottobre del 1920; a quasi ventidue anni, pur con alle spalle esperienze diverse – che lo avrebbero segnato per la vita –, non aveva ancora ottenuto la maturità scolastica. A questo fine si recò a Palermo, dove nel 1921 ottenne la licenza liceale. Proseguì poi anche gli studi militari, presso l’Accademia militare di Torino, città che amava e a partire dalla quale poté praticare alcune sue passioni, fra cui l’alpinismo, scalando, ad esempio, il Cervino e la Becca di Grain.
Scomparve quindi per più di un anno, dall’ottobre 1921 al gennaio 1923. Si seppe poi che aveva soggiornato nel Congo belga sotto una falsa identità (quella di Amedeo della Cisterna, dal cognome della nonna paterna) e come semplice lavoratore, in un’azienda di proprietà di un imprenditore inglese, conoscente della madre. Fu, dopo i combattimenti al fronte e dopo il viaggio in Somalia, un’ulteriore esperienza formativa per Amedeo, di certo assai inconsueta per un principe europeo.
Tornato di nuovo in Italia, si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza di Palermo e si laureò, piuttosto rapidamente, con una tesi in diritto coloniale, I concetti informatori dei rapporti giuridici fra gli Stati moderni e le popolazioni indigene delle loro colonie. Nella sua dissertazione, presentata il 4 dicembre 1924, auspicò che si creasse «una solidarietà di vita e di opere, un intensificarsi di cooperazione e di mutualità fra gli elementi sociali» e che l’opera di colonizzazione si risolvesse in un «organo di progresso, educando gli indigeni a bisogni sempre più elevati», dichiarandosi per «la negazione dell’asservimento degli indigeni e dello sfruttamento egoistico del loro territorio».
Tra l’ottobre del 1925 e il gennaio del 1931 Amedeo prese parte, con il grado di tenente colonnello, alla fase finale delle operazioni di ‘riconquista’ della Libia da parte delle truppe italiane (nell’ottobre 1912 – quando, dopo la guerra contro la Turchia, il trattato di Losanna aveva assegnato il Paese all’Italia – solo una parte del Paese era effettivamente occupata). In quegli anni Amedeo alternò semestri sul teatro di operazione e (a partire dall’aprile 1926) semestri di presenza alla Scuola di guerra di Torino (era intanto passato dall’artiglieria alla fanteria), allo scopo di completare gli studi militari, indispensabili per ulteriori avanzamenti di carriera. In Libia venne assegnato ai reparti indigeni ‘meharisti’ (cioè montati su dromedari) e operò fra Buerat el-Hsun, nella Gran Sirte, a Mizda, nel Fezzan, da Zella a Nufilia, da Tagrift a Murzuk, sino a partecipare all’occupazione dell’oasi di Cufra (gennaio 1931); fu grazie a queste operazioni che guadagnò l’appellativo di ‘principe sahariano’.
Negli stessi anni frenetici di impegno, non pago di essere buon cavaliere, nuotatore, schermitore, alpinista ecc., Amedeo si dedicò anche al volo. Se nel luglio 1926 già aveva ottenuto il brevetto di pilota, fra il 1928 e il 1931 ottenne le specializzazioni come pilota di aerei militari di vario tipo (Fiat CR.20, 30 e 32, IMAM Ro.1, 37 e 41, Savoia-Marchetti SM.79 e 81, Piaggio P.32, Caproni AP.1 e altri ancora). Artigliere, soldato coloniale, adesso pilota, Amedeo poteva rappresentare in quegli anni l’icona di un vitalismo modernista e militare.
Fu in questo periodo di alternanza fra la Libia e l’Italia che Amedeo conobbe la cugina Anna d’Orléans (nata nel 1926), con la quale si sposò a Napoli il 5 novembre 1927 e dalla quale avrebbe avuto le figlie Margherita (1930) e Maria Cristina (1933).
Intanto, dopo essere stato promosso colonnello (1928), nel marzo 1929 terminò i suoi studi alla Scuola di guerra di Torino – iniziati, come detto, nell’aprile 1926 –, che volle completare (una sua vecchia passione) con corsi alla Scuola di guerra marittima (1929) e all’Istituto di cultura superiore aeronautica (1932).
Nel gennaio 1931 – stroncata la resistenza libica nella regione della Cirenaica – anche per Amedeo finì, come detto, il periodo delle operazioni in Libia. Tornò definitivamente in Italia, dove dal 12 febbraio fu al comando del 23° reggimento artiglieria da campagna, avente sede a Trieste; lo si volle infatti tenere lontano tanto dai Savoia quanto dal regime. Pochi mesi più tardi, il 4 luglio, morì suo padre, Emanuele Filiberto, e Amedeo ereditò il titolo di duca d’Aosta.
A Trieste Amedeo si stabilì, insieme alla moglie, nel castello di Miramare, dove risiedette stabilmente per più di sei anni, dall’aprile 1931 al novembre 1937. Furono anni di quiete borghese, che però gli servirono per praticare la passione del volo. Dalla fanteria ottenne infatti di passare all’aeronautica, allora diretta da Italo Balbo, che il 2 maggio 1932 gli affidò il comando di uno stormo da ricognizione terrestre (il 21°) e poi da caccia, e negli anni seguenti gli permise di effettuare una rapidissima carriera (generale di brigata comandante la III brigata aerea nel 1934, generale di divisione aerea comandante la I divisione Aquila di Gorizia nel 1936, e infine, nel dicembre del 1937, generale di squadra aerea). Di questo periodo triestino si ricorda una sua visita in Germania alla fine del 1936, nel corso della quale incontrò Hermann Goering e Adolf Hitler; a un’esternazione di quest’ultimo sui programmi espansionistici del Reich e del regime nazista, sembra abbia risposto ambiguamente che secondo lui il fascismo e il nazismo non erano merci da esportazione.
Mentre Amedeo volava, nel 1935-36 il regime fascista aveva occupato l’Etiopia e ‘rifondato’ l’Impero. A metà del 1937 Benito Mussolini giunse alla conclusione di dover sostituire il generale Rodolfo Graziani nell’incarico di governatore generale e viceré dell’Etiopia. Ma con chi? Chi poteva in Italia fare il viceré?
Probabilmente all’interno del ministero delle Colonie nacque l’idea di chiedere al duca d’Aosta di rendersi disponibile per l’incarico. I vari pretendenti alla carica, si pensava, non avrebbero potuto opporsi alla nomina di un componente della famiglia regnante. Inoltre il suo nome poteva andar bene anche a chi non voleva che in Etiopia cambiasse niente, poiché si supponeva che Amedeo – per carattere e per mancanza di formazione specifica – si sarebbe limitato a fare il ‘re travicello’. Come scrisse un suo biografo: «Come se la sarebbe cavata il Duca d’Aosta, bravo soldato sia pure, simpatico giovinotto, ma non esperto in affari politici e tanto meno amministrativi?» (Valori, in Amedeo duca d’Aosta, 1954, p. 59). Amedeo, cosa per certi versi sorprendente, accettò. Prevalse in lui, forse, la nota passione per l’Africa, anche se la sua assoluta mancanza di esperienza dirigenziale e amministrativa lo rendeva oggettivamente ostaggio della burocrazia coloniale e del governo di Roma.
Un’intelligente propaganda, che aveva alcune basi nella realtà, tese immediatamente a distinguere il passato di Graziani dal presente di Amedeo, presentato come epitome del buon padre coloniale, sollecito sostenitore degli interessi dei sudditi indigeni: non v’è dubbio che molte delle intenzioni del nuovo viceré andavano in questo senso, ma la loro concreta applicazione dev’essere valutata con attenzione dallo storico.
In alcuni punti Amedeo seppe imporsi: ad esempio congedando definitivamente Graziani, che avrebbe voluto rimanere con la carica di comandante supremo delle forze armate dell’Africa orientale. Invece in altri punti non poté (o non seppe, o non volle) imporsi. Non vi riuscì, ad esempio, quando Roma gli inviò, proprio per la carica di comandante militare, il generale Luigi Cavallero, che, come Amedeo poté constatare, compiva spesso scelte diverse dalle sue. Per certi aspetti, Amedeo fu aiutato dalla prosecuzione dell’enorme flusso di finanziamenti che il regime continuò a indirizzare, per motivi di prestigio, verso la nuova colonia. Ma certo era difficile passare dalla politica di dominio diretto ed esclusivo da parte degli italiani voluta da Mussolini e da Graziani alla politica di collaborazione paternalistica che Amedeo aveva sognato nella sua tesi di laurea, e che pure per certi versi cercò di mettere in pratica. Su alcuni punti, infine, almeno a quanto oggi è noto, Amedeo semplicemente tacque: fu infatti proprio durante il suo periodo di governo che l’Italia fascista inaugurò la legislazione razziale coloniale, decretata (com’è noto) l’anno precedente a quello che vide il regime avviare la legislazione antisemita.
In realtà Amedeo fu sostanzialmente una vittima, sia pur partecipe, di quella politica del regime che accettando la carica di viceré aveva – forse generosamente e ingenuamente – pensato di poter cambiare. Insediatosi come governatore generale e viceré d’Etiopia il 21 dicembre 1937 – quando già da oltre un anno il regime si era formalmente legato al Reich nell’asse Roma-Berlino –, Amedeo assistette con crescente preoccupazione alla deriva che portava l’Europa in guerra.
Accadde esattamente ciò che aveva temuto. Il 10 giugno 1940 l’Italia fascista entrò in guerra a fianco di Hitler; lo stesso giorno Amedeo venne nominato addirittura generale designato d’armata aerea. Dopo alcuni (ingannevoli) primi successi locali italiani, l’Africa orientale fu il primo territorio attaccato dalle forze del Commonwealth britannico, e il primo lembo di suolo ‘italiano’ (coloniale) a essere perso, alla fine del novembre 1941. Nella disfatta, attorno ad Amedeo fu cucito l’alone di eroe: ‘l’eroe dell’Amba Alagi’ (il massiccio montano dell’Etiopia settentrionale dove resistette, accerchiato con i suoi uomini da soverchianti forze britanniche, per quattro settimane, nell’aprile-maggio 1941).
In precedenza Amedeo aveva compiuto un’altra scelta, a suo modo eroica ma anche tragica e meno nota. A quanto pare, il generale Gustavo Pesenti – comandante del settore del fiume Giuba (al confine con la colonia britannica del Kenya) – nel dicembre del 1940 avrebbe chiesto ad Amedeo di ammettere l’impossibilità di una vittoria militare italiana in Africa e di proporre quindi ai britannici una pace separata che sola, secondo lui, avrebbe salvato l’Impero – e forse l’Italia – da una guerra (Del Boca, 1982, rist. 2001, p. 392). Amedeo avrebbe rifiutato: non poteva pensare di tradire il suo re e Mussolini con una scelta che non gli pareva adatta a un duca d’Aosta. Ciò detto, pur sapendo di non avere speranza alcuna di ricevere aiuti dall’Italia, Amedeo, assunto il comando delle forze armate della colonia, dopo il citato, breve periodo di limitate offensive, comandò la più stretta difensiva. Battute ovunque le sue truppe, ordinò ai pochi uomini rimasti di effettuare una difesa estrema in due ‘ridotti’, a Gondar e all’Amba Alagi, nel tentativo di impegnare il maggior numero possibile di forze avversarie e di impedire che fossero portate sull’altro fronte africano dell’Italia fascista, quello fra la Libia e l’Egitto. La vittoria britannica in Africa orientale era data per scontata, ma si cercava almeno di rallentarla. Scarsa soddisfazione gli diede intanto la promozione a generale d’armata, il 12 febbraio 1941. L’Amba Alagi cadde solo il 18 maggio 1941; dopo aver rifiutato più volte la resa, alla fine Amedeo l’accettò, ma ottenne dagli avversari l’onore delle armi (e dopo la resa rifiutò di fuggire, in occasione di quello che forse fu un momento di distrazione dei suoi catturatori), mentre il ridotto di Gondar, comandato dal generale Guglielmo Nasi, cadde solo in novembre. A quel punto, anche formalmente l’Africa orientale era persa.
Come già per i soldati dell’Africa orientale, e per non pochi civili, anche per Amedeo si aprirono le porte dei campi di prigionia. Egli era ora un ostaggio importante in mano al governo di Londra, dove pure qualcuno cominciò a illudersi di poterlo utilizzare in futuro come sostituto del re Vittorio Emanuele III. La sua non fu una prigionia dorata, e Amedeo rimase – pur se in una casetta tutta per lui – nel campo di Donyo Sabouk in Kenya, assieme ad altri prigionieri italiani, condividendone non poche sofferenze e disagi.
Purtroppo la zona del campo era malarica e questo favorì il reinsorgere in lui di questa malattia – contratta in precedenza –, combinata con il tifo. Assieme alle molte privazioni connaturate alla prigionia, essa creò complicazioni e un repentino aggravamento del quadro clinico che, dopo un ricovero forse non tempestivo (e che comunque, anche se lo fosse stato, difficilmente avrebbe potuto mutare il decorso generale), il 3 marzo 1942 portò alla morte il nemmeno quarantaquattrenne Amedeo di Savoia. Fu sepolto nel cimitero militare italiano di Nyeri, in Kenya, accanto ai suoi soldati.
La morte di un principe della casa regnante, sia pure di un ramo cadetto, non era vicenda da passare sotto silenzio. La propaganda del regime accusò la Gran Bretagna di barbarie, la pubblicistica militare incensò ‘l’eroe dell’Amba Alagi’, e i circoli più vicini agli Aosta – e gli ambienti più sensibili al mito coloniale – misero da parte l’icona (guerresca ed esotica) del ‘principe sahariano’ per porre l’accento su quella del colonialista moderato, ‘buono’. Come in tutti i miti, anche in questo c’erano aspetti veri, ma nel complesso si trattava di un mito falso, o falsificabile: in fin dei conti, Amedeo aveva partecipato alle campagne di riconquista della Libia, aveva aiutato il fascismo accettando la carica di viceré di Etiopia, aveva taciuto sulla legislazione razzista coloniale, e non aveva voluto passare dalla parte delle potenze antifasciste, decidendo di combattere sino in fondo la guerra promossa dal fascismo.
Scrisse di lui un biografo parole che dovrebbero essere meditate: «Il duca Amedeo non aveva un temperamento politico; egli era essenzialmente un uomo d’azione. Nel fascismo egli vide, come tanti altri, il lato patriottico, il mezzo per dare al Paese una disciplina che ne facesse un blocco d’un ideale di grandezza. A tale scopo appariva ragionevole sacrificare anche un poco di libertà» (Valori, in Villa Santa et al., 1954, p. 99).
Certo, aveva compiuto molte delle sue scelte conservando un profilo autonomo, aperto, inconsueto per un Savoia, e per molti versi irriducibile al regime per il quale poi sino alla fine combatté: in questo sta il suo dramma personale, la tragicità della sua vicenda. Una vicenda che per essere conosciuta per intero, però, dovrebbe essere studiata sulle fonti originali di Casa Savoia Aosta, e in particolare sul diario che da più parti si dice Amedeo abbia tenuto, sin da giovanissimo, praticamente per tutta la vita: testo di cui sono state pubblicate alcune pagine, ma in sedi né scientifiche né affidabili. Il diario potrebbe forse trovarsi negli archivi dei suoi eredi, i quali – se questa ipotesi è giusta – sino a oggi non l’hanno mai divulgato, agendo quindi – se, ripetiamo, tale ipotesi fosse confermata – come i principali nemici della memoria e di una giusta considerazione del loro avo.(fonte)
[8] Svetozar Boroević. Feldmaresciallo austriaco, nato a Umetic (Croazia) il 13 dicembre 1856, morto il 13 maggio 1920 a Klagenfurt. Comandante il VI corpo d’armata, si segnalò nella battaglia di Komarów (29 e 30 agosto 1914), ove fu sconfitta la V armata russa, e il 4 settembre fu nominato comandante della III armata. Alla testa di tale grande unità partecipò alla battaglia di Leopoli, la quale, malgrado i successi locali conseguiti dal B., terminò con la ritirata dell’esercito austroungarico (11 settembre), che abbandonò ai Russi circa centomila prigionieri e tutta la Galizia. L’armata del B. nell’autunno del 1914 fu destinata alla difesa dei Carpazî. Nella battaglia di Limanowa (dicembre 1914), nella quale i Russi dopo lunga lotta furono arrestati nella loro avanzata minacciosa verso la Slesia, il B. avrebbe dovuto, scendendo dai monti, attaccare sul fianco sinistro i Russi e produrre la decisione, ma dopo qualche successo, nuovi rinforzi giunti all’avversario costrinsero (Natale 1914) il B. a ritirarsí dopo aspri combattimenti presso Jasło, sino alla cresta dei Carpazî, che difese con grande tenacia. Di fronte agli attacchi ostinati dei Russi il B. seppe cedere poco terreno, senza compromettere la solidità della difesa.
Le forze del B. in unione alla II armata tentarono invano nel marzo di liberare il campo trincerato di Przemysł che il 22 marzo dovette arrendersi. Con le forze rese cosị disponibili i Russi rinnovarono persistenti e sanguinosi attacchi specialmente contro il centro e la destra delle truppe del B., talchḫ fu necessario inviare in rinforzo il corpo d’armata tedesco detto dei Beschidi, con l’aiuto del quale i Russi vennero respinti.
Dopo la battaglia di Gorlice (2 maggio 1915) i Russi furono costretti alla ritirata e l’armata del B. passn̄ all’offensiva contro l’avversario che ripiegava sull’intera fronte. Il 27 maggio 1915 al B. venne affidato il comando della nuova V armata destinata allo scacchiere italiano per la difesa della fronte dal Monte Nero al mare. Da allora il B. rimase nel teatro d’operazioni italiano. La V armata prese dal gennaio 1916 il nome di armata dell’Isonzo; il 23 agosto 1917 essa fu divisa in due armate, la I e II armata dell’Isonzo, le quali costituirono il gruppo d’armata Boroević.
Il B. diresse tutte le operazioni alla fronte giulia: egli ebbe quindi parte preminente nella tenace difesa che l’esercito imperiale oppose alle nostre offensive durante gli anni 1915-16-17: nonostante però il valore delle truppe e l’abilità dei capi e i continui rinforzi tratti dalla fronte russa, la nostra azione poderosa aveva portato l’esercito austriaco vicino allo sfacelo, tanto che l’Austria fu costretta a ricorrere alla Germania, la quale inviò alla fronte giulia un’armata per effettuare l’offensiva di Caporetto. In questa operazione si verificarono fra l’armata di destra del B. e le truppe vicine attriti e contrattempi che diedero motivo a gravi accuse da parte degli avversarî del B. Il generale di fanteria Alfredo Krauss, che fu capo di Stato maggiore delle forze austriache alla fronte italiana e che comandò durante l’offensiva di Caporetto il I corpo d’armata austriaco alla dipendenza della XIV armata tedesca (conca di Plezzo), nella sua opera Die Ursachen unserer Niederlage afferma che il B. rimase troppo lontano dalle truppe operanti e che egli con inopportuni ordini motivati da invidia “salvò la III armata italiana”. Il generale austriaco soggiunge che la limitata capacità del B. era ben nota nell’esercito ed anche al comando supremo. Tali aspri giudizî sono un’eco evidente degli attriti esistenti nell’esercito austriaco fra comandanti di differenti nazionalità.
Raggiunto il Piave e partita la XIV armata germanica, la fronte dal mare al Grappa fu affidata al B. (nel febbraio promosso feldmaresciallo), mentre la fronte montana era affidata al Conrad. Nell’offensiva del giugno, secondo il primitivo disegno d’operazione, l’attacco decisivo avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente dal Conrad, mentre un compito soltanto dimostrativo era affidato al gruppo B. Questi avrebbe preferito non dare battaglia, per conservare le forze intatte in vista di una prossima pace; ma, come afferma il generale tedesco Cramon (allora addetto al Comando supremo austro-ungarico) nel suo libro Unser österreichisch–ungarischer Bundesgenosse, il B. non era un uomo da accontentarsi, una volta decisa l’offensiva, d’incarichi secondarî. In tal modo l’attacco, diluito pressoché sull’intera fronte, perdette di vigore e naufragò miseramente. Tuttavia, mentre l’offensiva del Conrad fu stroncata sin dal primo giorno, le truppe del B. riuscirono a passare il Piave e a mantenervisi, sia pure in ristretto spazio, per alcuni giorni; ma il 20 giugno, cioè cinque giorni dopo l’inizio dell’offensiva, il B. dichiarò esplicitamente al Comando supremo che, se si voleva evitare una catastrofe, occorreva ritirare le truppe sulla sinistra del Piave. Dopo una giornata di esitazioni dovute a motivi politici, l’imperatore si piegò alle ragioni militari del B.
L’attacco italiano dell’ottobre 1918 fu da principio diretto contro il gruppo dell’esercito Boroević, prima sul Grappa, dove le truppe imperiali opposero accanita ed efficace resistenza, poi sul Piave. Ma dopo che le forze nostre ebbero guadagnato a viva forza il passaggio del fiume, l’esercito, seguendo l’esempio del paese, incominciò a sconnettersi, e il maresciallo dovette assistere impotente alla ritirata e alla dissoluzione dell’esercito imperiale.
Il B., generale stimato in pace per la sua elevata capacità, si era dimostrato a Komarów comandante di corpo d’armata prudente e nello stesso tempo energico e tenace. Il suo ordine del giorno nell’assumere il comando dell’armata incomincia: “Soldati, io vengo a voi come vincitore…” In realtà il B. d’allora in poi non conobbe più la vittoria vera, perché le sue azioni fortunate furono riflesso di successi altrui. È però certo ch’egli mostrò, sia sui Carpazî sia sull’Isonzo, fermezza ed energia non comuni, non mai smentite durante oltre quattro anni di guerra.(fonte)
[9] Enrico Caviglia. Nato a Finale Ligure (allora Finalmarina), in provincia di Savona, il 4 maggio 1862 da Pietro e da Antonina Saccone in una famiglia di naviganti e commercianti di media fortuna, fu allievo del Collegio militare di Milano e poi dell’Accademia militare di Torino. Tenente di artiglieria nel 20 reggimento nel 1884, fu in Eritrea nel 1888-89; frequentò quindi la scuola di artiglieria entrando nel corpo di Stato Maggiore come capitano. All’inizio del 1896 ottenne di essere nuovamente destinato in Eritrea, dove raggiunse il comando del gen. O. Baratieri il 28 febbraio e assisté alla battaglia di Adua il 1° marzo; con un tratto caratteristico del suo fiero carattere, per essere scampato al disastro chiese di essere sottoposto a un’inchiesta che lo liberò da ogni ombra di addebito. Rimase in Afirica nel 1896-97, distinguendosi nell’operazione contro i dervisci sudanesi, poi, tornato in Italia, fu addetto al comando di divisione di Catanzaro. Qui si occupò nel tempo libero di arte (pubblicò nella Rassegna d’arte di C. Ricci, III, [1903], pp. 51-57 e 189 s., due articoli su La Roccella del vescovo di Squillace), e dei problemi della regione calabrese analizzando sulla Nuova Antologia (1° ott. 1905, pp. 449 ss.) la situazione disperata dei contadini e la degradazione progressiva del territorio, chiedendo l’esproprio dei latifondisti assenteisti, la sistemazione delle pendici boscose e dei corsi d’acqua, la bonifica delle zone paludose e malariche.
Maggiore nel 1901, l’anno seguente fu nominato addetto militare straordinario a Tokio con l’incarico di seguire gli sviluppi della guerra russo-giapponese in Manciuria. Dal 1905 al 1911 fu addetto militare a Tokio e Pechino, approfittando dell’occasione per studiare le civiltà dell’Estremo Oriente e conoscere popoli e regioni; rientrò in Italia attraversando a cavallo l’Asia dalla Cina al Mar Nero, con un’impresa sportiva degna di nota, e condensò poi la conoscenza della civiltà asiatica in diversi articoli per la Nuova Antologia (16 luglio 1910, pp. 348 ss.; 16 giugno 1912, pp. 633 s.; 1° ag. 1912, pp. 432 s.), oltre che nelle relazioni allo Stato Maggiore. Fu quindi addetto al comando del X corpo d’armata di Napoli (era tenente colonnello dal 1908) e nel 1912 fu in Libia, collaborando al Corriere della sera con articoli sulla costituzione geologica della costa tripolina, sulle acque del sottosuolo e sull’avvenire agricolo della regione costiera. Venne poi destinato all’Istituto geografico militare di Firenze, di cui divenne direttore in seconda nel 1914, dopo la promozione a colonnello. Maggior generale nell’estate 1915, assunse il comando della brigata “Bari” impegnata sul Carso nei combattimenti di Bosco Lancia e Bosco Cappuccio. Iniziava così la sua rapida ascesa ai più alti comandi, compiuta tutta alla testa di unità di prima linea, senza la relativa sicurezza degli Stati Maggiori.
Durante settantacinque giorni consecutivi, nell’autunno 1915, il C. condusse la sua brigata nei disperati combattimenti del Carso, perdendo 6.500 uomini (più di quanti ne aveva all’inizio). Sin dal primo momento confermò quel suo rigido senso del dovere, che fece sì che comandasse assalti sanguinosi senza prospettiva di successo, e lo stimolò, alla continua ricerca di grandi e piccoli miglioramenti tattici che dessero la possibilità di guadagni anche limitati e permettessero di risparmiare la vita dei soldati, per i quali ebbe sempre un profondo rispetto e attaccamento. Nella riorganizzazione dell’esercito della primavera 1916 ebbe il comando della 29ª divisione, con la quale lasciò nel giugno il fronte dell’Isonzo per concorrere a fermare l’offensiva austriaca dal Trentino. Il suo comportamento gli valse allora la nomina a cavaliere dell’Ordine militare di Savoia. Rimase sull’altopiano di Asiago fino al giugno 1917, prendendo parte anche alla battaglia dell’Ortigara di cui pure aveva decisamente criticato l’impostazione.
Nel luglio 1917 ricevette il comando del XXIV corpo d’armata schierato lungo l’Isonzo, che con le divisioni 47ª e 60ª doveva passare di forza il fiume e penetrare sull’altopiano della Bainsizza nel quadro di quella che fu detta l’undicesima battaglia dell’Isonzo. Una preparazione accurata e lo sfruttamento della sorpresa permisero al XXIV corpo di passare il fiume, la mattina del 19 agosto con parte delle truppe, poi, dopo una prima manovra di fianco che spazzò via la difesa austriaca, il 20 con le altre forze, dando inizio a una rapida penetrazione nell’interno Una nuova manovra laterale ampliò lo sfondamento, provocò la caduta del monte Oscendrik e aprì la via al II corpo d’armata schierato più a sud. Il 22 agosto cadde anche lo Jelenik e dinanzi al XXIV corpo si creò un vuoto nello schieramento austriaco. La mancanza di riserve fresche (L. Cadorna e L. Capello non avevano previsto un così netto successo) impedì lo sfruttamento strategico del vantaggio e diede agli Austriaci il tempo di ricostituire la loro linea. Tra il 25 e il 28 agosto la spinta delle truppe del C. si esaurì al vallone di Chiapovano: non si era avuta la rottura del fronte austriaco, ma un notevole successo tattico, evidenziato da guadagni territoriali insolitamente ampi e dal rapporto tra le perdite del XXIV corpo (6.400 tra morti, feriti e dispersi, su una forza di quasi 100.000 uomini) e quelle inflitte agli Austriaci (11.000 prigionieri e 150 cannoni, oltre ai morti e feriti). Si trattava della maggior vittoria italiana del 1917, forse la più interessante fra tutte quelle italiane per l’uso della sorpresa e della manovra su scala inusuale nella guerra di trincea.
Dopo la battaglia il XXIV corpo, su tre divisioni, rimase sulla Bainsizza a presidiare il terreno conquistato, avendo alla sua sinistra il XXVII corpo di P. Badoglio. Il 24 ott. 1917 la grande offensiva austro-tedesca investì marginalmente le truppe del C., che respinsero facilmente gli attacchi, e travolse la 19ª divisione di Badoglio, schierata dinanzi a Tolmino, dilagando su Caporetto e oltre la testata dello Judrio. La sera dello stesso giorno il comando della 2ª armata affidò al C. la responsabilità delle tre superstiti divisioni di Badoglio e gli ordinò di iniziare il ripiegamento dalla Bainsizza. Lo sgombero dell’altopiano, condotto sotto la pressione nemica, diede luogo a dolorose perdite e sbandamenti. Il C. riuscì però a salvare il grosso delle sue truppe, nonché altre affidategli nel corso della ritirata, schierandosi il 31 ottobre sul Tagliamento con otto divisioni e portandole tutte sul Piave il 6 novembre ancora in buona efficienza. Il suo comportamento in quei giorni gli valse una medaglia d’argento con una lusinghiera motivazione; ma il 22 novembre, nel corso del riordinamento dell’esercito, con grande amarezza del C., il XXIV corpo venne sciolto. Il provvedimento fu da lui interpretato come una ritorsione di Badoglio, che avrebbe approfittato della nomina a sottocapo di Stato Maggiore dell’esercito per conservare in vita il suo XXVII corpo, travolto e disfatto, sacrificando invece il XXIV, che ne aveva assorbito forze e compiti. L’episodio inasprì la rivalità tra i due generali, che avrebbe avuto maggiori ripercussioni negli anni seguenti.
Il C. ebbe il comando dell’VIII corpo d’armata sul Piave, poi, dal, febbraio al giugno 1918, del X corpo della 1ª armata sull’Astico. Il 15 giugno 1918 l’intervento dell’artiglieria del suo corpo permise al contiguo corpo d’armata inglese della 6ª armata di respingere l’attacco austriaco. Subito dopo il C. fu destinato a sostituire il gen. G. Pennella alla testa dell’8ª armata sul Piave, che non aveva retto all’offensiva austriaca, e si diede a riordinare truppe e comandi. Si palesava intanto la crisi degli Imperi centrali e il governo italiano, fino allora sostenitore della difensiva a oltranza, cominciava a chiedere al gen. A. Diaz un’offensiva risolutrice prima dell’inverno. A fine settembre il col. U. Cavallero, capo dell’ufficio operazioni del Comando Supremo, stese per Diaz e Badoglio il piano di un’offensiva dell’8ª armata. Il C. lo approvò, ma chiese e ottenne l’ampliamento del fronte d’attacco fino ai ponti di Vidor a nord e alle Grave di Papadopoli a sud, per sfruttare la prevista superiorità di forze con una molteplicità di tentativi, tenendo conto delle difficoltà create dalle prossime piene autunnali. Complessivamente erano disponibili per l’offensiva 23 divisioni di fanteria e 4 di cavalleria, ripartite in tre armate (la 12ª sotto comando francese, la 10ª sotto comando inglese e l’8ª che avrebbe avuto il ruolo maggiore), inizialmente sotto il comando unico di Caviglia. Restava da prendere la decisione finale dell’offensiva; il precipitare degli avvenimenti sul fronte francese, la crisi ormai palese dell’Austria-Ungheria e l’insistenza di V. E. Orlando decisero Diaz e Badoglio ad attaccare.
La battaglia, che avrebbe preso il nome di Vittorio Veneto, iniziò il 24 ott. 1919 con attacchi infruttuosi della 4ª armata sul Grappa. La piena del Piave costrinse a rinviare il gittamento dei ponti alla notte tra il 26 e il 27, e poi spazzò via la maggior parte di quelli costituiti, isolando le teste di ponte di Pederobba e di Semaglia. Il C. spostò allora le sue riserve a sud, le fece passare sui ponti delle Grave di Papadopoli, e risalire a nord il 28, provocando il crollo del dispositivo di difesa austriaco. Il 29 ottobre l’8ª armata passò in forze il Piave e penetrò in profondità realizzando una rottura Strategica, facilitata dalla crisi morale e politica delle unità austro-ungariche. Lo stesso giorno il comando nemico chiese di aprire le trattative di resa, prolungate poi sino a permettere alle truppe italiane di arrivare a Trento e Trieste. La vittoria era stata certamente permessa dalla netta superiorità italiana di mezzi e ingrandita dalla progressiva disgregazione dell’esercito nemico; non era però piccolo merito per il C. averla perseguita con ampiezza di vedute e fermezza.
Cavaliere di gran croce dell’Ordine di Savoia, senatore, tenente generale con rango di comandante d’armata e poi nel novembre 1919 generale d’esercito (il massimo grado della gerarchia militare), nel dopoguerra il C. si trovò a far parte del ristretto gruppo dei “generali della vittoria”, proiettati sulla scena politica con un prestigio e un peso che le forze politiche non potevano trascurare. Le grandi responsabilità avute durante la guerra gli davano la certezza di dover chiedere e ottenere un ruolo di primo piano nella vita nazionale anche in tempo di pace. Ma la sua capacità e cultura politica (come traspare da numerosi discorsi e proclami del 1918-19, tra cui il Discorso di Finalmarina tenuto il 20 sett. 1919 e pubblicato in opuscolo lo stesso anno a Milano) goverano tuttavia pari alla ricchezza di altri suoi interessi culturali.
Un forte paternalismo genericamente populista, che nasceva da un giusto rispetto per il valore delle truppe (ma non gli impediva di biasimare duramente le “abitudini spenderecce” contratte dagli operai grazie ai salari di guerra, e i miglioramenti nell’alimentazione dei contadini), si accompagnava a un giudizio sprezzante sulla classe dirigente, nei suoi circoli politici come in quelli economici. Solo la media e piccola borghesia, che aveva sofferto e pagato in guerra, e i giovani ufficiali, che ne erano la migliore espressione, aprivano alla speranza il cuore del C., più volte tentato dall’idea di proporsi loro come capo per rinnovare il paese, ma raffrenato dalla sua ripugnanza per la politica organizzata. Questa ripugnanza si estendeva anche all’estremismo nazionalista emergente, di cui biasimava gli slanci di rivolta; il rispetto e l’obbedienza per l’autorità costituita, anche se non stimata. erano infatti per il C. un dogma irrinunciabile. Ciò finiva col fare di lui un isolato, incapace com’era di sviluppare una linea politica che andasse oltre un nobile moralismo, e sempre pronto al richiamo all’ordine da parte delle autorità riconosciute.
Il 18 genn. 1919, in occasione di un rimpasto del governo Orlando, il C. fu nominato ministro della Guerra, col compito di impostare un programma di smobilitazione che contemperasse le esigenze della politica, dell’economia e del popolo stanco di guerra. Seppe pubblicizzare abilmente i provvedimenti decisi a favore dei congedati, e occuparsi attivamente degli ufficiali di, complemento cui riservò un trattamento privilegiato (indennità di congedamento, mantenimento in servizio a domanda, avvicinamento alla sede per professionisti e studenti universitari). Dinanzi allo sfavorevole andamento delle trattative di Parigi si assunse la grave responsabilità di arrestare la smobilitazione: due milioni di uomini alle armi sembravano necessari per sostenere Ierichieste di V. E. Orlando.e di G. S. Sonnino. Alla fine di giugno, quando F. S. Nitti successe a Orlando, la spesa mensile per l’esercito era salita a due miliardi (contro i 1.400 milioni di lire dell’autunno 1918) e tutto il paese chiedeva che la smobilitazione fosse portata avanti con decisione. Nitti trattò direttamente con Diaz e Badoglio, li trovò favorevoli a una politica di normalizzazione ed economie, e concordò con essi la sostituzione del C. con il gen. A. Albricci.
Sei mesi più tardi fu Diaz a fare a Nitti il nome del C. per comandare le truppe che fronteggiavano la sedizione dannunziana di Fiume, dovendo Badoglio, che aveva assolto questo incarico fino allora, rientrare a Roma perché nominato capo di Stato Maggiore dell’esercito. Il 21 dic. 1919 il C. assunse i poteri di commissario straordinario per la Venezia Giulia e il comando dell’8° armata, e si diede subito a riordinare le truppe, la cui disciplina lasciava a desiderare. Provvide poi a introdurre nelle relazioni con G. D’Annunzio una nuova fermezza, diminuendo al medesimo tempo la tensione al confine italo-iugoslavo con la parziale smobilitazione dell’8ª armata. Nel novembre 1920, quando il governo Giolitti firmò con gli Iugoslavi il trattato di Rapallo che risolveva la questione di Fiume, il C. poteva garantire di avere in pugno la situazione; e infatti condusse a termine lo sgombero dei dannunziani con prudente efficienza e minimi incidenti negli ultimi giorni di dicembre. Il suo comportamento permise al paese e all’esercito di chiudere senza lacerazioni una brutta crisi; tuttavia le clamorose proteste dell’estremismo nazionalista (che giunse ad accusarlo di un “Natale di sangue”) e le reazioni di molti gruppi di ex combattenti indussero il C. a prendere le distanze dalla politica di Giolitti, con un inabile e ingeneroso tentativo di scindere le sue responsabilità.
Il 17 luglio 1921 disse infatti in Senato di aver marciato contro D’Annunzio solo perché ingannato dal governo sulla reale portata delle concessioni territoriali alla Iugoslavia, parlò di una vera “beffa all’americana” e confessò di aver portato a Fiume “un’aspide” anziché un accordo vantaggioso. Era un rovesciamento di posizioni troppo brusco per essere credibile, che dimostrava con quale incertezza il C. si muovesse sulla scena politica; il risultato infatti fu di marcare il suo isolamento. Negli anni successivi la parte da lui avuta nella repressione dell’avventura fu progressivamente dimenticata; il fascismo però vietò nel 1925 la pubblicazione di un suo volume di memorie e documenti su Il conflitto di Fiume (che fu poi ampiamente rimaneggiato nel 1936 e dato alle stampe dagli eredi a Milano nel 1948).
Dal 1921 al 1925, come comandante designato di una delle quattro armate e membro del Consiglio dell’esercito (l’organo che in quel periodo costituiva il vertice decisionale dell’apparato militare), il C. ebbe una responsabilità di primissimo piano nella politica militare italiana. Non prese parte attiva al dibattito sulla riorganizzazione delle forze armate, allineandosi sulle posizioni di Diaz e di G. Giardino, fautori dichiarati di un ritorno alle strutture prebelliche; si trovò d’accordo con i suoi colleghi anche nel provocare la rimozione di Badoglio dalla carica di capo di Stato Maggiore dell’esercito nel gennaio 1921 e nel negargli poi un comando degno, del suo rango, quasi a scontare un’ascesa che poteva dare ombra agli altri “generali della vittoria”. Tra l’aprile e l’ottobre 1922 compi un viaggio ufficiale nell’America latina col compito di distribuire decorazioni agli emigrati italiani, e l’incarico ufficioso di saggiare la possibilità di nuove esportazioni per l’industria bellica italiana.
Non sono note particolari prese di posizione del C. dinanzi al fascismo e alla marcia su Roma. Ma tutto lascia credere che egli accettasse e sostenesse il governo Mussolini, per motivi quali quelli che esporrà in Senato il 5 dic. 1924: “Io sono favorevole alle idee originarie del fascismo che sono le idee dei combattenti di tutti i partiti; idee maturate nelle trincee e che ebbero già il consenso dell’Italia sfiduciata davanti allo sfacelo dei poteri statali, idee che si riassumono nella necessità che il governo sia forte, che sia mantenuta la disciplina di tutti i funzionari e di tutti i servizi dello Stato e che l’Italia, rispettata e ascoltata all’estero e perciò necessariamente pacificata all’interno, veda restaurato l’impero della. legge da parte di un governo, che tale impero faccia rispettare e lo rispetti per il primo esso stesso”. Nel momento in cui così si esprimeva, il C. annunciava anche di aver rettificato il suo giudizio sul fascismo: insieme con alcuni altri generali di chiara fama, si asteneva dal confermare la fiducia al governo Mussolini, che gli sembrava ormai un ostacolo per la pacificazione degli animi e il ritorno all’ordine. Il governo, forte dell’appoggio della maggioranza del Senato e dei capi militari, rimase al potere e si avviò alla dittatura aperta, senza che il C. spingesse oltre la sua opposizione.
Nei primi mesi del 1925 il C. diede la sua adesione alla campagna che Giardino, con il consenso di quasi tutti i generali più noti, scatenò contro il progetto di ristrutturazione dell’esercito portato avanti dal gen. A. Di Giorgio, ministro della Guerra. La campagna culminò in un clamoroso dibattito in Senato (l’ultimo momento di vitalità del Parlamento) in cui l’opposizione decisa di tutti i “generali della vittoria” (opposizione al progetto e non al governo, era precisato) indusse Mussolini ad abbandonare Di Giorgio e ad assumere personalmente il ministero della Guerra. Per dimostrare concretamente l’interesse del regime per le forze armate, e nel medesimo tempo minare la posizione dei generali che lo avevano sfidato, Mussolini ricorse a Badoglio, l’unico tra i grandi generali che non avesse partecipato alle polemiche perché, emarginato dai colleghi, aveva accettato il posto di ambasciatore in Brasile. Lo nominò quindi capo di Stato Maggiore generale, con un potere di comando sull’esercito più ampio che in passato (4 maggio 1925). Contro questa soluzione della crisi, che lasciava prevedere l’allontanamento suo e degli altri colleghi dal vertice dell’esercito, il C. si batté energicamente in pubblico e in privato, con un discorso in Senato del 5 maggio che era una vera e propria autocandidatura alla direzione delle forze armate e con un passo diretto presso Mussolini. In questa occasione non esitò a dare un giudizio estremamente duro sul collega (“…egli fu il principale responsabile di Caporetto, dove si condusse come un caporale… Per l’avvenire vi dico che Badoglio sarà certamente la rovina dell’esercito, della monarchia e dell’Italia” – così almeno E. Canevari riferisce le parole del C.), e a diffondersi in accuse sulla carriera di Badoglio troppo acri e insistite per non apparire (come infatti erano) frutto in gran parte di rancori personali. Mussolini non ne tenne conto e Badoglio ebbe via libera per estromettere il rivale da tutte le cariche di responsabilità ricoperte nell’esercito, sostituendolo come comandante designato d’armata e come membro del Consiglio dell’esercito. Non si trattava di una discriminazione di natura politica (gli atteggiamenti di critica al fascismo del C. erano stati occasionali, parziali e contraddittori), ma di un momento della lotta per il controllo dell’esercito che, allora come in seguito (basti pensare alla rivalità tra Badoglio e Cavallero), non essendo legata a reali differenze di orientamento politico o di dottrina militare, assumeva aspetti esasperatamente personalistici.
Dalla metà del 1925 in poi il C. fu quindi costretto a contentarsi del ruolo di “generale della vittoria”: fu cioè colmato di onori (la nomina al nuovo grado di maresciallo nel giugno 1926, il collare della SS. Annunziata nel dicembre 1929) da dividere con Badoglio e gli altri grandi generali, ed ebbe assicurato un ruolo di tutto prestigio nel regime, ma fu privato di ogni responsabilità concreta nella politica militare italiana. Accettò il suo emarginamento con dignità e contenuta amarezza, senza cedere alla tentazione di riguadagnare terreno trescando negli ambienti fascisti o cercando facili successi di pubblicità. Fedele al suo alto concetto di disciplina, mantenne verso il regime un atteggiamento pubblico di assoluta lealtà, che egli stesso così motivava in una lettera del 14 nov. 1930: “Tutti sanno che io non mi occupo di politica. Per me il capo del governo è stato scelto dal re; esso è il capo della gerarchia, di tutti i funzionari civili e militari, e gli debbo rispetto e riverenza, come si debbono a chi sono affidate le sorti della nazione. Mancherei al nido dovete, s’io cercassi di creargli imbarazzi”. Nella vita privata il C. si conduceva invece con una certa libertà, esercitando una critica talora aspra su determinati aspetti del regime, e mantenendo rapporti di amicizia con alcuni antifascisti dichiarati.
In una lettera del 18apr. 1932, intercettata dalla polizia, così gli scriveva dall’esilio C. Sforza: “Per lei, oltre il rispetto, ho con tutti gli italiani liberi riconoscenza perché il suo nome, che appartiene ai nostri figli, è rimasto puro e intatto tra tante cadute nel fango. Il giorno della reazione popolare rischieremo veder gli ideali nazionali rinnegati sol perché una banda osò identificarsi con essi. Quel giorno, additar un Caviglia che rimase solitario e sdegnoso potrà salvar da crisi dolorosa”. Questa e analoghe testimonianze, e, lo stesso Diario del C. (pubblicato postumo a Roma nel 1952, con evidenti tagli) mettono in evidenza come egli accettasse lealmente il regime fascista, più per disciplina che per convinzione o interesse. Il suo atteggiamento relativamente indipendente e critico, anche se in privato e non in pubblico, nel clima dell’epoca bastava a farlo passare per oppositore molto più deciso di quanto non fosse. Ma in effetti la sua idea della vita politica era estranea ad una opposizione di fondo al fascismo. Dalla totale fedeltà monarchica il C. derivava una concezione dello Stato nettamente gerarchico e autoritario, basato sulla obbedienza assoluta alla autorità costituita, sulla disciplina e il governo forte, sul combattentismo e la politica di potenza, venato di paternalismo ma fondamentalmente antipopolare.
La forzata inattività: diede al C. l’occasione per tornare criticamente sulla sua esperienza bellica, con tre volumi di studi e memorie apparsi tra il 1930 e il 1934 nella collezione sulla storia della prima guerra mondiale diretta dal gen. A. Gatti per l’editore Mondadori.
Nel primo di questi volumi, La battaglia della Bainsizza (Milano 1930), si proponeva di rivendicare il valore delle truppe italiane e, se ben comandate, la loro efficienza, in polemica contro la tendenza a scaricare sui soldati la responsabilità di tutte le deficienze della guerra italiana. L’esaltazione della sua opera di comando in questa battaglia, di cui fu l’indiscusso protagonista, si accompagnava a un giudizio critico, ma non negativo, sull’operato di Cadorna. Questo aspetto era sviluppato nello Studio sulla direzione politica e il comando militare nella grande guerra, in appendice al volume, che si segnalava per un’ostentata indipendenza rispetto alla versione dominante (ad es. nel rifiuto di addebitare alla politica giolittiana la responsabilità dell’impreparazione militare italiana).
Nel successivo volume, La dodicesima battaglia: Caporetto (Milano 1933), accanto alla bella rivendicazione del valore delle truppe (in polemica contro la versione ufficiale che riversava le colpe della sconfitta sui soldati e il disfattismo) e alla sottolineatura talora eccessiva della sua azione nella ritirata dall’Isonzo al Piave, si sviluppava la polemica con Badoglio, presentato implicitamente come il responsabile della sconfitta. Un estratto di alcune pagine sulla carriera di Badoglio, in cui il risentimento personale portava il C. a un’interpretazione forzata ed eccessiva dei fatti, non fu compreso nell’edizione del volume, ma inviato al re e a Mussolini e fatto circolare negli ambienti ostili a Badoglio, che non si curò di rispondere.
Queste caratteristiche si ritrovano nel terzo volume, Le tre battaglie del Piave (Milano 1934), che mirava a svalutare l’operato del Comando Supremo di Diaz e Badoglio, specie in relazione alla battaglia di Vittorio Veneto. Come scrisse P. Pieri, il libro “è ricco d’osservazioni interessanti, di notizie a volte preziose, ma scarso di documentazione e con un tono spesso cattedratico, accompagnato talora da una non adeguata valutazione dell’opera altrui”. Più ancora del precedente, il volume scatenò violente polemiche negli ambienti ufficiali, che accusarono il C. di svolgere opera antinazionale denigrando la guerra italiana e il Comando Supremo. Non sappiamo se per parare questi attacchi o per il maturare di un’intima convinzione, il C. si rivolgeva a Mussolini in una lettera del 13 dic. 1934 con toni inconsueti di adesione: nel volume sulle battaglie del Piave, scriveva, “il mio scopo principale è di mettere in evidenza il valore del soldato italiano e di troncare la tendenza storica dei nostri comandi – da Novara a Adua a Caporetto – a gettare sulle truppe la responsabilità delle proprie manchevolezze. È questa un’opera, vostra eccellenza vorrà ammetterlo, eminentemente fascista: rompere una deplorevole tradizione di “Piccolo mondo antico”; dare ai comandi un dignitoso senso di fedeltà alle truppe; ristabilire la fiducia fra gli uni e gli altri. Vostra eccellenza dà l’esempio, nella sua quotidiana comunione e nei suoi contatti con le organizzazioni politiche economiche e militari italiane, del dovere di chi comanda verso i propri dipendenti… Poiché il destino volle che l’Italia avesse durante la guerra ed ora due governi tanto differenti – per energia, decisione, forza di volontà e indipendenza politica – così, sarebbe stato meglio per noi che allora avessimo il governo di vostra eccellenza”.
La guerra d’Etiopia fu accolta dal C. con un entusiasmo limitato solo dal suo rancore verso Badoglio; secondo le informazioni di polizia, spiegava in ogni occasione che la vittoria era “assolutamente merito esclusivo di Mussolini”. Nel settembre 1939, quando l’inizio della seconda guerra mondiale rivelava il ritardo e la crisi nella riorganizzazione e preparazione delle forze armate italiane, fu lo stesso Mussolini a incaricarlo di un’ispezione alla frontiera occidentale, il primo incarico ufficiale di cui abbiamo notizia dal 1925. Poco dopo, però, il C. avallava con una prefazione un volume dello storico suo amico A. Cappa, La guerra e la sua condotta politica e strategica nel XX secolo (Milano 1940), che esaltava la condotta democratica della guerra anglo-francese nel 1914-18 in contrapposizione a quella autocratica e perdente degli Imperi centrali, con implicazioni politiche assai chiare nel momento in cui l’Italia fascista scendeva in campo a fianco della Germania nazista. Convinto sostenitore dell’amicizia italo-francese, ancora nel dicembre 1941 il C. tentò di riproporla come base per una pace di compromesso in un articolo, inviato a Mussolini per l’approvazione alla stampa che naturalmente non ci fu.
Si trattava, anche se non riusciva a tradursi in una linea di condotta politicamente chiara, della manifestazione di quel crescente e ambiguo dissenso che non era solo del C. ma di buona parte dell’alta casta militare. Questo dissenso nasceva dalle contraddizioni tra gestione della politica estera, stato dell’assetto delle forze armate, limiti oggettivi della realtà economica del paese e dell’indirizzo autarchico ai fini della mobilitazione bellica, e opposizione alla guerra di larghi strati e ceti; e investiva gli stessi obiettivi politici della guerra, in quanto suscettibili di mettere in pericolo la sperimentata struttura moderata dello Stato italiano.
Dinanzi al precipitare della situazione italiana per le sconfitte del 1942-43, il C. si illuse ancora sperando che Anglo-americani e Tedeschi potessero accettare l’uscita dell’Italia dal conflitto e la sua neutralizzazione. Fu sorpreso così dagli avvenimenti dell’estate 1943, e fu critico deciso dell’operato del governo Badoglio senza però riuscire a capirne il nodo cruciale.
Se impotenza e impreparazione di fatto dei partiti antifascisti avevano dato spazio all’iniziativa monarchica del colpo di Stato, che tentava così di egemonizzare il cresciuto dissenso delle alte caste economiche e militari verso la guerra per salvaguardare le strutture tradizionali dello Stato insieme con le macerie dell’assetto gerarchico e corporativo fascista, fu poi proprio l’iniziativa monarchica a creare, non volendo, uno spazio d’azione alle forze antifasciste. Unica prospettiva militare possibile del 25 luglio era infatti l’armistizio; ma la sua maggiore o minore onerosità di condizioni diveniva irrilevante di fronte alla ineluttabilità di una scelta politica. Essendo irreale una immediata, o celere, occupazione della penisola da parte delle forze anglo-americane, ed essendo la dislocazione delle truppe italiane dispersa, né solo sull’area metropolitana, e frammista in quest’area con notevoli raggruppamenti tedeschi, le forze armate italiane o si proponevano una lotta di tipo popolare, di militari e civili, che apriva però prospettive politiche innovative e democratiche; o andavano incontro ad un ampio dissolvimento, anche con casuali resistenze simboliche, postulando un’eredità di lotta ancor più popolare e democratica. La fuga dell’8 settembre fu perciò l’oggettiva incapacità di operare questa scelta.
Il C. giunse a Roma l’8 sett. 1943, e il giorno seguente, apprendendo della precipitosa fuga del re e di Badoglio, tentò di coprire il vuoto di potere assumendo responsabilità di governo. In una situazione drammaticamente confusa, non riuscì né a imporre né a seguire una linea di condotta. coerente, e finì col facilitare la resa ai Tedeschi, senza rendersi conto delle conseguenze. Si ritirò poi nuovamente nella sua casa di Finale Ligure, da cui assisté agli avvenimenti del 1943-45 trasportato da sentimenti contrastanti, reso ormai incapace dalla sua formazione e dalla sua vita stessa a fare scelte precise.
Morì a Finale Ligure il 22 marzo 1945. La salma fu poi traslata il 21 giugno 1952 in un mausoleo ricavato da un antico torrione di guardia sopra Finale Ligure, con una solenne cerimonia alla quale intervennero il presidente L. Einaudi e Orlando come oratore ufficiale.(fonte)
[10] Francesco Saverio Grazioli. Nacque a Roma il 18 dic. 1869 da Giovanni, appartenente a una famiglia di mercanti di campagna dell’Agro romano, e da Teresa Busiri Vici, figlia di Andrea, primo architetto della Fabbrica di S. Pietro.
Secondo di quattro figli, il G. dal 1° nov. 1883 studiò al collegio militare di Roma. Il 1° ott. 1886 entrò all’Accademia militare, da cui uscì con il grado di sottotenente il 7 marzo 1889, e poi alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio. Nominato tenente il 30 ag. 1890, fra il 19 ott. 1896 e il 22 ag. 1898 fu in Colonia Eritrea. Fra il 1895 e il 1899 seguì i corsi della Scuola superiore di guerra di Torino dove ottenne il brevetto il 12 dic. 1899. Il 10 luglio 1900 fu nominato, a scelta, capitano; il 20 ott. 1900 sposò Anna Agnese Bianco. Il 13 luglio 1903 lasciò l’artiglieria per il corpo di stato maggiore.
Distintosi nell’azione di soccorso dopo il terremoto di Messina del 1908 (medaglia d’argento al valor civile, r.d. 27 marzo 1911), il G. si mise in evidenza soprattutto per l’interesse agli studi, le capacità di scrittura e per i giudizi, “moderni” e spigliati: tra l’altro riteneva che l’istituzione militare doveva modificarsi, in sintonia con le istituzioni politiche e sociali del tempo.
Questi aspetti del carattere dovettero piacere al capo di stato maggiore dell’esercito, A. Pollio che, nel 1908, lo volle con sé. Il 31 marzo 1910 fu promosso maggiore per meriti eccezionali.
Dopo una prima missione “coperta” a Malta, fra il settembre e l’ottobre, dal novembre 1911 al 6 ott. 1912 fu in Libia, dove venne decorato con medaglia d’argento per i combattimenti di Bir Tobras. Dal 28 apr. 1912 fu capo di stato maggiore della 5a divisione speciale e il 23 ag. 1912 fu promosso tenente colonnello per merito di guerra per la conquista di Sidi Said. Tornato in patria fu addetto agli uffici ministeriali militari responsabili per le colonie; dal 30 maggio 1913 al 19 marzo 1915 fu di nuovo in Libia, con l’importante incarico di capo dell’ufficio politico-militare di Tripoli. La fine dell’incarico coloniale coincise con lo scoppio della guerra mondiale.
Fu prima capo di stato maggiore al V corpo d’armata della 1ª armata, quindi al XIII corpo d’armata, passato poi alla 3ª armata. Il 6 luglio fu promosso colonnello e, nemmeno un anno più tardi, colonnello brigadiere, cioè comandante di brigata (la “Lambro”); il 10 ag. 1916, ancora per meriti di guerra legati al comando della “Lambro”, fu nominato maggior generale. Comandò poi la 48ª divisione e, per un breve periodo, dal 21 sett. 1917, addirittura l’VIII corpo d’armata, uno dei corpi travolti nel corso dell’operazione austro-tedesca che portò allo sfondamento a Caporetto.
Dopo la rotta il G. venne spedito come capo di stato maggiore prima alla 4ª armata, sul Grappa, poi alla 5ª, di formazione e di riserva (dal maggio 9ª). Qui poté dedicarsi anche agli studi: teorizzò, fra l’altro, un piano per una “armata di riserva mobile strategica” e le modalità per una migliore cooperazione fra fanteria e aeronautica.
Tenente generale il 20 giugno 1918, già dall’8 dello stesso mese era stato nominato comandante del corpo d’armata d’assalto, cioè degli arditi. In tale veste il G. giocò un ruolo di rilievo nella battaglia di Vittorio Veneto. Nei giorni dell’attacco finale, anzi, da E. Caviglia (8ª armata) gli fu affidato il comando anche dell’VIII corpo d’armata (28 ott. 1918), con l’incarico di imprimergli maggior impulso offensivo.
Alla fine della guerra il G. era dunque arrivato quasi al culmine della carriera, conosciuto per gli scritti oltre che per l’indipendenza di giudizio: appoggiandosi alle sue amicizie, fra cui era il duca d’Aosta Emanuele Filiberto, poté rimanere critico nei confronti sia del vecchio sia del nuovo comando supremo, e in particolare di P. Badoglio. Dopo lo scioglimento del corpo d’assalto, ricevette un incarico politico-militare di rilievo nazionale: dal 28 nov. 1918 all’agosto 1919, fu comandante del corpo interalleato di occupazione di Fiume.
Il comandante militare italiano veniva, di fatto, a trovarsi in una situazione complessa, stretto fra le richieste dei circoli nazionalistici italiani di Fiume, l’ostilità antitaliana della popolazione locale non italofona, le pressioni dei comandanti dei reparti militari delle altre nazioni e, soprattutto, i sospetti delle potenze. Il G., pur consapevole delle intemperanze dei circoli italiani, ne sostenne in ultima analisi la politica e se ebbe, su questa linea, il costante sostegno del duca d’Aosta, comandante della 3ª armata, solo alla fine ottenne l’appoggio del comando supremo, cioè di A. Diaz e Badoglio.
L’evoluzione della congiuntura internazionale e diplomatica e gli errori politici commessi dal G. – oltre al sostegno all’irredentismo locale, vi fu anche l’atteggiamento altero da lui tenuto nei confronti della commissione interalleata, giunta sul posto nel luglio 1919 – resero impossibile la sua permanenza. Venne sostituito e, il 1° sett. 1919, dovette lasciare Fiume.
L’incarico aveva comunque aumentato la notorietà del G., al punto che si fece il suo nome, insieme con quello del duca d’Aosta, quando, nel clima arroventato di quel particolare momento, si parlò di complotti e colpi di Stato. Del resto il G. non aveva mai nascosto le sue simpatie per una politica di indirizzo nazionalista e militarista.
Dopo un periodo a disposizione, al G. fu assegnato l’incarico di direttore superiore delle scuole militari: pur trattandosi di una destinazione che lusingava il militare studioso e innovatore, il ruolo era tutt’altro che di primo piano. Piuttosto, il grado, l’età e la notorietà gli aprirono le porte del Consiglio d’esercito: composto di una decina di alti generali, era il corpo consultivo del ministro e un contrappeso al potere dello stato maggiore e di Badoglio. Gli vennero, inoltre, affidate l’organizzazione e la guida del corteo che, il 4 nov. 1921, condusse la salma del milite ignoto a Roma, al Vittoriano.
Onori e incarichi avevano forse illuso il G. circa la possibilità di entrare attivamente nel gioco politico, in anni in cui si poneva il problema di un nuovo ordinamento per l’esercito. A questo proposito, nell’ottobre 1919, egli aveva inviato a F.S. Nitti un promemoria in cui proponeva un esercito piccolo e ben armato, guidato da una dottrina strategica offensiva e ispirato a una tattica che consentisse rapidità e facilità di manovra. Qualche tempo dopo (agosto 1922) lo ripropose a B. Mussolini cui volle pure comunicare (23 ottobre) che, in caso di un colpo di mano da parte del fascismo, l’esercito sarebbe rimasto passivo. Anche per questo Mussolini lo fece invitare (26 ottobre) perché affiancasse De Bono nella preparazione della marcia su Roma, ma il G. rifiutò.
Nel dicembre 1922 fece avere a Mussolini, ora capo del governo, un nuovo promemoria proponendosi come ministro e come fondatore di un “nuovo esercito”; contemporaneamente, all’interno della gerarchia militare continuò a perorare la costituzione di “grandi unità celeri miste”, interforze, motorizzate e meccanizzate.
Come generale di corpo d’armata destinato, dall’8 marzo 1923, al comando del IV corpo d’armata con sede a Verona, il G. si trovò a essere per il fascismo una utile sponda nelle alte gerarchie dell’esercito. Avendo deciso di creare l’ufficio di capo di stato maggiore generale guidato da Badoglio, Mussolini, nonostante il parere contrario di quest’ultimo, il 4 maggio 1925 nominò il G. sottocapo, ruolo che egli ricoprì sino al 1° febbr. 1927. Subito dopo (26 febbr. 1927) venne designato generale di armata (in caso di guerra) e inviato a Bologna, dove rimase sino all’ottobre 1934, ancora una volta lontano da Roma e quindi dai centri del potere politico. Il 22 dic. 1928 era stato nominato senatore.
L’ambizioso G. avrebbe voluto salire più in alto (nel maggio 1931 aveva scritto ancora al duce, di nuovo autoproponendosi come ministro della Guerra), ma Mussolini, che nel 1925 lo aveva messo alle costole di Badoglio più per controllare l’uno che per promuovere l’altro, vedeva, ragionevolmente, nel G. una personalità isolata, con scarso seguito, cui non intendeva, né aveva interesse a farlo, affidare la politica militare nazionale.
Nel frattempo il G. non aveva abbandonato il suo atteggiamento critico circa la gestione delle forze armate.
Già nel novembre 1930 Mussolini aveva bloccato l’uscita di un suo articolo critico dell’operato del gen. G. Giardino e della gerarchia militare nel corso della Grande Guerra. Nel luglio 1931, viceversa, il G. riuscì a pubblicare sulla Nuova Antologia un’aperta denuncia circa l’insufficiente ammodernamento degli armamenti e delle tattiche dell’esercito che fece inalberare Badoglio; ancora una volta, solo il duce poté tamponare lo scandalo.
Dal 1° ott. 1934 il G. fu ispettore della preparazione pre e postmilitare (in pratica responsabile della ginnastica militare ovvero della militarizzazione della popolazione, cui il regime teneva molto). Il 18 dic. 1935 il G. passò in posizione ausiliaria per raggiunti limiti d’età: in effetti venne “trattenuto in servizio” ma senza incarichi connessi alla guerra d’Etiopia, mentre veniva invece richiamato Badoglio. Fu nominato, in extremis, generale d’armata (21 ott. 1937) e continuò a svolgere numerose missioni, ma di scarso rilievo; venne quindi congedato (1° sett. 1938) e poi messo nella riserva (1° genn. 1940). Il regime gli offrì ancora qualche incarico: dal 3 nov. 1938 al marzo 1940 fu vicepresidente della Compagnia italiana trasporti Africa Orientale e, dall’aprile 1941 al luglio 1943, direttore della rivista Nazione militare cui da tempo collaborava.
La vecchia simpatia per il fascismo delle origini, il prestigio militare e il suo storico “antibadoglismo” fecero sì che, il 19 sett. 1943, G. Buffarini Guidi, per conto di Mussolini, gli offrisse l’incarico di ministro della Difesa nazionale della Repubblica sociale italiana, ma il G. rifiutò. Questa decisione gli evitò spiacevoli conseguenze dopo l’occupazione delle truppe alleate: un procedimento di epurazione, avviato il 3 dic. 1944, venne sbrigativamente concluso il 27 dicembre con la dizione: “non sussiste addebito alcuno”.
Nel dopoguerra fu attivo nelle file monarchiche e continuò a scrivere: tra l’altro fu tra gli autori del volume curato nel 1948 dall’Ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito in occasione del centenario del 1848 (Le operazioni militari nel 1848, in Il primo passo verso l’Unità d’Italia, Roma 1948).(fonte)
[11] Antonin de Selliers de Moranville (Saint-Josse-ten-Noode, 12 gennaio 1852 – Ixelles, 17 aprile 1945) è stato un soldato belga. IL25 maggio 1914. fu nominato capo di stato maggiore dell’esercito belga, che comandò al momento dell’invasione del Belgio nell’agosto 1914 . È figlio di Léonard de Selliers de Moranville (cavaliere) (Bruxelles, 28 maggio 1803 – Bruxelles, 14 aprile 1856), avvocato, pubblicista, ispettore dell’istruzione primaria nel cantone di Asse 3 e Marie Pangaert, 1810-1892 .
Iniziò la sua formazione presso la Scuola Militare nel 1869 come membro della trentacinquesima promozione (1869-1874), dipartimento di artiglieria e genio. Durante la guerra franco-prussiana del 1870, la Scuola Militare fu chiusa e Antonin in questo periodo fece volontariato con le guardie di frontiera. La scuola riaprì nell’ottobre 1870.
Nel novembre 1871 divenne sottotenente. Si laureò nel 1874 e divenne ufficiale di artiglieria. Nel 1875 fu promosso tenente. Nel 1877 seguì i corsi della Scuola Militare e nel 1877 ottenne il brevetto di personale. Nel 1881 divenne professore di storia militare nella stessa scuola militare.
Le elezioni legislative del 1884 assicurarono al partito cattolico una maggioranza che mantenne per trent’anni. Il nuovo ministro della Guerra, il generale Charles Pontus , prese Antonin de Selliers nel suo gabinetto e lo promosse capitano.
Come aiutante del ministro, de Selliers fu testimone degli scioperi dei ribelli del 1886 a Liegi e Charleroi . Era consapevole del rischio che questi movimenti insurrezionali venissero schiacciati da un esercito composto principalmente da coscritti , figli della classe operaia , poiché le classi più ricche potevano sottrarsi al servizio militare mediante sostituzione , pagando un sostituto. Il comandante generale che schiererà l’esercito contro gli scioperanti sottolinea che non è da escludere una fraternizzazione tra scioperanti e soldati. Nella revisione generale, de Selliers pubblica un articolo in cui accusa la borghesia di ingenuità e mancanza di perspicacia.
Nel 1886 de Selliers divenne membro dello stato maggiore, da cui venne scelto il comando dell’esercito. Nel 1893 si affezionò al nuovo segretario alla Guerra, il tenente generale Jacques Brassine , che presentò un disegno di legge che eliminava la possibilità di pagare un sostituto per il servizio militare. I tre progetti presentati successivamente nel 1895 e nel 1896 furono respinti sotto la pressione di Charles Woeste e Brassine si dimise. Nessun soldato vuole succedergli ed è il civile Jules Vandenpeereboom a diventare ministro della Guerra.
Nel giugno 1896 de Selliers fu promosso maggiore e secondo in comando dell’Ecole Militaire . Nel 1899 divenne direttore delle operazioni militari presso il ministero. Nel 1900 fu promosso tenente colonnello e nominato capo di stato maggiore del quarto distretto militare. Nel 1902 fu promosso colonnello. Durante gli scioperi avvenuti quest’anno, garantisce l’ordine pubblico. Poiché la sua condotta diplomatica nel mantenimento dell’ordine si dimostrò favorevole, e anche perché era uno dei pochi alti ufficiali cattolici , fu nominato comandante della gendarmeria nel 1904. Nel 1907 fu promosso maggiore generale e nel 1912 tenente generale .
Per poter applicare con mano ferma la coscrizione generale, lo stesso primo ministro Charles de Broqueville divenne ministro della Guerra dal novembre 1912.
All’interno dei vertici dell’esercito i disaccordi e la competizione sono considerevoli. Il colonnello Louis-Désiré de Ryckel fu nominato vice capo di stato maggiore nel dicembre 1913. Si oppose al capo di stato maggiore, generale Armand De Ceuninck , che presto sarebbe andato in pensione, e Charles de Broqueville nominò suo successore il generale de Selliers. Maggio ad interim e a luglio come titolare. Tuttavia, i rapporti non erano buoni tra lui e de Ryckel, che da parte sua aveva la fiducia del re Alberto I e del suo ufficiale d’ordinanza, il generale Émile-Joseph Galet .
Le rivalità tra i leader si riflettono nelle loro opinioni divergenti su quale dovrebbe essere la migliore difesa contro gli attacchi tedeschi . Il 2 agosto 1914 il governo belga ricevette l’ultimatum tedesco. La guerra è decisa, ma le strategie di Selliers e Louis de Ryckel si scontrano. Il re Alberto scelse le proposte di Louis de Ryckel, tanto più che alla fine fu proprio il piano elaborato dal re stesso e da Galet a proporre de Ryckel.
All’interno dell’esercito persistono problemi. Il generale de Ryckel discuteva spesso della situazione militare con Galet, senza che de Selliers lo sapesse. Il Re lascia anche il Capo di Stato Maggiore all’oscuro di ciò che ha deciso. Ciò non poteva durare e il 6 settembre 1914 fu emanato un decreto reale che abolì puramente e semplicemente la carica di Capo di Stato Maggiore Generale. Il re ora esercitava lui stesso il comando completo, con l’aiuto di Emile Galet e con l’aiuto di un docile vice capo di stato maggiore, il generale Félix Wielemans .
Secondo lo storico Jacques Willequet , il re ritiene che con il giuramento costituzionale “di mantenere l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio”, ha la responsabilità personale di dirigere l’esercito.
De Selliers viene nominato ispettore generale dell’esercito. Si occupa in particolare dell’organizzazione dei centri di formazione dove vengono formati i nuovi assunti. Raggiunse l’età pensionabile nel 1917, ma rimase in servizio fino al febbraio 1919 .
Non sopporta l’abolizione del suo incarico di Capo di Stato Maggiore o di Comandante in Capo, e questo si riflette nella libertà e nell’audacia con cui parla dei prossimi problemi militari e politici. Per i successivi trent’anni de Selliers si dedicò allo studio e alle pubblicazioni.
Controversia: responsabilità ministeriale
A partire da Leopoldo I , i re belgi hanno preso alla lettera l’articolo 68 della Costituzione ( Il Re comanda le forze terrestri e navali ) e lo hanno ritenuto un’eccezione all’articolo 64, il quale afferma che nessun atto del re può avere forza se non è controfirmato da un ministro . Il re Alberto I ritiene inoltre che i suoi atti di comandante militare, almeno in tempo di guerra, siano validi senza controfirma ministeriale e non rientrino sotto la responsabilità ministeriale. Il primo ministro Charles de Broqueville si oppose, ma perse. Il suo capo di stato maggiore, Louis de Lichtervelde, scrive un memorandum dettagliato in cui vuole dimostrare che il Re agisce incostituzionalmente. Quando Albert legge questa nota, è furioso. De Lichtervelde e il primo ministro vengono duramente rimproverati e il caso viene finalmente archiviato. Nel dopoguerra il Re-Cavaliere divenne così popolare e intoccabile, visto l’esito vittorioso della guerra, che sulla questione non si può più tornare indietro.
C’è un’eccezione: lo studio che Antonin de Selliers de Moranville dedica al problema in un editoriale intitolato I poteri del re secondo la Costituzione belga . A questo punto era già caduto in disgrazia a Corte e inoltre si era ritirato per poter esprimere liberamente la sua opinione. Egli scrive: Tutti i governi belgi dal 1831 e la stragrande maggioranza dei giuristi riconoscono la necessità di cooperare con un ministro responsabile quando il re comanda l’esercito. Il decreto stabilisce che secondo la Costituzione belga, il Re e il Ministro della Guerra costituiscono un’entità inseparabile per comandare legalmente l’esercito .
Non ha usato questa parola, ma la conclusione è chiara: la Costituzione è stata violata durante la Prima Guerra Mondiale. L’enorme popolarità di cui godette il Re-Cavaliere nel dopoguerra, e la sua morte improvvisa, fecero sì che questa disputa costituzionale non venisse approfondita.
La questione tornò d’attualità nel 1940, quando si scoprì che il re Leopoldo III credeva ancora di poter agire al di fuori della responsabilità ministeriale come comandante dell’esercito. Una conseguenza di ciò è il dramma della divisione tra il re e il suo governo e la conseguente questione reale , che porta la monarchia sull’orlo dell’abolizione. Nessuno oggi pensa che in futuro solo il re potrà comandare l’esercito, né autonomamente né addirittura con controfirma ministeriale.(fonte)
[12] Alberto Emanuele Lumbroso Nacque a Torino il 1o ott. 1872, in una famiglia israelita, unico figlio di Giacomo e di Maria Esmeralda Todros, di nazionalità francese.
Il nonno paterno, Abramo, protomedico del bey di Tunisi, aveva ottenuto nel 1866 da Vittorio Emanuele II il titolo di barone per meriti scientifici e per speciali benemerenze. Il padre del L., Giacomo, era nato a Bardo, in Tunisia, nel 1844. Ellenista e papirologo di fama internazionale, dal 1874 socio della Deutsche Akademie der Wissenschaften, influenzò fortemente l’educazione e la formazione intellettuale del Lumbroso. Trasferitosi a Roma intorno al 1877, divenne accademico dei Lincei (1878) e pubblicò la sua opera principale, L’Egitto al tempo dei Greci e dei Romani (Roma 1882), ottenendo nello stesso 1882 la cattedra di storia antica all’Università di Palermo. Con il medesimo insegnamento, nel 1884, si trasferì a Pisa, quindi, nel 1887, nuovamente a Roma dove insegnò storia moderna alla “Sapienza” (vedi le Lezioni universitarie su Cola di Rienzo, ibid. 1891). Giacomo morì a Rapallo nel 1925.
I trasferimenti del padre lasciarono notevoli tracce nella formazione del giovane L.; tra le sue prime esperienze romane si ricordano la frequentazione delle case di T. Mamiani e di Q. Sella, dove divenne amico di S. Giacomelli, nipote di questo; in Sicilia rimase affascinato da G. Pitrè e, nell’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari da lui diretto, pubblicò nel 1896 il suo primo articolo.
Nel periodo pisano il L. continuò con successo gli studi e sviluppò una notevole passione per la cultura erudita, collezionando autografi, raccogliendo motti, proverbi e notizie folkloristiche, sempre in perfetta sintonia con il padre. Tornato a Roma si diplomò al liceo classico E.Q. Visconti, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza e si appassionò al periodo napoleonico, laureandosi, intorno al 1894, con una tesi su Napoleone I e l’Inghilterra (poi rielaborata e pubblicata in volume: Napoleone I e l’Inghilterra. Saggio sulle origini del blocco continentale e sulle sue conseguenze economiche, Roma 1897). Gli studi napoleonici occuparono interamente il L. fra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il primo del Novecento. La frequentazione di ambienti intellettuali ed eruditi italiani (soprattutto romani, torinesi e, più tardi, napoletani) e francesi, l’assoluta familiarità con la lingua della madre e lo sviluppo di un talento compilativo dimostrato fin dalla prima giovinezza portarono il L. alla realizzazione di un gran numero di pubblicazioni.
Tra il 1894 e il 1895 uscirono i cinque volumi del Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell’epoca napoleonica (Modena), circa mille pagine dedicate alle lettere “da A a Bernays” (l’opera resterà incompiuta) e tra il 1895 e il 1898 le sei serie della Miscellanea napoleonica (Roma-Modena), altra cospicua opera erudita di oltre millecinquecento pagine che raccoglieva memoriali, lettere, canzoni, accadimenti notevoli e minuti forniti da studiosi europei e introdotti dal L.; nella Bibliografia dell’età del Risorgimento V.E. Giuntella li definì “saggi bibliografici che, sebbene arretrati, possono ancora essere utilmente consultati” (I, Firenze 1971, p. 405).
L’interesse per il periodo napoleonico portò il L. a Napoli, in cerca di notizie e documenti su Gioacchino Murat. Suo interlocutore privilegiato in quella città fu B. Croce: il L. frequentò la casa del filosofo negli ultimi anni del secolo e i rapporti epistolari tra i due si protrassero a lungo.
I maggiori lavori napoletani del L. furono la Correspondance de Joachim Murat, chasseur à cheval, général, maréchal d’Empire, grand-duc de Clèves et de Berg (julliet 1791 – julliet 1808 [sic]), (prefaz. di H. Houssaves, Turin 1899 e L’agonia di un Regno: Gioacchino Murat al Pizzo (1815), I, L’addio a Napoli, prefaz. di G. Mazzatinti, Roma-Bologna 1904.
Alla fine del secolo il L. fu organizzatore e presidente operativo del Comitato internazionale per il centenario della battaglia di Marengo (14 giugno 1800-1900): chiamò alla presidenza onoraria G. Larroumet, professore della Sorbona e accademico di Francia, ottenendo la partecipazione onoraria di noti intellettuali tra cui G. Carducci, B. Croce, G. Mazzatinti, C. Segre, A. Sorel, le cui lettere di adesione furono via via pubblicate nel Bulletin mensuel du Comité international; nel 1903, accompagnato da una lettera-prefazione di Larroumet, fu edito il primo tomo, poi rimasto senza seguito, dei Mélanges Marengo (s.l. [ma Frascati] né d.).
Ancora una volta il L. usa uno stile cronachistico, cerca e pubblica ogni genere di fonte, prediligendo quelle dirette. A tale scopo rintraccia figli e nipoti dei personaggi che descrive; caso emblematico quello dei “Napoleonidi”: e infatti, grazie ai suoi lavori e alle sue frequentazioni parigine, divenne “Bibliothécaire honoraire de S.A.I. le prince Napoléon” [Vittorio Napoleone]; pubblicò poi Napoleone II, studi e ricerche. Ritratti, fac-simili di autografi e vari scritti editi ed inediti sul duca di Reichstadt (Roma 1902), Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II, re di Roma, duca di Reichstadt (ibid. 1905) e – più tardi – redasse le voci su Napoleone I e i Napoleonidi per il Grande Dizionario enciclopedico UTET (1937, VII, pp. 1100-1150). A coronamento dei suoi interessi per i Bonaparte, nel 1901 il L. fondò e diresse la Revue napoléonienne, bimestrale (ma, dal 1908, mensile) che uscì fino al 1913, coinvolgendo nell’iniziativa un gran numero di studiosi italiani e francesi.
L’interesse per la cultura d’Oltralpe lo portò a pubblicare anche lavori su Voltaire (Voltairiana inedita, Roma 1901), Stendhal (Stendhaliana: da Enrico Beyle a Gioacchino Rossini, Pinerolo 1902) e soprattutto Maupassant (Souvenirs sur Guy de Maupassant: sa dernière maladie, sa mort. Avec des lettres inédites communiquées par madame Laure de Maupassant et des notes recueillies parmi les amis et les médecins de l’écrivain, Genève-Rome 1905), scritto durante un lungo soggiorno parigino.
Nel 1898 il L. era intanto diventato consigliere della Società bibliografica italiana e probabilmente nel contesto culturale della Società conobbe Carducci, cui dedicò, postuma, una Miscellanea carducciana (con prefaz. di B. Croce, Bologna 1911), raccolta di notizie critiche, biografiche e bibliografiche sul poeta.
Nel 1897 aveva sposato Natalia Besso, dall’unione con la quale nacquero Maria Letizia (1898) e Ortensia (1901). Nel 1901 l’intera famiglia abbracciò la religione cattolica. Nel 1904 il L. donò la sua ricca biblioteca napoleonica (circa trentamila volumi e opuscoli) alla Biblioteca nazionale di Torino, da poco distrutta in un incendio. Nel 1907 assunse, con A.J. Rusconi, la direzione della Rivista di Roma e, a partire dal 1909, ne divenne direttore unico.
La direzione della Rivista rappresentò una svolta nei suoi interessi e nei suoi studi, che da internazionali ed eruditi divennero più “patriottici”, legati a eventi del Risorgimento e della storia italiana (in particolare il L. sì appassionò alla riabilitazione dell’ammiraglio C. Pellion di Persano e, oltre agli articoli apparsi nella Rivista, sull’argomento pubblicò La battaglia di Lissa nella storia e nella leggenda: la verità sulla campagna navale del 1866 desunta da nuovi documenti e testimonianze, Roma 1910, seguita da ulteriori approfondimenti, tra cui Il carteggio di un vinto, ibid. 1917). Tra coloro chiamati dal L. a collaborare alla Rivista – che dal primo momento egli volle “crispina, salandrina e antigiolittiana” e, dopo la guerra, “antibonomiana e antinittiana” (Premessa, s. 3, XXXII [1928], 1) – D. Oliva, E. Corradini, L. Ferderzoni, A. Dudan.
Dal 1909 G. D’Annunzio collaborò alla Rivista di Roma. Il contatto diretto portò in breve tempo il L., inizialmente piuttosto critico nei confronti del poeta (si veda del L. Plagi, imitazioni e traduzioni, in Id., Scaramucce e avvisaglie. Saggi storici e letterari di un bibliofilo(, Frascati 1902, pubblicazione che Croce aveva particolarmente apprezzato), a divenirne ammiratore e paladino, fino a entrare in forte polemica sia con lo stesso Croce sia con G.A. Borgese; nel 1913, nel cinquantesimo anniversario di D’Annunzio, volle dedicargli l’intero n. 6 della Rivista; nello stesso anno il L. fu attivo nel Comitato pro Dalmazia italiana e, nel 1914, diede vita a un Comitato pro Polonia del quale offrì la presidenza onoraria al poeta.
Approssimandosi la guerra, la Rivista di Roma svolse campagne in favore dell’intervento e, nel 1915, lo stesso L. partì volontario col grado di sottotenente. Promosso tenente, dal 1916 al 1918 fu addetto militare aggiunto presso l’ambasciata italiana ad Atene e, al termine del conflitto, fu insignito del cavalierato nell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro per benemerenze acquisite in guerra.
Nel 1924, ormai di fatto separato dalla moglie, il L. si trasferì a Genova dove riprese la pubblicazione della Rivista di Roma, sospesa nel biennio 1922-23, che diresse fino al 1932. A Genova ebbe due figli, Emanuele e Maria Tornaghi, nati nel 1918 e nel 1919 da Adriana Tornaghi, con la quale aveva a lungo convissuto.
Dopo la morte del padre, il L. ne pubblicò la bibliografia (in Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso, Milano 1925); fin dal 1923 aveva collaborato con Critica fascista, e nel 1929 inviò suoi libri a B. Mussolini e chiese l’iscrizione al Partito nazionale fascista. I lavori più consistenti del L. negli anni Venti e Trenta furono dedicati principalmente alla Grande Guerra e a personaggi della casa reale.
Bibliografia ragionata della guerra delle nazioni: numeri 1-1000 (scritti anteriori al 1 marzo 1916), Roma 1920; Le origini economiche e diplomatiche della guerra mondiale, dal trattato di Francoforte a quello di Versailles, I-II, Milano 1926-28; Carteggi imperiali e reali: 1870-1918. Come sovrani e uomini di Stato stranieri passarono da un sincero pacifismo al convincimento della guerra inevitabile, ibid. 1931; Cinque capi nella tormenta e dopo: Cadorna, Diaz, Emanuele Filiberto, Giardino, Thaon di Revel visti da vicino, ibid. 1932; Da Adua alla Bainsizza a Vittorio Veneto: documenti inediti, polemiche, spunti critici, Genova 1932; Fame usurpate: il dramma del comando unico interalleato, Milano 1934.
Fra gli ultimi volumi pubblicati dal L. si ricordano ancora: Carlo Alberto re di Sardegna. Memorie inedite del 1848, con uno studio sulla campagna del 1848 e con un’appendice di documenti inediti o sconosciuti tradotti sugli autografi francesi del re da Carlo Promis (s.l. 1935) nonché, per i “Quaderni di cultura sabauda”, I duchi di Genova dal 1822 ad oggi (Ferdinando, Tommaso, Ferdinando-Umberto), ed Elena di Montenegro regina d’Italia (entrambi Firenze 1934).
Grazie al suo prestigio personale e all’adesione al cattolicesimo risalente al 1901, i Lumbroso furono discriminati dall’applicazione delle leggi razziali del 1938, ma il L. non pubblicò più. Il L. morì a Santa Margherita Ligure l’8 maggio 1942.(fonte)
[13] Luca Montuori. – Nacque ad Avellino il 18 febbraio 1859 da Nicola e da Tommasina Soldutti, in una famiglia che non poteva vantare precedenti militari illustri. Dopo l’infanzia trascorsa in Irpinia, entrò all’Accademia di Torino il 1° ottobre 1878 e ne uscì due anni dopo sottotenente d’artiglieria.
Quale appartenente all’arma ‘dotta’ per eccellenza le strade che gli si prospettavano erano sostanzialmente due: quella di specializzarsi nell’impiego della propria arma e di transitare nel ruolo tecnico, oppure quella di entrare nello stato maggiore per cercare di segnalarsi nell’azione di comando. La prima alternativa gli consentiva una carriera sicura ma spesso ingrata e scarsa di soddisfazioni, la seconda apriva prospettive realmente interessanti solo in caso di conflitto. Montuori ebbe pochi dubbi nell’optare per quest’ultima strada. Tratto tipico della sua personalità militare furono la durezza nel comando e la severità verso se stesso e gli altri. Difficilmente discusse gli ordini ricevuti, o si permise anche solo di interpretarli, e quasi mai accettò incertezze nei suoi subordinati. Anche se difettava di originalità concettuale, non era privo di cultura e a ogni gradino importante della sua carriera si costruì una solida preparazione tecnico-professionale.
Nel 1889 entrò alla scuola di guerra, da cui passò al corpo di stato maggiore, completando la formazione come ufficiale di fanteria. In occasione dei moti di Milano del 1898, quando era maggiore, gli fu conferita una medaglia d’argento per il suo intervento contro i dimostranti. Promosso tenente colonnello nel dicembre 1901, lavorò all’Istituto geografico militare, per diventare quindi titolare di logistica alla scuola di guerra e passare poi nel 1907 a Berlino quale addetto militare. Il 3 febbraio 1907 fu promosso colonnello, restando in servizio presso il corpo di stato maggiore; solo nel 1910 assunse il comando del 50° reggimento fanteria «Parma», con cui l’anno dopo partì per la Tripolitania.
Restò in Libia anche nei due anni successivi, promosso maggior generale nel giugno 1912, meritando la croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia (16 marzo 1913) per il comando della brigata mista nella battaglia di Zanzur (8 giugno 1912) e poi quella di ufficiale del medesimo ordine (28 dicembre 1913) per la battaglia di Assaba e la successiva avanzata su Nalut.
Richiamato in Italia, comandò la brigata «Pisa» e nel 1914 la III brigata alpina, per assumere all’inizio del 1915 il comando della scuola di guerra. Gli si apriva per la prima volta l’opportunità di dare un proprio indirizzo a un ente molto prestigioso, ma con una impostazione rigida e dottrinale. Tuttavia non poté nemmeno iniziare l’impresa, perché lo scoppio del conflitto lo vide subito trasferito al fronte alla testa della brigata «Parma», che guidò fino al 3 giugno 1915. I precedenti di carriera lo destinavano infatti a un comando superiore e ai primi di giugno, con la promozione a tenente generale, gli venne assegnata la 10ª divisione, impegnata in Cadore nel settore Padola-Visdende.
Mantenne tale comando fino al 1° dicembre successivo, quando assunse quello della 4ª divisione, da mesi impegnata sul Sabotino, nel tentativo di conquistare quella fortezza naturale ritenuta prendibile in poche ore alla scuola di guerra ma che dall’inizio del conflitto aveva logorato senza alcun successo molte delle migliori unità della fanteria. Il 23 maggio 1916 lasciò la divisione per assumere il comando del XX corpo d’armata, con il quale combatté per i 15 mesi successivi sull’Altopiano dei Sette Comuni. Contribuì ad arrestare l’offensiva austriaca, condusse la controffensiva e combatté nell’estate 1917 l’attacco che avrebbe dovuto ridare all’Italia la sicurezza alle spalle dell’esercito operante sull’Isonzo e che invece naufragò nel massacro dell’Ortigara.
La sua azione di comando fu contrassegnata da un notevole livello di brutalità e da un’assoluta mancanza di scrupoli. Ordini improntati alla scarsissima considerazione per la vita dei suoi subordinati provocarono infatti la morte di parecchi comandanti di brigata e innumerevoli richieste di provvedimenti di esonero. L’azione a tratti sconsiderata di siluramento dei comandanti al fronte, se ebbe in Cadorna il maggior responsabile, trovò in Montuori uno degli esecutori più zelanti, spesso anche oltre le intenzioni del capo di stato maggiore. Montuori non subì tuttavia alcuna conseguenza dalla sua azione infruttuosa, ricavandone anzi la commenda dell’Ordine militare di Savoia (28 dicembre 1916) e una seconda medaglia d’argento.
Il 23 agosto 1917 venne richiamato sul Carso al comando del II corpo d’armata, dove rimase – ferito sulla Bainsizza – fino al 12 ottobre 1917, prendendo parte alla XI battaglia dell’Isonzo. In questa data assunse il comando interinale della 2ª armata, in sostituzione del titolare Luigi Capello, costretto al ricovero ospedaliero. Nelle fasi cruciali di questo comando la sua acquiescenza agli ordini e alle illusioni di Cadorna costò alla sua unità perdite gravissime sotto il profilo numerico ed esiziali sotto quello morale. La mancata denuncia delle responsabilità di Pietro Badoglio a Caporetto gli valse poi l’appoggio del nuovo comando supremo, che lo destinò al comando della 6ª armata sull’Altopiano dei Sette Comuni. Mantenne questo incarico fino al termine della guerra e, in una zona che conosceva molto bene, sostenuto da ottimi collaboratori, combatté più che egregiamente la battaglia del Solstizio, infrangendo fin dal primo giorno ogni velleità offensiva del generale austriaco Franz Conrad. Concorse quindi all’offensiva finale, con un’azione che ebbe il merito di tagliare la via della ritirata alla maggior parte delle forze che lo fronteggiavano.
Lasciò il comando dell’armata, alle cui dipendenze aveva avuto notevoli aliquote di forze francesi e inglesi, il 1° luglio 1919 con il titolo di cavaliere di gran croce, attribuitogli il 24 maggio 1919 per l’intera azione esercitata al comando di truppe interalleate. Il clima politico del dopoguerra e gli echi di Caporetto oscurarono i successi dell’ultimo anno di guerra, provocando anche la messa a disposizione di Montuori nel 1919. L’avvento al potere del fascismo mutò decisamente la situazione e nel febbraio 1923 tornò in auge, fu promosso generale d’armata e incluso nel Consiglio d’esercito.
All’interno di questo organismo, fedele alla sua impostazione, mantenne un profilo defilato e decisamente conservatore: fu così tra gli oppositori del nuovo ordinamento destinato ad ammodernare l’esercito proposto dal generale Antonino Di Giorgio. Nei quattro anni successivi restò al comando d’armata e nel 1927 fu collocato in soprannumero. Il 12 maggio 1928, con la presentazione di Carlo Petitti di Roreto, arrivò la nomina a senatore del Regno. Sopravvisse alla fine del fascismo e al secondo conflitto mondiale senza mai assumere posizioni di rilevanza sulla scena nazionale. Aderì però alla Repubblica sociale italiana (RSI) e di conseguenza venne fatto decadere da senatore il 31 luglio 1945. Contro quest’ultimo provvedimento avanzò poi, senza successo, istanza di ricorso. Fu sposato dapprima con Annina Fano e quindi con Carlotta Margherita Beyerle. Morì a Genova l’8 marzo 1952.(fonte)
[14] Edoardo Monti (Como, 19 luglio 1876 – 27 ottobre 1958) è stato un generale italiano. Sottotenente di artiglieria nel 1896, frequentò la scuola di guerra e passò nel corpo di Stato Maggiore. Partecipò alla guerra libica del 1911-12 ed a tutta la guerra contro l’Austria, divenendo colonnello nel 1917. Fu successivamente Capo di Stato Maggiore del settore di Tarvisio e della divisione di Gorizia (1921), Comandante del 15º Reggimento artiglieria da campagna (1923) e poi (1926) Capo di Stato Maggiore di Corpo d’Armata di Bari. Generale di brigata nel 1928, fu ispettore di mobilitazione della divisione di Gorizia e nel 1929 passò al comando del corpo di Stato Maggiore. Con il grado di Generale di divisione comandò la 14ª Divisione fanteria “Isonzo” a Gorizia negli anni 1931-34. Trasferito a Cagliari assunse il comando del Corpo d’Armata della Sardegna con il grado di Generale di Corpo d’Armata e lo resse dal 1935 al 1936. In Bologna nel 1937 assunse il comando di quel Corpo d’Armata fino al 17 luglio 1939. Nominato designato d’Armata si trasferì a Como, sua città natale; in Milano assunse il Comando dell’Armata “S”, unità puramente cartacea, incaricata di studiare la difesa del confine settentrionale dal Monte Dolent al Cadore.
L’11 novembre 1939 trasmise allo Stato Maggiore del Regio Esercito una “Memoria operativa nell’ipotesi di violazione della neutralità svizzera da parte della Francia”. Il 15 dicembre 1939 ricevette direttamente da Mussolini l’incarico di sovrintendente alla fortificazione del “Vallo Alpino del Littorio” alla frontiera germanica; all’interno dell’Armata “S” l’ufficio preposto prese il nome di “Comando Presidio Monti”. Nel settembre 1940 il Comando venne sciolto e Monti continuò, sotto forma di consulenza, la sua collaborazione ai nuovi uffici preposti alla costruzione del “Vallo” fino al 19 luglio 1942, quando venne collocato nella riserva. Il 10 settembre del 1942 venne ricevuto a Palazzo Venezia da Mussolini il quale volle complimentarsi con lui, in modo particolare, per la condotta durante l’incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica. Terminato l’importante incarico fu Presidente della Casa militare per i veterani in Turate (CO) fino alla morte. Poco dopo la fine della guerra fece parte di un giurì per indagare sulla responsabilità in ordine alla mancata difesa della piazza di Roma durante i tragici giorni susseguenti l’8 settembre 1943.
Ruolo nella realizzazione del Vallo Alpino. Prima dell’importante incarico di sovrintendente alla costruzione del Vallo Littorio alla frontiera germanica assegnatogli da Mussolini, di cui si è riferito nella biografia, il generale Monti aveva firmato in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito la Circolare 300, emessa il 21 gennaio 1932, con cui approvava le aggiunte e varianti alla Circolare 200 ed alla Circolare 800 compilate dall’Ispettorato dell’Arma del Genio.(fonte)