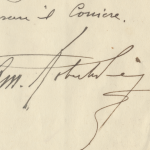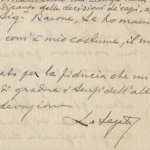PER IL GENERALE D’ARMATA
LUIGI CADORNA
( Lettera aperta a S. E. il Generale Antonino Di Giorgio[1],
Deputato, Ministro della Guerra )
( Estratto dall’ ELBA NUOVA, N. 119 del 5 Ottobre 1924 )
PORTOFERRAIO
TIPOGRAFIA ELBANA
— 1924 —
( Edizione non venale di 250 esemplari )
Per il Generale d’ Armata Luigi Cadorna[2]
Lettera aperta a S. E. il Generale Antonino Di Giorgio
Ministro della Guerra
Caro ed illustre amico,
Mi permetto di chiamarLa così, poichè la Sua benevolenza mi
vi autorizza, e non è oggi il Tenente Volontario di Guerra, che si
rivolge al Generale, ma è l’Italiano che parla al Ministro, ed è
lo Storico che pubblicamente fa noto il suo pensiero all’ illustre
suo Collaboratore e profondo scrittore ed oratore.
Se mi rivolgo a Lei da questa piccola e nobile Elba di napo-
leonica memoria, e dalle colonne di questo indipendente giornaletto
settimanale, anzichè da quelle di un quotidiano di Genova o di
Roma dei quali sono ordinario redattore, gli è che mio precipuo
desiderio è questo : Evitare ad ogni costo — per chi non mi cono-
sca — la più lontana apparenza dello scrittore che voglia far
chiasso, attrarre la pubblica attenzione, speculare sulla notorietà
dell’ Uomo di cui parla e dell’ Uomo al quale parla per far rica-
dere qualche po’ di notorietà anche su sè stesso. D’ altra parte,
penso che sia mio preciso dovere, mandarLe una « Lettera aperta »
e non una « Lettera privata » , anzitutto perchè un Ministro in ca-
rica non deve rispondere ad un letterato, in pubblico ; poi perchè
conosco già il Suo pensiero sul Caso Cadorna, e mentre una let-
tera che Le giungesse per posta sarebbe una indegna ipocrisia ,
vorrebbe cioè farLe ripetere per 1 ennesima volta un Suo giudizio
già noto a tutti gli amici ed estimatori di Cadorna, a tutti i
Generali italiani, a tutti i giornalisti per poco che siano bene
informati .
Dunque, vado diritto allo scopo. Molti Italiani, — fra i
più autorevoli perchè in maggioranza possono, ognuno, dire di sé :
Quorum pars magna fui —, stimarono e stimano strano (parlo con
eufemismo! ) che sia tuttora Generale d’Armata e con pensione
da Maresciallo dei Carabinieri, il Capo che mise sul piede di
guerra tutto un Esercito lasciato andare alla malora dal Presidente
Giolitti[3] e dal Ministro Generale Spingardi[4]; il Capo che vinse undici
battaglie; il Capo che condusse a salvamento un enorme Esercito
con una ritirata che sarà, nei secoli, ammirata, — mentre l’ Italia
novera mezza dozzina di Generali d’ Esercito. Per i quali, s’ inten-
de, ho la massima ammirazione (e come non averne per Duci
come Emanuele Filiberto di Savoia – Aosta[5] , come Giardino[6], come
Pecori – Giraldi[7] etc. ?); ma ciò non vieta una ovvia osservazione :
Può egli sostenersi che Diaz, Badoglio, Caviglia e gli altri, usciti
con tanto onore e con tanti onori dalla Guerra, avrebbero potuto
conseguire le loro vittorie, se Cadorna non avesse loro apprestato
il mirabile strumento con cui furon potute strappare le vittorie
del Piave e di Vittorio Veneto ? ( Per chiarire il mio ragionamento
con un parallelo: Orlando avrebb’ egli presieduto nel 1918 il
Consiglio dei Ministri dell’ Armistizio , se nel 1914 Salandra[8] e
Sonnino[9] non avessero , con occhio politico sicuro, indovinata la
strada per la quale dovevano avviare il Paese, e dichiarata la
guerra all’ Austria ? ).
La Vittoria italiana è un blocco, la Guerra italiana non va dal
Novembre 1917 alla giornata di Vittorio Veneto, ma dal 24 Maggio
1915 all’ Armistizio; così come la Francia riunisce in un’ unica
apoteosi Joffre[10] che si ritira dopo Charleroy e vince la prima bat-
taglia della Marna nel Settembre del 1914 con Foch[11] che pone fine
alla guerra, — così l’Italia (almeno l’Italia senza pregiudizî e
senza preconcetti ) riunisce in un sol fascio tutte le sue glorie: Ca-
dorna con Diaz[12], il Duca degli Abruzzi[13] con Thaon de Revel[14].
C’ è gloria per un centinaio di Capi, e il Governo d’ Italia
stenta a distribuirne, equamente, a quattro Uomini che hanno, più
e meglio di Clemenceau in Francia (cui tale elogio è stato decre-
tato solennemente dalla Camera e dal Senato ), bene meritato della
Patria ?
Molto complesse sono le cause (a Lei, illustre Generale, ben
note ) della severità estrema con cui è stato trattato dal Governo
il « Vinto di Caporetto » ; fra i varî elementi, noterò anzitutto
l’ influenza massonica (dovuta alla falsa leggenda di un Cadorna
clericale, mentre Cadorna, come Porro, è stato sempre ed è un
credente: la qual cosa, ch’ io mi sappia, è in Italia ammessa anche
dallo Statuto Albertino, almeno… finchè dura !); noterò poi l’ astio
dei silurati ( molto umano, ma non molto nobile ); noterò finalmente
la piccineria di mente di coloro, che temevano di diminuir la pro-
pria gloria lasciando che si ricordassero i meriti dei loro prede-
cessori. A tutti questi elementi, pare vada aggiunta (se le voci che
corrono sono esatte ) la personale avversione del Capo del Governo,
il quale a Stefania Türr[15] che gli chiedeva giustizia per Cadorna,
avrebbe risposto: « Chiedetemi tutto ciò che volete, fuorchè questo! ».
Sarà bene sgombrare il terreno, subito, di questi impedimenta.
Un giudizio tecnico, dal Capo del Governo, non può pretendersi,
nè egli stesso vorrebbe darlo. Nel suo subcoseiente, forse, un
motivo di « anticadornismo » e’ è, ed è squisitamente (si dice così ,
anche se si tratta di cose dalle quali esula del tutto ogni squisitezza ! )
ed è, dicevo, squisitamente politico: Il Corriere della Sera è cador-
niano, Albertini[16] è per la riabilitazione e per le onoranze a Cadorna;
ergo Mussolini[17] ed il suo Governo (non tutti i Ministri, s’ intende,
poichè sappiamo, ad esempio, ciò che di Cadorna pensano il mio
amico Federzoni[18] e Vostra Eccellenza ) sono contro Cadorna e ri-
mandano alle calende greche ogni resa di giustizia all’ Uomo vene-
rando e al Condottiero grande . Il Presidente del Consiglio, insomma,
sia pure inconsciamente, punisce il Generale reo di esser difeso e
onorato dal Senatore Albertini e dal Colonnello Angelo Gatti[19] sulle
colonne del più letto fra i giornali d’ Italia e del più autorevole
organo dell’ opposizione. Questa non è vana supposizione mia; Le
citerò, Eccellenza, il brano saliente di una lettera di un informa-
tissimo uomo la cui saviezza e la cui esperienza lo pongono al di
sopra di ogni meschino sospetto :
« L’ Italia ha assistito ad un vero e proprio duello fra Musso-
lini ed Albertini; ad un osservatore obbiettivo non è certo sfuggito
un punto caratteristico che, per quanto apparentemente del tutto
estraneo alla grande contesa, è stato psicologicamente un elemento
determinante dell’ atteggiamento morale di Albertini contro Musso-
lini: voglio dire la Questione Cadorna . Chi Le scrive è in grado di
parlarne. E’ ben noto quale grande e profonda passione, e quanta
minore discrezione, Luigi Albertini abbia posto nella difesa e nella
tentata riabilitazione ed apologia di Luigi Cadorna. Agli occhi di
Albertini, il vecchio Condottiere era, ed effettivamente era, vittima
dei Governi imbelli ( Orlando[20], Nitti[21], Giolitti, Facta[22], ma sopra tutti
Orlando e Giolitti) che avevano punito in lui non il vinto di Ca-
poretto o il firmatario del famoso Bollettino, ma l’ organizzatore
dell’ Esercito che aveva rese possibili la guerra e la vittoria. Nella
rigidità del suo spirito , Albertini non vide la inopportunità del
momento scelto per quell’ apologia, per quanto giusta in sè. Il suo
cuore non era meno impegnato che il suo amor proprio. Il duro
Comunicato ufficiale che sconfessò le onoranze a Cadorna e che era
inutilmente troppo duro, fu per Albertini un colpo della cui acer-
bità pochi, forse, si resero conto. Come molte persone chiuse,
Albertini è un criptosentimentale. Da quel giorno, ogni possibilità
di riavvicinamento fra lui e Mussolini fu distrutta. Questo fu veramente
l’ incidente, piccolo in sè, che produsse la rottura irrimediabile .
Forse lo stesso Albertini non se ne rende pienamente conto e ne-
gherebbe che sia così, ma coloro che lo conoscono da vicino sanno
bene che così è. Ogni storia dei rapporti tra i due uomini, il Pre-
sidente Mussolini e il Senatore Albertini, deve quindi tener conto
della Questione Cadorna » .
Chi mai rammenta il testo di quell’ « inutilmente duro » Co-
municato Volta ? Forse anche Lei , Eccellenza , ne ricorda il senso ,
ma non le parole . Lo riferisco quindi testualmente :
« Roma, 18 Maggio 1923, notte. L’ Agenzia Volta comunica:
Negli ambienti autorizzati si giudica alquanto inopportuno che
venga risollevata a fondo la Questione Cadorna, come pare sia
intenzione di qualche giornale e di qualche gruppo. Per quanti
meriti si vogliano attribuire a quegli che ebbe la responsabilità e
l’ onore di preparare e di condurre la nostra guerra dai giorni
dell’ intervento a quelli del Piave, non si può facilmente dimenti-
care che il nome di quest’ uomo è anche legato a due sciagure del
nostro Esercito , e non può non suonare amaramente al cuore della
grande maggioranza degli Italiani. Inoltre , coloro i quali esaltano
la figura di questo Generale sono pregati di rendersi conto che ,
eccedendo nei loro propositi , possono dar luogo ad una naturale
ed adeguata reazione da parte di quanti , invece , giudicano molto
severamente. l’ opera di tale Condottiero. Se un giudizio di revisione
dovrà avvenire, soltanto la Storia potrà farlo, e coloro che
verranno dopo di noi ( sic ! ) ; non si può essere a un tempo testi-
moni e giudici. In conclusione, nelle sfere governative non si
nasconde per nulla il pensiero che la questione debba essere posta
senz’ altro a tacere e che un elementare senso di patriottica disci-
plina debba indurre i fautori del Generale Cadorna a rientrare nel
più assoluto riserbo » .
Lo stile non è militare ; è anche una pagina alquanto sgram-
maticata. Un Senatore , il Prof. Pantaleoni[23] , ha pubblicamente di-
chiarato ( nè fu mai smentito ) che il testo di un così ignobile
Comunicato fu inviato alla Stampa senza che Mussolini l’ avesse
Visto , così come lo aveva redatto il Capo dell’ Ufficio Stampa alla
Presidenza del Consiglio, Comm. Cesare Rossi[24], attualmente dete-
nuto a Regina Coeli sotto l’ imputazione di omicidio nella persona
dell’ on . Matteotti[25].
Può l’Italia, Eccellenza, tollerare che il Conquistatore di Go-
rizia e l’Uomo che fermò l’invasione austro – tedesca al Piave
senza bisogno di consigli e di lezioni d’ energia dell’ allor Generale
Foch, stia un giorno di più sotto il peso della condanna inflittagli
da un uomo che tutta Italia sospetta essere mandante in un assas-
sinio politico? Può un Governo lasciar chiamare ancora due scia-
gure del nostro Esercito la gloriosa fermata dell’invasione austriaca
ad Asiago con l’immediata susseguente vittoriosa offensiva su Go-
rizia, e l’ancor più magnifica fermata della nuova invasione al
Piave, lì dove provvidenzialmente l’ Eccellenza Vostra chiuse, a
salvezza della Patria, la falla che, con la sua inqualificabile len-
tezza nella ritirata, aveva lasciata aperta nel fronte italiano il Ge-
nerale Senatore di Robilant[26] ?
Dal Maggio del 1923 al Settembre del 1924, per sedici mesi, non
solo la Stampa, ma la Storia ha dovuto tacere. La parola d’ ordine
veniva dal Viminale . S’ immagini, Eccellenza, che quando il mio
indipendentissimo e coraggiosissimo amico , il fine poeta Mario Maria
Martini[27] , pubblicò nella sua Rivista genovese Le Opere e i Giorni ,
una serie di articoli miei sul Mistero di Caporetto in cui contrap-
ponevo la Storia alla Leggenda, e quando comunicò parte delle
bozze al Corriere Mercantile di Genova, il futuro deputato Corrado
Marchi , allora Direttore del foglio , forse per non guastarsi le sim-
patie di Cesare Rossi che doveva poco dopo ( onore che nessuno
gl’ invidia! ) includerlo nel famoso « listone » elettorale, rispose al
Martini: « Per Cadorna, la consegna è di tacere ». Bel modo di
ragionare ! Se la maggioranza degl’ Italiani era, a detta del Comu-
nicato, già contraria al Cadorna, che danno poteva mai fare la
discussione storica ed obbiettiva dei fatti ?
D’ altra parte il Comunicato « si dava la zappa sui piedi » ;
diceva esso, con poca grammatica ma molta incongruenza, che
« solo la storia e la posterità potranno fare un giudizio di revisione »
per i responsabili di Caporetto, e che « non si può essere a un
tempo testimonî e giudici » , ma viceversa negava agli storici im-
parziali lo studio delle fonti (e incanalava in tal via anche l’ Uf-
ficio storico del Ministero della Guerra, argomento questo sul quale
tornerò in separata e più adatta sede ! ), studio senza il quale i
posteri dovrebbero dunque sentenziare senza « l’ escussione dei testi » ;
ma viceversa faceva , esso Ufficio Stampa della Presidenza del Con-
siglio, « a un tempo da testimone e da giudice »; e mi spiego .
Come Ella sa, Eccellenza, i responsabili di Caporetto sono tre Co-
mandanti di Corpo d’ Armata ( Badoglio[28] , Bongiovanni[29] , Cavaciocchi[30] ) ,
un Comandante d’ Armata ( Capello[31] ) e un Comandante Supremo
( Cadorna ). Se fosse sincero il Comunicato lì dove dice che per
Caporetto non si può essere, cioè il Governo non può essere, te-
stimone e giudice, il Governo avrebbe dovuto mandare a riposo ,
in blocco, î cinque responsabili, dicendo manzonianamente : « Ai po-
steri l’ ardua sentenza ». Invece due ne promuove ( Badoglio a Capo
di Stato Maggiore, a Generale d’ Esercito, a membro del Consiglio
Militare Supremo, ad Ambasciatore, ed è il più gravemente compro-
messo per Caporetto !; Bongiovanni a Governatore della Cirenaica
come Tenente Generale richiamato in attività di servizio ) e tre ne
mette — « inequivocabilmente » condannati — a riposo: Cadorna,
Capello, Cavaciocchi ( la sillaba iniziale Ca pare fatale ; l’ iniziale
B pare un porte – bonheur ! ).
Ora tutti gl’ Italiani di buon senso domandano, Eccellenza, la
revisione della sentenza sfavorevole ai tre condannati all’ ostraci-
smo, e la revisione dell’ altra sentenza favorevole ai due promossi.
Tanto più che nell’ Esercito, e quindi nel Paese, pochissimi sono
— fra gli autorevoli, fra i competenti — convinti della colpa o
dell’ inettitudine di Cadorna, ma moltissimi ( la quasi totalità ) sono
arciconvinti del grave errore di Badoglio. Il quale, dopo Caporet-
to, ha scritta una bella pagina di storia militare; ma se si tien
conto di questa per assolverlo e per promuoverlo, perchè non
tener conto delle undici vittorie anteriori del conte Luigi Cadorna?
Ma ce’ è un punto, Eccellenza, sul quale, per quanto ciò mi
riesca doloroso , io debbo insistere : ed è il danno enorme che la
nostra ingratitudine verso Cadorna ci arreca all’ estero. Non io ,
illustre Generale, posso supporre che Ella ignori la campagna di
denigrazione cui siam fatti segno , dal giorno dell’ intervento in
poi, oltr’ Alpi. All’ Istituto di Francia, presente il Maresciallo Pétain
che approvava, un professore universitario francese, insegnante a
Poitiers, ha osato parlar di vittoria italiana dovuta agli aiuti
francesi. Dunque : dal 1915 al 1917, Cadorna per il trionfo della
Intesa ha fatto poco o nulla, come dimostra il Comunicato Cesare
Rossi; dal Novembre 1917 al Novembre 1918 Diaz ha fatto ancor
Meno , come dimostra l’ alto parere di Pétain[32] ( che parla , del resto ,
per « udito dire », chè in quei mesi era in tutt’ altre faccende af-
faccendato, non in Italia ma in Francia, dove Ludendorff è stato
sul punto di sfondarlo! ). Distrutte le glorie , distrutti i meriti di
Cadorna e di Diaz, è logico che le « pretese » — per modeste che
siano — dell’ alleata Italia sembrino, in Francia e altrove, ecces-
sive.
Il Duca Thaon de Revel, che è un gran diplomatico oltrechè
un grande Ammiraglio ed un ottimo Ministro, quando ha visto che
la Francia faceva suo il merito del salvataggio dell’ Esercito serbo
posto in rotta dagli Austriaci e trasportato in Italia dalla flotta del
Duca degli Abruzzi, ha messo uno stop militaresco al dilagare
dell’ insulsa e malevola leggenda, proponendo a Sua Maestà di
concedere all’ Ammiraglio in Capo salvatore dei Serbi la più alta
onorificenza dell’ Ordine Militare di Savoia , con una motivazione
che non permetteva agl’ invidiosi di insistere sull’ ingrato e ingiu-
sto vanto a nostro danno. Il Duca della Vittoria, Diaz, non ha
creduto fare altrettanto per Cadorna. Me ne rincresce per la sim-
patica figura del vincitore. Ma Vostra Eccellenza, che ha visto
all’ opera il Cadorna, che ne ha seguita la mirabile attività bellica
per ventinove mesi, senza contare lo. straordinario lavoro prepara-
torio prebellico, troverà, certo, modo di far sapere all’ Estero che
l’Italia non è ingrata verso Cadorna, e che 1’ opera di Lui non è
di quelle che ammettono denigratori, sian pure illustri come Foch .
Oggi, del resto, ci troviamo innanzi ad una contraddizione ,
per la quale gl’ Italiani debbono essere, senza ritardo, tratti dal
dubbio fattosi incubo. Nel Maggio 1923 il Presidente del Consi-
glio o chi per esso demanda ai posteri il giudizio sul Cadorna e
chiede ai « fautori del generale » il «< più assoluto riserbo ». Idem
il Ministro della Guerra d’ allora ( Diaz ). Nel Settembre del 1924,
alle feste nazionali, italiane, fatte a Pallanza al Generale Cadorna,
lo stesso Presidente del Consiglio si fa rappresentare dal Prefetto .
Non c’è, dunque, più bisogno di aspettare…i posteri. Dal « ri-
serbo » è uscito lo stesso Mussolini. E Vostra Eccellenza si è fatta
rappresentare dal Generale comandante le truppe della regione, alle
onoranze tributate al Capo del quale solo sedici mesi fa si diceva
ufficialmente essere il suo nome « legato a due sciagure del nostro
Esercito ».
Siccome il Generale Di Giorgio, eroico combattente in Libia
e in Italia, non è di quelli che posson patir di simpatie per coloro
che causano sciagure al nostro Esercito, si può dedurne che il
Ministro attuale della Guerra, facendosi rappresentare da un Te-
nente Generale in attività di servizio alle cerimonie di Pallanza ,
ha ormai deciso in senso tutt’ altro che sfavorevole a Cadorna
quale possa essere il tanto atteso « giudizio della Storia ». Siccome
V. E. è di quelli che non solo scrivon bene di Storia, ma la fanno
bene, incomincio a credere che la revisione della ingiusta condan-
na sia più vicina di quanto potessimo credere l’ anno scorso.
Ad ogni modo , ripeto , non è possibile che il Capo, che il
Condottiero, che il fucinatore di undici vittorie sia e rimanga con-
dannato da un candidato all’ ergastolo .
Cesare Rossi ha detta la sua , nel 1923. Moltissimi Italiani chie-
dono all’ illustre nostro Ministro della Guerra che dica la sua ,
decedente il 1924.
Creda , caro ed illustre amico , alla profonda stima del Suo
devotissimo
Alberto Lumbroso[33]
Note
[1] Antonino Di Giorgio. Nato a San Fratello (Messina) il 22 sett. 1867 da Ignazio e Giuseppina Faraci in una famiglia di media borghesia di professionisti e proprietari terrieri, nell’ottobre 1882 fu ammesso come allievo nel collegio militare della “Nunziatella” di Napoli, dove compi gli studi liceali. Vinto il concorso di ammissione all’Accademia militare di Modena, vi entrò il 1° ott. 1886, e il 6 ag. 1888 conseguì il grado di sottotenente di fanteria. Prese servizio a Pescara nel 77° reggimento di fanteria; tenente nel 1892, alla fine del 1895 partì volontario per l’Eritrea, dove partecipò alla battaglia di Adua come ufficiale addetto al comando del 6° reggimento (colonnello C. Airaghi) della brigata Dabormida, dimostrando nel combattimento e nella difficile ritirata un coraggio e un’energia premiati con una medaglia di bronzo. Una seconda medaglia di bronzo ricevette per avere brillantemente condotto al fuoco una centuria di ascari nello scontro di Aga-à del 2 maggio 1896; poi una malattia infettiva lo costrinse a rientrare in Italia, dove riprese servizio nel 77° reggimento.
Sulla sua esperienza africana tornò nel 1899 con un articolo sulla Rivista politica e letteraria che, in polemica con le memorie del generale O. Baratieri, difendeva il comportamento delle truppe ad Adua e indicava nel comandante in capo il principale responsabile della disfatta; nel 1901 scrisse poi una bella Prefazione alla raccolta di Scritti vari (Città di Castello) del colonnello C. Airaghi, caduto ad Adua, mettendone in luce il carattere e la cultura, elementi fondamentali per l’esercizio del comando.
Dopo aver frequentato con successo la Scuola di guerra di Torino, fu ammesso nel corpo di stato maggiore e nel 1902 promosso capitano a scelta; prestò servizio nel 19° reggimento di fanteria, poi dal 1904 al 1907 presso il comando del VII corpo d’armata di Firenze, infine, maggiore a sceka eccezionale nel 1907, nell’89° reggimento di fanteria.
In questi anni sviluppò ricerche storiche sul Risorgimento scrivendo sulla Rivista (poi Rivista moderna) politica e letteraria sul generale austriaco L.A. v. Benedek nel 1899, pubblicando Il generale Manfredo Fanti (Firenze 1906), e partecipò alle polemiche provocate dal movimento degli ufficiali “modernisti” con il libretto Il caso Ranzi e il modernismo nell‘esercito (Firenze 1908), in cui sosteneva la necessità di una disciplina severa e consapevole e condannava duramente ogni forma di organizzazione politica o sindacale degli ufficiali, pur riaffermando il loro diritto-dovere a partecipare come cittadini alla vita politica e culturale nazionale, nei limiti del giuramento di fedeltà prestato al re e alle istituzioni.
Nell’aprile 1908 il D. fu scelto per il comando delle truppe del Benadir, dove stava prendendo sviluppo l’occupazione italiana, seguita con interesse dall’opinione pubblica. La mancanza di una chiara delimitazione di responsabilità e dipendenze deterininò subito un insanabile contrasto tra il governatore del Benadir Tommaso Carletti, che intendeva continuare a dirigere personalmente una politica di penetrazione progressiva non aliena da compromessi con i capi somali, e il D., fautore di una politica di forza (per la quale aveva l’appoggio del ministero della Guerra, che aveva potenziato le truppe affidategli) e convinto di essere l’unico giudice e responsabile della sicurezza della colonia e delle operazioni militari. Dopo aver riordinato le sue otto compagnie di ascari (metà eritrei, metà arruolati nella penisola araba) e curato l’organizzazione logistica, il D. estese l’occupazione italiana a tutta la regione del basso Scebeli, con una serie di scontri vittoriosi con le popolazioni somale; fu però accusato dallo stesso governatore di aver esagerato in durezza con la distruzione di interi villaggi e massacri indiscriminati.
Le polemiche, che trovarono larga eco nella stampa nazionale e in Parlamento, provocarono il rimpatrio del D. in novembre e del Carletti nel dicembre 1908 e penosi strascichi politici e giudiziari. Il D. fu assolto dalle accuse di eccessivo rigore, prima da una autorevole commissione governativa d’inchiesta, poi da una commissione militare, ma condannato dal Consiglio dei ministri nel settembre 1911 a due mesi di fortezza per “contegno indisciplinato” verso il governatore; ottenne per altro in tempestosi processi la condanna per diffamazione del suo principale accusatore, il noto giornalista Giuseppe Piazza della Tribuna, acquistandosi molta popolarità nell’esercito per aver difeso le prerogative dei militari contro l’amministrazione giolittiana.
In Italia il D. riprese servizio nell’89° reggimento di fanteria e con esso partì per la Libia nel dicembre 1911. Il suo comportamento alla testa del suo battaglione nei combattimenti sul Mergheb tra fine febbraio e primi di marzo 1912 gli valse la croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia. Tenente colonnello in giugno, fu decorato di medaglia d’argento per il brillante spirito offensivo dimostrato in agosto alla testa di una colonna di truppe eritree. Rimpatriò a fine 1912 e nel 1913 si presentò alle elezioni politiche nel collegio di Mistretta (Messina) con un programma nazionalista e fieramente antigiolittiano; eletto deputato, alternò il servizio nell’89° reggimento con un’attiva partecipazione ai lavori parlamentari. Nel marzo 1915 L. Cadorna, che molto lo stimava, lo volle tra i suoi collaboratori diretti; ma il D. (colonnello in luglio) chiese un comando attivo e fu destinato all’VIII corpo d’armata come capo di stato maggiore.
Il 1° apr. 1916 il D. assunse il comando della brigata Bisagno di nuova formazione, che condusse nei combattimenti in Trentino, particolarmente nei vani, sanguinosi attacchi di luglio alle munitissime posizioni austriache del Cimone d’Arsiero e del Tonezza, che (come ebbe più tardi a scrivere il D.) attestavano lo slancio e l’obbedienza dei soldati assai più che la preveggenza e capacità dei comandi superiori. A fine agosto il D. (ormai brigadiere generale e poi maggior generale nel dicembre successivo) ebbe il comando del IV raggruppamento alpino, su otto battaglioni alpini, che preparava l’offensiva detta poi dell’Ortigara, fermata però dall’arrivo anticipato delle nevi invernali. Il D. continuò a lavorare per l’offensiva (con qualche breve viaggio a Roma per i lavori parlamentari, dove ebbe accenni assai duri verso quella che giudicava la debolezza del governo), ma quando nel giugno 1917. Poté sferrarla, gli interventi dei comandi superiori e l’energica resistenza austriaca fecero si che i suoi battaglioni fossero massacrati senza successo sull’Ortigara, in una delle battaglie più tristemente note del conflitto. L’opera di comando del D. fu ugualmente apprezzata e alla fine di agosto egli fu promosso alla testa della 51ª divisione in Valsugana. All’indomani dello sfondamento di Caporetto, il 27 ottobre, il Cadorna gli affidò il comando di un improvvisato corpo d’armata “speciale”, su quattro piccole brigate, che doveva proteggere la ritirata della 2ª armata e in primo luogo difendere i ponti del Tagliamento per consentire il deflusso delle truppe.
Il D. svolse la difficile missione con energia e il 10 novembre, quando il corpo d’armata speciale fu sciolto, nonostante la sua scarsa anzianità gli venne affidato il comando del XXVII corpo d’armata destinato a giocare un ruolo essenziale nella difesa del Grappa.
Il D. tenne il comando di questo XXVII corpo fino al termine della guerra (anzi fino al suo scioglimento nel giugno 1919), prendendo parte alla prima e più dura battaglia del Grappa (novembre-dicembre 1917), poi alla battaglia del Piave sulle posizioni del Montello (giugno 1918) e infine alla vittoriosa avanzata di Vittorio Veneto, dando sempre eccellente prova e conseguendo (tra le altre decorazioni) le croci di grande ufficiale dell’Ordine militare di Savoia e di commendatore dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, oltre alla promozione a tenente generale.
Nel dopoguerra il D. non ebbe comandi attivi, ma rimase a lungo in aspettativa e poi a disposizione del ministero, non solo perché assorbito dalla battaglia politica, ma anche perché la sua scarsa anzianità rendeva difficile affidargli un comando di corpo d’armata nel momento della riduzione dell’esercito e dei generali in servizio. Partecipò con autorità al dibattito parlamentare su Caporetto e la condotta della guerra del settembre 1919; poi fu rieletto deputato a Messina in una lista di Destra, continuando a battersi su posizioni nazionaliste in difesa della guerra e per una politica di prestigio, ma senza simpatie per il dannunzianesimo (nell’avventura di Fiume colse soprattutto la lacerazione della disciplina e dell’unità dell’esercito) e per il primo squadrismo. La scarsa consonanza con il clima politico lo indusse a non ripresentare la sua candidatura nelle elezioni politiche del 1921. Il 6 febbr. 1922 sposò Norina Whitaker, appartenente a famiglia anglo-siciliana di alto censo e prestigio, diradando i suoi impegni pubblici.
Il D. tornò ad interessarsi attivamente di politica nella seconda metà del 1923, manifestando piena adesione alla restaurazione condotta da Mussolini, col quale stabili rapporti di stima e fiducia grazie alla mediazione dell’amico L. Federzoni. Ebbe una parte di rilievo nella preparazione del successo elettorale del “listone” governativo in Sicilia nell’aprile 1924; e si presentò candidato egli stesso, come indipendente, perché (come dichiarò apertamente) la sua condizione di ufficiale gli impediva di accettare una tessera di partito. Fu eletto e subito nominato ministro della Guerra (30 aprile 1924) dalla concorde designazione di Diaz, che lasciava l’incarico per ragioni di salute, e di Mussolini, che aveva bisogno di un generale gradito al re e all’esercito, leale verso il fascismo e disposto a accettare un bilancio di economie.
Come ministro della Guerra, il D. difese con energia l’autonomia e il ruolo dell’esercito anche verso il fascismo, vietò esplicitamente agli ufficiali di fare politica, si battè per ridurre il peso della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e ottenne la riabilitazione del Cadorna (promosso maresciallo d’Italia con Diaz il 4 nov. 1924), rendendosi inviso al partito fascista; nel medesimo tempo appoggiò con fermezza il governo Mussolini in tutta la crisi 1924-25, fino a consegnare alla milizia centomila fucili all’indomani dell’assassinio di Matteotti.
Propose poi un nuovo ordinamento dell’esercito, che prevedeva di mantenere in efficienza per tutto l’anno un numero limitato di reggimenti, mentre gli altri, dopo quattro mesi a ranghi completi, sarebbero stati ridotti a quadro, con il congedamento di gran parte della classe di leva e un sensibile risparmio di spesa. Il progetto, portato avanti dal D. con intransigente asprezza, incontrò la decisa resistenza di quasi tutti gli alti comandanti e delle opposizioni liberali e non fu sostenuto dal partito fascista, tanto che all’inizio di aprile 1925 Mussolini troncò il vivacissimo dibattito in Senato sconfessando il D. e, dopo le sue immediate dimissioni, assumendo personalmente il dicastero della Guerra.
Profondamente amareggiato, il D. lasciò la vita politica e riprese servizio come comandante del corpo d’armata di Firenze e poi, nell’agosto 1926, di Palermo.
Messosi in urto con il prefetto Cesare (poi Primo) Mori, che accusava di eccessiva spregiudicatezza nella lotta contro la mafia, nel maggio 1928 lasciò il servizio attivo e si ritirò a vita privata, dedicandosi anche alla stesura di studi e ricordi di guerra.
Il D. morì a Palermo il 17 apr. 1932.
Si ricordano del D., pubblicate in parte postume: La battaglia dell‘Ortigara, Roma 1935; Scritti e discorsi 1899–1927, a cura di N. Di Giorgio, Milano 1938 (che raccoglie i testi più significativi della sua vita politica e militare e dei suoi studi storici); Ricordi della grande guerra 1915–18, a cura di G. De Stefani e per iniziativa della Fondazione Whitaker, Palermo 1978 (che presenta le memorie di guerra rimaste incompiute e alcuni scritti ripresi dal precedente volume del 1938). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[2] Luigi Cadorna. Nato a Pallanza il 4 sett. 1850, unico figlio maschio del generale Raffaele e di Clementina Zoppi, divenne allievo a dieci anni del Collegio militare di Milano, a quindici dell’Accademia militare di Torino; ne uscì nel 1868 primo classificato e sottotenente nel corpo di Stato Maggiore, e passò subito alla Scuola di guerra, dove rimase fino alla promozione a tenente nel 1870. Prestò servizio in un reggimento di artiglieria da campagna, poi al comando della divisione di Firenze, tenuto allora dal padre; capitano nel 1875, fu trasferito a Roma al comando del corpo di Stato Maggiore, dove fu tra i compilatori di varie monografie sul territorio di confine austriaco, che percorse a piedi. Maggiore nel 1883, fu per tre anni comandante di battaglione nel 62º reggimento di fanteria in Alba, poi fu al comando del corpo d’armata di Verona, agli ordini del generale Pianell, che molto lo stimava e lo volle ancora presso di sé come capo di Stato Maggiore della divisione di Verona. Colonnello nel 1892, il C. comandò per quattro anni il 10º reggimento bersaglieri (a Cremona e poi a Napoli), che egli definì il suo più bel comando fino alla guerra; fu poi capo di Stato Maggiore del corpo d’armata di Firenze, dove prestò servizio sotto Baldissera, il più rinomato dei generali italiani.
In più edizioni, a partire dal 1898 (ricordiamo quella definitiva del 1907, stampata a Napoli), diede alle stampe un libretto sulla tattica e l’istruzione della fanteria, intitolato appunto Istruzione tattica, che nel suo nucleo centrale risaliva a un articolo già pubblicato sulla Rivista militare ital., XXXIII (1888), pp. 5-22. In queste pagine osservava che un movimento offensivo si sarebbe sempre risolto in un attacco frontale, reso costosissimo dalle moderne armi se non ben preparato e condotto; riteneva però che il coordinamento delle varie armi, lo sfruttamento del terreno da parte delle catene di tiratori avanzanti e una fredda determinazione del comandante avrebbero permesso di effettuare con successo anche un attacco frontale. Erano però necessari comandanti autorevoli, quadri affiatati, truppe disciplinate: e appunto all’istruzione dei reparti era dedicata l’ultima parte, in cui si raccomandavano esercitazioni di quadri a partiti contrapposti sul terreno e sulla carta. Il libretto fu assai favorevolmente accolto da esperti ufficiali, fra cui il Baldissera, che ebbe parole di elogio per l’autore. Nel 1902questi pubblicava sulla Rivista militare ital. (XLVII, pp. 1783-1835, 1931-1970, 2131-2181)uno studio Da Weissemburg a Sedan nel 1870, in cui veniva discussa la condotta tattica dei reparti prussiani nella guerra con la Francia.
Maggiore generale nel 1898, il C. comandò per sette anni la brigata Pistoia ad Alessandria e poi all’Aquila; tenente generale nel 1905, ebbe il comando della divisione di Ancona (1905-07) e di quella di Napoli (1907-09).
Nel 1906-08 si poneva il problema di dare un successore al capo di Stato Maggiore dell’esercito, gen. Saletta, ormai anziano, e il nome del C. era fatto da più parti, tra gli altri dal gen. Baldissera che lo propose per tre volte al re che lo aveva chiamato a consiglio. Giocava contro di lui la sua fama di energia senza compromessi e perciò l’8 marzo 1908 il gen. U. Brusati, primo aiutante di campo generale del re, gli scriveva chiedendogli di smentire le voci che gli attribuivano l’intenzione di non accettare controlli di sorta nell’esercizio del comando. Il 9 marzo il C. gli rispondeva di avere acquisito dal padre la convinzione che l’unità di comando fosse assolutamente necessaria alla vittoria; pertanto, poiché il capo di Stato Maggiore era il comandante responsabile dell’esercito, non doveva tollerare intromissioni nella preparazione di pace e ancor più nelle operazioni belliche, pur facendo salva l’autorità formale del sovrano. Con queste parole egli giocava coscientemente le sue probabilità di successo, perché gli ambienti di corte non avrebbero certo rinunciato a ingerirsi negli affari militari. Poco dopo, infatti, apprendeva la nomina all’alto incarico del gen. A. Pollio, che peraltro doveva dare ottima prova.
Nel 1910 il C. assumeva il comando del corpo d’armata di Genova e, due anni più tardi, era designato per il comando della 2a armata in caso di guerra, con sede sempre in Genova. In questo periodo egli si dedicò all’approntamento delle fortificazioni della frontiera con la Francia e allo studio della cooperazione tra fanteria e artiglieria, che gli appariva necessaria per lo sfondamento delle difese nemiche. Nel 1913 veniva nominato senatore del Regno.
Il 6 luglio 1914 una riunione dei comandanti d’armata lo designava come nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito, al posto del gen. Pollio, scomparso immaturamente il 28 giugno. Il 27 luglio egli assumeva l’alto incarico, mentre stava per scatenarsi la successione delle mobilitazioni generali delle nazioni europee che doveva segnare l’inizio della guerra mondiale. Il giudizio del nuovo capo di Stato Maggiore sull’esercito era duro, e in termini ancora più severi egli si espresse nel dopoguerra, parlando di una crisi morale che aggravava la scarsezza di materiali e l’insufficienza dei quadri. Tuttavia egli non esitò a predisporre le operazioni offensive contro la Francia previste dai piani vigenti, che il silenzio del governo gli faceva credere sempre validi. Dopo la dichiarazione di neutralità il C. chiedeva l’immediata mobilitazione generale, che sola poteva mettere l’esercito in condizione di farsi valere: ad essa si oppose il governo, perché tale provvedimento avrebbe quasi inevitabilmente portato a un prematuro intervento. Non cessando di chiedere una politica di forza, il C. dava mano ai provvedimenti più urgenti per l’esercito, ma solo in ottobre, quando Salandra ebbe reso noto il rinvio dell’intervento a primavera, fu possibile impostare una organica preparazione su larga scala.
Il programma Cadorna-Zupelli, attuato dall’ottobre 1914 al maggio 1915, prevedeva la ricostituzione dei reparti dislocati in Libia e in Albania, pari alla forza di circa quattro divisioni, il completamento dell’equipaggiamento e dell’armamento individuale, la trasformazione delle batterie da campagna da sei a quattro pezzi, tutti a deformazione, la creazione di una modesta artiglieria pesante campale e l’ampliamento del parco d’assedio, la nomina di nuovi ufficiali con corsi accelerati (cui si presentarono molti tra gli interventisti). Contemporaneamente il C. chiedeva la mobilitazione industriale del paese per la guerra, con obiettivi per il momento modesti, e curava la riedizione del suo libretto di tattica (pubblicato a Roma), che nel febbraio 1915 fu distribuito a tutti gli ufficiali, col titolo Attacco frontale ed ammaestramento tattico: l’opuscolo univa ottimi principi a una visione dei combattimenti ormai superata, teneva insufficiente conto della guerra in corso (ma non era sempre facile afferrarne la novità anche per gli stessi combattenti) e incoraggiava, oltre le intenzioni dell’autore, un certo schematismo di mosse, che avrebbe giustificato in ufficiali impreparati l’assunzione a dogma del principio dell’attacco frontale anche dopo sanguinosi insuccessi. Il libretto fu molto criticato nel dopoguerra: in realtà, era tutta la dottrina prebellica che si rivelava superata dalla guerra di trincea.
Il 24 maggio 1915 il C. iniziava le operazioni contro le truppe austro-ungariche con trentacinque solide divisioni e un armamento purtroppo inadeguato alle crescenti esigenze della guerra di trincea. Nei trenta mesi in cui tenne il comando dell’esercito il suo comportamento fu rettilineo, ispirato a principî molto chiari e meditati: la necessità di un’assoluta unità di comando che non ammetteva deroghe né controlli, un elevatissimo senso del dovere che tutto sacrificava alla vittoria, la convinzione che il paese dovesse concorrere allo sforzo bellico con una totale adesione alle richieste dell’esercito in uomini e mezzi. L’impostazione strategica della guerra italiana (cui non contribuirono né il re né il governo, secondo la prassi) era semplice: impegnare il maggior numero possibile di divisioni austro-ungariche e distruggerle. Il C. rifiutava cioè di indirizzare lo sforzo italiano su obiettivi territoriali e intendeva progredire oltre l’Isonzo e le Alpi Giulie verso Lubiana, nella direzione più sensibile per il nemico; concentrò quindi le sue forze nel Friuli, ordinando uno schieramento difensivo nel Trentino e permettendo offensive locali nel Cadore e nella Carnia (che però causarono la dispersione delle scarse artiglierie pesanti). A questo piano si attenne anche quando fu evidente che i guadagni territoriali erano limitatissimi e molto costosi e che la guerra si riduceva a logoramento. Egli indirizzò quindi i suoi sforzi a ottenere nuove truppe e soprattutto nuovi materiali bellici, per rinnovare le “spallate” sull’Isonzo (undici battaglie complessive). Né si lasciò distrarre dall’offensiva austro-ungarica del Trentino (maggio 1916), da cui fu sostanzialmente sorpreso. Arrestate le penetrazioni nemiche con truppe tolte alle riserve, ristabilita una linea italiana, il C. concentrava nuovamente le sue forze sull’Isonzo e strappava al nemico Gorizia (agosto 1916), con la vittoria più sentita dall’opinione pubblica. Nel 1917 rinnovava i suoi assalti oltre l’Isonzo, e con truppe più provviste di mezzi riusciva a ottenere successi considerevoli (battaglia della Bainsizza, agosto del 1917) che spingevano l’Austria-Ungheria sull’orlo del collasso.
Assai ampia ed aderente alla situazione era l’impostazione che il C. dava ai rapporti con gli alleati e i teatri secondari d’operazioni. In contrasto con il governo, egli avrebbe voluto ridurre le forze italiane in Libia e Albania e accrescerle in Macedonia, dove potevano rappresentare un reale pericolo per il nemico. Era pure favorevole al più stretto coordinamento con gli eserciti alleati, cercando nel 1915 l’appoggio dei Russi e dei Serbi, scatenando più di una offensiva concordata con gli Anglo-francesi, proponendo nel 1917 il concentramento degli sforzi dell’Intesa contro l’Austria-Ungheria, punto debole della coalizione nemica. Anche in questi progetti fu osteggiato dal governo, legato a una concezione più ristretta della guerra.
La guerra di trincea era guerra di logoramento, e il C. la condusse con un’energia che non ammetteva ostacoli né debolezze, dando mano a una severa selezione dei quadri (furono esonerati 206 generali e 255 colonnelli) e a un ampliamento dell’esercito senza precedenti. I 548 battaglioni di fanteria del 1915 diventavano 867 nel 1917, con un armamento immensamente superiore (per es. 3.000 pezzi di medio calibro invece di 246 e 5.000 di piccolo calibro invece di 1.772).
Tuttavia egli non seppe ottenere il massimo rendimento da questi nuovi mezzi sul campo di battaglia: le truppe furono addestrate solo all’attacco frontale in masse compatte, senza conoscere né avvolgimento né infiltrazione, le grandi unità insufficientemente amalgamate per i continui scambi di reparti e per i siluramenti, trasferimenti e promozioni di alti ufficiali, troppi comandanti giudicati solo sull’energia con cui sapevano ributtare truppe esauste ad un ennesimo assalto. Inoltre il C. chiuso in una aristocratica concezione del dovere, non comprendeva tutte le esigenze molteplici del nuovo esercito formato da milioni di soldati semimprovvisati; egli aveva del combattente e della sua disciplina una concezione troppo rigida e astratta, che lo portava a non curare abbastanza il benessere materiale e morale delle truppe (turni di riposo, vitto e licenze, propaganda sugli scopi di guerra, assistenza alle famiglie, ecc.) e a sospettare mene sovversive e disfattistiche in ogni segno di stanchezza. E così, dinanzi a casi di ribellione o di cedimento di reparti nel 1917, il C. non si soffermava sulla tremenda tensione cui gli uomini erano sottoposti, ma ordinava fucilazioni sommarie e denunciava l’attività dei partiti contrari alla guerra e la debolezza del governo. In realtà, egli era tremendamente solo nella condotta della guerra: il dogma dell’unità di comando lo portava infatti a non volere intorno a sé collaboratori troppo autorevoli, con i quali suddividere le responsabilità, e a non accettare controlli né consigli, neppure quelli assai timidi del re. Al Comando supremo il gen. Porro, sottocapo di Stato Maggiore, era confinato in incarichi secondari e tutto il lavoro gravava su di un pugno di giovani ufficiali, di grande valore, ma privi di autorità ed esperienza, nessuno dei quali aveva comandato un reparto in trincea. Ne derivava l’isolamento del C., privo di contatti con la truppa, non assistito da un adeguato servizio di informazioni, spesso non in grado di assicurare l’esecuzione dei suoi ordini. Si noti infatti che alcuni dei più gravi errori tattici, come la continuazione degli attacchi contro un nemico ormai rinfrancato, avvenivano contro le intenzioni del C., il quale, non disponendo di ufficiali di collegamento e di dipendenti più affiatati, poteva più facilmente esonerare un comandante che controllarne l’operato. In complesso, egli aveva saputo formare un esercito immenso, armarlo con relativa ricchezza e guidarlo con fermezza e fede, ma non comprenderne appieno tutte le debolezze e le caratteristiche e quindi non valorizzarne tutte le risorse.
I rapporti tra Comando supremo e governo, poi, furono male impostati e peggio sviluppati. Prima del conflitto si riteneva inevitabile una netta separazione di responsabilità tra potere politico e potere militare: a questi principi s’ispirarono il C., Salandra, Sonnino, Boselli, anche quando l’estensione crescente dello sforzo bellico ne dimostrava la fallacia. E già si è detto che il piano di guerra venne elaborato senza ingerenze politiche, mentre il patto di Londra e le operazioni oltremare furono condotte senza richiedere né accettare il parere del capo di Stato Maggiore. Questi si veniva quindi confermando nell’opinione che a lui solo spettasse segnalare il fabbisogno dell’esercito in uomini e materiali, e che il governo non dovesse che adeguarvisi; e in realtà la lentezza con cui gli uomini politici responsabili afferravano il carattere totale e le nuove esigenze del conflitto impediva loro di rivendicare l’effettiva direzione della guerra. Nel vuoto di potere si inserì quindi l’azione decisa del C., che diede impulso allo sforzo nazionale e alla mobilitazione industriale esautorando il ministero della Guerra. Contemporaneamente egli impediva al governo qualsiasi ingerenza nella condotta delle operazioni e alle sue spalle sviluppava contatti con elementi politici interventisti, per imprimere più vigoroso ritmo alla preparazione bellica.
Grandi campagne di stampa ne innalzavano la figura, con un’esaltazione sempre meno misurata: la sua posizione poteva così essere travisata al punto che, nell’estate 1917, gli veniva chiesto di capeggiare un colpo di Stato di estrema destra per instaurare una dittatura militare capace di portare alla vittoria. Il C. rifiutava, ma l’episodio non poteva certo migliorare i suoi rapporti col governo. Si alimentava una incresciosa situazione di sfiducia reciproca, che trovava espressione nelle lettere con cui il C. nel giugno-agosto 1917 rigettava sulla debole politica interna di Orlando la responsabilità degli episodi di indisciplina e stanchezza verificatisi tra le truppe.
Il 24 ott. 1917 la 14a armata austrotedesca sfondò le linee italiane, e da Caporetto progredì rapidamente verso la pianura veneta. L’offensiva non giungeva inattesa al Comando supremo, che il 18 settembre aveva diramato istruzioni di massima per il passaggio allo schieramento difensivo; ma assolutamente imprevista fu la rapidità dell’avanzata nemica, che toglieva alle lontane e scarse riserve strategiche italiane la possibilità di un efficace intervento. Senza soffermarsi ad analizzare le molteplici cause del crollo delle linee italiane (in gran parte imputabili ai comandi italiani), il C. attribuì la rotta a uno sciopero militare, a un collasso delle truppe provocato dalla propaganda neutralista, e il 27 ottobre diramò un bollettino (fermato dal governo, ma conosciuto all’estero) in cui si parlava di “mancata resistenza di reparti della 2a armata vilmente ritiratisi senza combattere ed ignominiosamente arresisi al nemico”. Lo stesso giorno telegrafava al presidente del Consiglio: “l’esercito cade non sotto i colpi del nemico esterno, ma sotto i colpi del nemico interno, per combattere il quale ho inviato al governo quattro lettere che non hanno ricevuto risposta”. Contemporaneamente egli esitava a dare l’ordine di ripiegamento, che pure la sorpresa strategica rendeva necessario, e diramava gli ordini relativi solo il 27 mattina. Il ritardo aggravava le condizioni della ritirata, che si svolgeva in crescente disordine. In quei giorni furono confermati i difetti di organizzazione del Comando supremo: il C. si trovò troppo solo, senza informazioni aggiornate sulla situazione (e quindi continuò a credere al collasso di tutta la 2a armata) e senza mezzi per dirigere i movimenti di ritirata (furono perciò possibili gravi insubordinazioni di comandanti, che concorsero ad aumentare le perdite). Ancora il 3 novembre scriveva al presidente del Consiglio: “siamo di fronte ad una insanabile crisi morale”; ma qualche giorno dopo, raggiunto il Piave con l’esercito dimezzato ma ancora valido, egli riprendeva fiducia nei soldati e lanciava l’ordine di resistenza ad oltranza: “nulla è perduto se lo spirito della riscossa è pronto, se la volontà non piega”.
Il suo esonero era però già stato deciso. Il nuovo governo costituitosi il 30 ottobre (Orlando presidente, Alfieri ministro della Guerra) aveva già in animo il provvedimento, più ancora che per la sconfitta (una sostituzione rappresentava un salto nel buio), per la convinzione che col C. non fosse possibile instaurare quella intima collaborazione tra governo e Comando supremo che pareva necessaria. Erano già stati designati Diaz e Giardino col favore del re, ma ogni decisione era stata rinviata nel tempo, per attendere la stabilizzazione del fronte (e quindi il 30 ottobre Orlando telegrafava al C. la sua fiducia). Ma il 6 novembre nel convegno di Rapallo gli Anglo-francesi ponevano come condizione della concessione delle loro truppe la sostituzione immediata del C., cui addebitavano il disordine della ritirata e il cattivo funzionamento del Comando supremo. Il 9 novembre il C. era perciò sostituito con Diaz e nominato membro del Consiglio superiore di guerra interalleato con sede a Versailles. La buona prova del nuovo Comando supremo durante l’ultimo anno di guerra avrebbe finito di comprovare l’opportunità dell’esonero. Accanto ai limiti accennati, è però necessario riconoscere al C. la grandezza della fede, l’ampiezza della visione strategica, la cognizione delle necessità della guerra moderna e infine l’energia con cui condusse due anni e mezzo di sanguinosi combattimenti.
Nel nuovo incarico, accettato solo per senso di dovere, il C. si adoperò con acutezza e larghezza di idee a promuovere una direzione unitaria degli alleati, avendo a colleghi i generali Foch, francese, e Wilson, britannico. Ma il 17 febbr. 1918 fu improvvisamente richiamato in Italia e collocato a disposizione della commissione d’inchiesta nominata dal governo Orlando per far luce sul disastro di Caporetto. Si iniziava così un durissimo periodo in cui il C. sarebbe stato indicato all’opinione pubblica come il principale responsabile della sconfitta e di ogni aspetto doloroso della guerra. Le conclusioni della commissione, apparse a fine luglio 1919, muovevano al C. severe censure, che acquistavano ingiusto risalto dal silenzio con cui si coprivano le responsabilità di altri esponenti militari e politici: e subito nel paese si scatenavano violentissime polemiche di stampa, in cui da entrambe le parti si perdeva il senso della realtà, passando da una vilissima denigrazione dell’ex comandante supremo a una faziosa esaltazione. Con un gesto che implicitamente sanzionava le accuse, nel settembre 1919 il C., che un anno prima era passato in posizione ausiliaria per ragioni d’età, fu collocato a riposo.
Le polemiche non lo indussero a uscire dal suo sdegnoso silenzio, pur se in manifestazioni private egli esprimeva simpatie per i movimenti di ex interventisti. La risposta alle accuse fu affidata ai due volumi di memorie: La guerra alla fronte italiana fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa (Milano 1921), in cui il C. tracciò con chiarezza e limpido stile la storia del conflitto come egli l’aveva vissuto, senza concedere nulla alle polemiche. Alcuni problemi relativamente secondari, concernenti specialmente i suoi contrasti col governo sui teatri d’oltremare, furono poi trattati nelle Altre pagine sulla guerra mondiale (Milano 1925); meno interessanti le Pagine polemiche (Milano 1950), pubblicate postume dai figli, in cui si ribadiva la versione del C. sulla rotta di Caporetto, facendo risalire pur sempre le maggiori responsabilità al governo e alle truppe. Ricordiamo ancora altre opere storiche, come la biografia del padre (Il gen. Raffaele Cadorna nel Risorgimento italiano, Milano 1922), assai ricca di documentazione, e l’introduzione a Le più belle pagine di Raimondo Montecuccoli, da lui raccolte (Milano 1922). Inoltre il volume di Lettere famigliari (Milano 1967), selezione delle lettere degli anni di guerra curata dal figlio Raffaele.
Negli anni del dopoguerra, smorzatesi le polemiche nel paese, la valutazione della figura e dell’opera del C. continuò a essere contrastata: uno schieramento che andava dai nazionalisti al Corriere della Sera e al Mondo si batteva per una completa riabilitazione, mentre fascisti, giolittiani, popolari e le sinistre concordavano nell’avversare un provvedimento che avrebbe loro suonato come glorificazione della guerra regia e non di popolo. Il 4 nov. 1924 Mussolini volle troncare le discussioni sulla guerra nominando il C. e Diaz marescialli d’Italia; poco prima una sottoscrizione nazionale aveva offerto al C. una villa nella sua Pallanza. Egli riprese una attività pubblica in Senato (dove rientrò il 30 marzo 1925 con un discorso contro il ministro Di Giorgio, che fece riproporre il suo nome per i più alti comandi), nell’esercito e con viaggi all’estero.
Morì il 21 dic. 1928 in Bordighera: gli fu eretto nel 1932 un mausoleo a Pallanza. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[3] Giovanni Giolitti. Uomo politico e statista italiano (Mondovì 1842 – Cavour 1928). Segretario generale della Corte dei Conti e poi Consigliere di stato, fu deputato (1882, 1924), ministro del Tesoro (1889-90) e degli Interni (1901-03), presidente del Consiglio (1892-93, a più riprese fino al 1914, 1920-21). Considerato uno tra i maggiori protagonisti della storia unitaria italiana, G. ha dominato la scena politica nel primo quindicennio del Novecento, periodo che è stato definito “età giolittiana”, dando un’impronta liberale alle linee di governo, specie rispetto ai conflitti dei lavoratori.
Laureato in giurisprudenza, lavorò dal 1862 nell’amministrazione statale, dal 1872 come reggente della direzione generale delle Finanze e poi come segretario generale della Corte dei conti. Consigliere di stato dal 1882 su invito di A. Depretis, l’anno stesso poté presentarsi candidato alla Camera e fu eletto deputato a Cuneo. Attivo nel gruppo dei liberali progressisti, seguì con impegno particolare la politica finanziaria, dal 1885 in espressa polemica con il ministro del Tesoro A. Magliani, e nel 1887 sostenne il gabinetto Crispi. Dimessosi Magliani, fu G. ad assumere il ministero del Tesoro (marzo 1889 – dic. 1890) divenendo il leader del partito delle economie nella sinistra liberale. Ciò lo mise in una luce particolare per cui, caduto il governo Rudinì, la scelta del re, sollecitata da U. Rattazzi, cadde su G. per l’incarico di presidente del Consiglio (maggio 1892). Sciolta la Camera e costituita una consistente maggioranza con le elezioni del 1892, a segnare la fine del I gabinetto G. (nov. 1893) intervennero la battaglia parlamentare di Crispi e lo scandalo della Banca Romana, nel quale il presidente del Consiglio venne accusato da un comitato di parlamentari, incaricato di indagare sulle vicende dell’istituto di emissione, di irregolarità commesse allorché era ministro del Tesoro (gli atti d’accusa furono archiviati nel 1895, non prima che G., onde evitare un probabile arresto, si trasferisse in Germania). Con l’inizio del secolo G. prese a occupare un posto di grandissimo rilievo nel quadro politico, tanto che sovente gli storici del secondo dopoguerra hanno parlato del periodo 1901-14 come dell'”età giolittiana”: fu infatti ministro degli Interni del gabinetto Zanardelli (1901-03), durante il quale fu in effetti l’ispiratore della politica governativa, poi presidente del Consiglio per tre lunghi ministeri fino al 1914, interrotti dai gabinetti Tittoni, Fortis e Sonnino (1905-06), e dai gabinetti Sonnino e Luzzatti (1909-11). La politica giolittiana fu orientata verso un “ordinato progresso civile”, che comportava un prudente allargamento delle basi del potere onde permettere una qual certa forma di partecipazione al movimento dei lavoratori; in questa prospettiva egli accentuò – visto anche il fallimento delle politiche puramente repressive dei predecessori – il carattere liberale della linea governativa, cercando di porre lo stato in una posizione neutrale o intermedia nei conflitti di lavoro (negli anni giolittiani ebbe un certo sviluppo anche la legislazione del lavoro). In ambito economico, G. tese a sostenere, con un cauto protezionismo, lo sviluppo dell’industria – in ascesa rispetto a una struttura economica tradizionalmente agraria – pur difendendo il bilancio statale dalle pressioni dei privati. I punti dove maggiormente si diressero le polemiche degli oppositori di sinistra furono la politica meridionale (il protezionismo sul grano sosteneva di fatto il latifondo) e la spregiudicata prassi elettoralistica (in un celebre pamphlet del 1909, G. Salvemini lo bollò come “il ministro della mala vita”), mentre da altri settori (G. Fortunato, L. Einaudi) gli veniva rimproverato l’abbandono del liberismo sul terreno della politica economica (lavori pubblici, protezionismo, legislazione del lavoro, ecc.), e da settori industriali l’acquiescenza nei confronti delle rivendicazioni sindacali. A suo favore G. ebbe la Corona, il socialismo riformista (che conseguì da quella politica un obiettivo impulso e una forte crescita), alcuni settori intellettuali (soprattutto B. Croce) e larghi strati della borghesia. Poté così costruire e mantenere un articolato sistema di potere i cui primi segni di squilibrio si manifestarono verso la fine del primo decennio, allorché si profilò una crisi generale della società e dello stato liberali, attraverso una serie di spostamenti politici significativamente centrifughi: il movimento operaio, posta in minoranza la componente riformista, iniziò a pretendere un più sostanziale coinvolgimento nel potere, i cattolici rivendicavano una presenza non più marginale nello stato, mentre alcuni settori politici e intellettuali ipotizzavano un’organizzazione sociale di tipo corporativo e si diffondeva il movimento nazionalista. G. si rivolse allora al mondo cattolico e strinse nel 1913 un accordo elettorale (patto Gentiloni) che gli avrebbe consentito maggiori spazî di manovra politica; ma anche la Camera uscita dalle elezioni del 1913 (era stata varata una riforma che introduceva un suffragio quasi universale) gli rese difficile l’azione di governo e nel marzo 1914 G. preferì dimettersi. Neutralista, restò ai margini della vita politica per il periodo bellico, ma venne chiamato nel giugno 1920 a costituire il suo quinto ministero, in una situazione in cui il durissimo conflitto politico e sociale segnava la dissoluzione dello stato liberale, rendendo pressoché inesistenti i margini della tradizionale mediazione giolittiana. Sciolta la Camera il responso delle urne gli fu nuovamente avverso e nel giugno 1921 rassegnò le dimissioni ponendo termine alla carriera di statista. Come deputato liberale, dal 1924 fu all’opposizione del governo Mussolini.(fonte)
[4] Paolo Antonio Spingardi. Nacque a Felizzano, presso Alessandria, il 2 novembre 1845 da Paolo, esattore comunale, originario di Bistagno, e da Caterina Abriata.
Dotato di predisposizione allo studio e al calcolo, prescelse la carriera militare – via non infrequente per certa piccola borghesia provinciale piemontese del tempo – per assicurarsi un discreto reddito.
Spingardi entrò allievo alla Scuola militare di fanteria di Modena nell’ottobre del 1864. Nel maggio del 1866 era sottotenente nel 6° reggimento granatieri e partecipò alle ostilità del 1866, poi nel 76° reggimento fanteria (marzo 1871), per passare al tranquillo distretto militare di Verona nel novembre del 1872, dove avrebbe trovato la promozione a luogotenente.
La svolta da una carriera modesta e appartata sarebbe stata impressa dal passaggio al corpo di Stato maggiore nel maggio del 1874 e soprattutto dalla sua destinazione presso il comando di quel corpo nel marzo del 1876. Allo Stato maggiore ricevette la promozione a capitano nell’agosto del 1877 e iniziò a mettersi in vista, come poi sempre avrebbe fatto, «per la sua svegliata intelligenza, l’attività tenace e lo studio» (dalla commemorazione in Senato).
Spingardi passava dalla provincia alla capitale in un momento particolare della storia militare e nazionale: Roma era stata presa da pochi anni e il ministro della Guerra della Destra storica, Cesare Ricotti Magnani, aveva riformato l’ordinamento dell’esercito scegliendo il modello prussiano.
All’opera di efficientamento dell’ordinamento di Ricotti il giovane ufficiale piemontese contribuì con le proprie sempre crescenti competenze e conoscenze, da militare colto e conoscitore della macchina amministrativa. Promosso maggiore nel giugno del 1884, venne comandato prima come professore titolare alla Scuola di guerra (agosto 1886) e poi al Segretariato generale del ministero della Guerra, l’ufficio che sosteneva da vicino le attività del ministro. Nel luglio del 1887 fu nominato capo sezione al ministero e promosso poi a tenente colonnello (ottobre 1888). La sua lunga esperienza amministrativa sarebbe stata interrotta solo dalla nomina (dicembre 1892) a comandante in seconda della Scuola di guerra, dove anni prima aveva insegnato, dove avrebbe ricevuto la nomina a colonnello (aprile 1893) e dove sarebbe rimasto quasi quattro anni. Dovette effettuare, lui che era stato sino ad allora per lunghissimi anni uomo di apparati e di uffici, il prescritto turno di comando di reparto senza il quale la sua carriera si sarebbe fermata. Comandò così il 13° reggimento da fortezza (ottobre 1896) per un po’ meno di un paio d’anni. Venne quindi richiamato al ministero per occupare l’autorevole posto di direttore generale dei servizi amministrativi (giugno 1898), ottenendo in quelle funzioni la nomina a maggior generale (novembre 1899). Ripassò poi presso un reparto (fu comandante della brigata Basilicata, dal settembre del 1900 al novembre del 1903), senza perdere il contatto con la macchina centrale ministeriale. Si era nel frattempo sposato, quarantacinquenne (nel settembre del 1890), con Rina Merialdi, da cui ebbe i figli Camillo (ottobre 1892), Amalia (marzo 1895) e Giuseppe (luglio 1896).
Nel 1903 Giolitti lo chiamò come sottosegretario del suo ministro della Guerra, Ettore Pedotti. Quasi sessantenne, Spingardi – militare di calcoli e parole più che di comando e di azione – poteva vantare come pochi una conoscenza dall’interno della macchina militare. Viste le competenze primariamente amministrative di un sottosegretario, non ci sono provvedimenti che dal novembre del 1903 al dicembre del 1905 possano essere immediatamente ascrivibili al solo Spingardi: ma il semplice fatto di far parte della compagine politica e governativa del secondo gabinetto Giolitti lo qualificava come militare aperto (avrebbe peraltro partecipato alle elezioni politiche del novembre del 1904 nel collegio di Anagni, risultandovi eletto) e progressista. A contrario, conferma tutto questo il fatto che, salito al governo Sonnino una prima volta, Spingardi fu cacciato.
Tornato Giolitti, Spingardi (che per progressione di carriera era intanto stato promosso tenente generale nell’aprile del 1906, dovendo per regolamento abbandonare la Camera) fu intanto nominato a un incarico delicatissimo, per il quale di norma l’assenso reale era necessario: comandante generale dell’arma dei carabinieri (febbraio 1908). Lo sarebbe rimasto poco più di un anno, quando il presidente del Consiglio lo avrebbe chiamato a dirigere il ministero della Guerra nell’aprile del 1909, in un momento particolare, ovvero dopo l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’esercito.
Nel giugno del 1907 Giolitti aveva infatti accettato la costituzione della Commissione che avrebbe dovuto proporre un riassetto dell’amministrazione militare e soprattutto un suo rifinanziamento. E nel dicembre del 1907 aveva chiamato a svolgere le funzioni di ministro della Guerra addirittura un civile (era la prima volta, nella storia del Regno d’Italia, e sarebbe rimasta l’unica sino al 1920) già componente di quella Commissione, il senatore torinese Severino Casana, peraltro privo di precedenti e particolari conoscenze specifiche.
È difficile sottovalutare quanto i militari volessero tornare a vedere, dopo un paio d’anni di questi complessi esperimenti giolittiani, un proprio rappresentante alla guida del ministero. Questo avrebbe dovuto essere un conoscitore della macchina amministrativa, in grado di garantire la crescita del bilancio militare, che pure Giolitti era intenzionato a concedere. Fu in questo quadro che la figura di Spingardi, conoscitore dell’amministrazione militare, ben accetto al re e ben conosciuto da Giolitti, sembrò un’ottima mediazione fra interessi diversi.
L’insolitamente lungo periodo ministeriale di Spingardi alla Guerra (da aprile del 1909 al marzo del 1914), questa volta rimasto in carica nonostante i cambiamenti di governo (da Giolitti a Sonnino e Luzzatti e di nuovo, nel marzo del 1911, a Giolitti), dimostrava molte cose. In primo luogo che il riconoscimento delle competenze personali di Spingardi era condiviso (avrebbe ricordato Vittorio Zupelli, nella commemorazione al Senato che «Fu, dopo il Ricotti, il ministro della guerra che ebbe vita politica più lunga»). In secondo luogo che l’amministrazione militare ricercava una propria stabilità dopo la minaccia della Commissione d’inchiesta e mentre i governi facevano a gara nell’aumentare gli stanziamenti, come avveniva in tutta Europa. In terzo luogo che il re aveva giudicato Spingardi liberale ma moderato, anziano e fidato, atto a rappresentare – nelle convulsioni politiche – un tratto di continuità. In quarto luogo, che questa continuità era, al fondo, giolittiana.
Non è facile riassumere in breve il complesso delle numerose attività di riforma, di spesa, di crescita cui l’esercito andò incontro negli anni di Spingardi. Rimaneva sempre l’esercito dell’ultima delle grandi potenze europee, ma si irrobustì e si rafforzò molto, grazie all’aumento dei finanziamenti. Spingardi sovrintese anche al rafforzamento militare italiano rispetto all’Austria-Ungheria, pur formalmente alleata nella comune Triplice alleanza, il cui comportamento divenne però a ragione sempre più sospetto all’élite politica e diplomatica italiana.
Spingardi fu a suo modo fortunato anche perché guidò il ministero della Guerra, fra il 1911 e il 1912, al tempo del conflitto armato con l’Impero ottomano e con i resistenti locali tripolitani e cirenaici per il controllo della Libia. Giolitti aveva bisogno di un’impresa di prestigio e voleva essere sicuro di non incorrere in un’altra Custoza, Dogali o Adua: i militari erano con lui. Quindi per la Libia si spese molto e si inviarono oltre 100.000 uomini: un numero inconsueto, se si fosse trattato solo di un’operazione coloniale. Interpretando le richieste del governo, Spingardi spronò il comandante locale, generale Carlo Caneva, il quale, conscio delle difficoltà, dopo l’insuccesso iniziale di Sciaria Sciat, aveva adottato un atteggiamento cauto e guardingo, più difensivo che offensivo.
Molta parte dell’opinione pubblica, che tutto questo non sapeva, fu trascinata dai nazionalisti e celebrò la guerra di Libia e l’esercito con toni ditirambici, e con essi il ministro della Guerra.
Di lì a poco Spingardi, che nell’ottobre del 1912 ricevette dal re l’Ordine supremo della Santissima Annunziata, uscì dai ruoli del servizio attivo per superati limiti d’età (ottobre del 1913), rimanendo nella sua carica di ministro; si vide inoltre concessa la medaglia mauriziana per i dieci lustri di servizio militare (aprile del 1913) e fu nobilitato con il titolo di conte (ottobre del 1913). Difficile pensare riconoscimenti maggiori per un uomo che sentiva di aver dato tutto all’istituzione militare.
La fortuna ‘mediatica’ della campagna libica non evitò a Giolitti, com’è noto, l’abbandono della guida del Paese a favore del governo di centrodestra di Antonio Salandra. Nella nuova compagine, evidentemente, non poteva esserci posto per Spingardi.
Con il deteriorarsi del clima internazionale e con l’approssimarsi della guerra, si fecero però sempre più evidenti le crepe nell’ordinamento militare nazionale e il fatto che la Libia fosse costata molto, anzi troppo. Apprezzato sotto Giolitti, Spingardi cominciò con Salandra e Sonnino a essere il bersaglio delle accuse di impreparazione militare.
L’ex ministro della Guerra provò a difendersi ma, moderato e uomo delle istituzioni, nonché forse consapevole dei molti concreti problemi, non volle mai utilizzare il suo scranno senatoriale per operare una difesa dell’operato suo, e di fatto di quello di Giolitti. Spingardi ne sofferse molto: Zupelli lo notò nella sua commemorazione in Senato, quando disse che «l’esercito fu per lui il pensiero dominante, anzi il pensiero unico attorno a cui si coordinavano la sua attività ed i suoi sentimenti».
La proclamazione dell’intervento italiano nella guerra europea e mondiale non permise libere discussioni pubbliche attorno allo stato dell’ordinamento militare. Impose anzi l’utilizzo di tutte le risorse militari disponibili: così anche Spingardi fu richiamato in servizio per esercitare le funzioni di comandante territoriale del III corpo d’armata, a Milano (9 maggio 1915). Il ‘maggio radioso’ milanese però lo condannò: quella che fu giudicata una sua debole risposta alle manifestazioni interventiste e a quelle controinterventiste spinse il governo di centrodestra all’ennesimo affronto verso il generale, che venne esonerato e collocato a disposizione (1° giugno 1915). La carriera di Spingardi era di fatto finita.
Fu anche nominato alla presidenza della commissione centrale per i (non molti) prigionieri in mano italiana: ma era poca cosa e rimaneva per troppi il ministro della Guerra responsabile dell’impreparazione militare italiana, non quello che aveva rafforzato l’esercito, sia pure in una misura non sufficiente per una guerra dalle dimensioni da molti impreviste.
Forse simbolicamente, non poté vedere la vittoria del proprio Paese in guerra. Si ammalò infatti – si disse per morbo contratto andando a visitare i prigionieri austriaci tenuti all’Asinara, dove molti sarebbero deceduti per malaria – e morì a Spigno Monferrato il 22 settembre 1918. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)
[5] Emanuele Filiberto Savoia Aosta. di, duca d’Aosta. – Nacque a Genova il 13 gennaio 1869, figlio primogenito di Amedeo di Savoia Aosta, duca d’Aosta (1845-1890), e di Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna (1846-1876).
La cerimonia di battesimo si svolse a Genova il 14 marzo, alla presenza di Vittorio Emanuele II. Padrino e madrina furono il principe Eugenio di Savoia Carignano e la principessa Maria Clotilde, sorella del padre.
Nel dicembre 1870, Amedeo si recò a Madrid per cingere la corona di re di Spagna, offertagli dalle Cortes. In seguito a ciò, il 2 gennaio 1871 Emanuele Filiberto fu nominato principe delle Asturie, tradizionale titolo dell’erede al trono iberico. L’esperienza spagnola durò, però, poco più di due anni: nel marzo del 1873, infatti, il padre abdicò e i duchi d’Aosta rientrarono in Italia. Vittorio Emanuele II gli conferì, allora, il titolo di duca delle Puglie. Nel 1878, il re costituì una ‘casa d’educazione’ per i tre figli di Amedeo (dopo Emanuele Filiberto, infatti, erano nati Vittorio Emanuele, conte di Torino, 1870-1946, e Luigi Amedeo, duca degli Abruzzi, 1873-1933), a capo della quale fu posto Carlo Alberto Asinari di San Marzano. Vicegovernatore per il duca fu scelto il generale Giuseppe Perrucchetti, fondatore del corpo degli alpini, coadiuvato dal capitano Federico Quaglia.
L’educazione militare del duca proseguì nelle sale dell’Accademia militare di Torino, dove entrò, quindicenne, nel 1884. La grande passione del giovane per l’ippica e la sua predisposizione per la matematica convinsero il re a nominarlo tenente, il 14 settembre 1888, nel 5° reggimento di artiglieria di campagna di stanza a Venaria. Da questo passò poi al 17° reggimento, a Novara, come capitano e ancora al 19° reggimento, a Firenze, con il grado di maggiore. In quegli anni compì diversi viaggi all’estero insieme al padre, fra cui uno in Belgio, Olanda e Inghilterra, in cui iniziò a stringere rapporti e relazioni con le case reali di Belgio e Inghilterra che avrebbe coltivato per tutta la vita. Fu allora che il tema delle sue nozze iniziò a essere oggetto di attenzioni politiche. Nel 1889 i giornali diedero come imminente il suo matrimonio prima con un’Asburgo e poi con una Wittelsbach. Si trattava di nozze che avrebbero dovuto rinsaldare i rapporti fra i Savoia e il mondo germanico pochi anni dopo la nascita della Triplice alleanza (1882). Tali progetti, però, si scontrarono con l’opposizione della regina Margherita, la quale voleva che le nozze del duca fossero successive a quelle di suo figlio, il principe ereditario, Vittorio Emanuele.
Il 18 gennaio 1890 il duca Amedeo morì improvvisamente e così Emanuele Filiberto da duca delle Puglie divenne duca d’Aosta; lo stesso anno raggiunse la maggiore età ed entrò nel Senato del Regno. In questi anni egli risiedeva a Firenze, per ragioni militari, ma se ne allontanava spesso o per seguire la corte o per compiere viaggi all’estero. Particolare importanza ebbe il viaggio in Inghilterra che fece, sotto il nome di conte della Cisterna, dal 17 giugno al 6 settembre 1892. Egli incontrò allora la regina Vittoria e i principali ministri, cercando di convincere la regina a visitare i sovrani a Roma, ma senza successo. Ebbe modo anche d’incontrare l’imperatore Guglielmo II, che lo ricevette sullo yacht imperiale insieme al principe di Galles, il futuro Edoardo VII. Durante tale viaggio egli riprese la ricerca di una sposa, ponendo la sua attenzione sulle due figlie nubili del principe di Galles, per altro oggetto di attenzione anche da parte del cugino Vittorio Emanuele, e soprattutto sulla principessa Elena di Orléans (1871-1951), figlia del pretendente al trono di Francia Luigi Filippo Alberto, conte di Parigi (1838-1894), e di Maria Isabella di Orléans (1848-1919). Inizialmente, Elena di Orléans avrebbe dovuto sposare Alberto duca di Clarence (1864-1892), erede al trono di Gran Bretagna; a questo fine nel 1890 accettò di convertirsi alla fede anglicana e tutto sembrava pronto per le nozze, quando il padre si oppose alla conversione: Elena, allora, si recò da papa Leone XIII, chiedendone l’approvazione, ma ne ebbe un rifiuto. Il matrimonio fu pertanto annullato.
Il duca domandò, quindi, il permesso per chiedere la mano della principessa, ma ottenne un netto rifiuto sia dalla regina Margherita sia da Giovanni Giolitti, allora presidente del Consiglio. Gli Orléans erano fortemente cattolici e si temeva che tali nozze, certamente gradite in Vaticano, avrebbero potuto modificare la politica di Casa Savoia. Inoltre, se il principe Vittorio Emanuele non si fosse sposato o non avesse avuto figli, a salire al trono sarebbe stato proprio il duca o uno dei suoi figli.
Rientrato a Firenze, Emanuele Filiberto riprese la carriera militare, divenendo tenente colonnello il 3 ottobre 1893. Un anno dopo, il 5 settembre 1894, fu nominato colonnello comandante del 5° reggimento d’artiglieria da campagna, dove aveva iniziato la propria carriera. Egli avrebbe preferito una scelta più prestigiosa, tanto che aveva richiesto Palermo, anche per essere vicino agli Orléans, che vi risiedevano spesso; ma Umberto aveva scelto Venaria probabilmente proprio per tenerlo lontano da quell’ambiente. Poiché la matrigna Letizia Bonaparte (seconda moglie del padre Amedeo) aveva svuotato degli arredi palazzo Cisterna (sede torinese degli Aosta), trasferendoli al castello di Moncalieri, dove viveva, il duca chiese al marchese Luigi Medici del Vascello d’avere a disposizione un appartamento nel castello della Mandria (situato nel parco di Venaria), dove si trasferì nel luglio del 1895. Nel frattempo, aveva ottenuto dal re e dal presidente del Consiglio Francesco Crispi l’assenso alle nozze con l’Orléans. La coppia si sposò in Inghilterra – a Kingston upon Thames (nei pressi di Londra) – il 25 giugno 1895. Testimone dello sposo era il principe Vittorio Emanuele, a simboleggiare l’unità della Real Casa, al di là delle tensioni che il matrimonio aveva suscitato.
Rientrato in Italia, il duca chiese di essere inviato alla guerra d’Abissinia, ma il re e Crispi glielo rifiutarono, considerando tanto la sua inesperienza sul campo quanto la sua «piena ignoranza sulle cose d’Africa» (Paolucci, 1986, p. 150). Il 9 dicembre 1897 il duca fu promosso maggior generale e nominato comandante generale dell’artiglieria di Torino. Si trasferì allora a palazzo Cisterna. Qui ospitò spesso i parenti Orléans, aumentando così la frattura con la matrigna Letizia, il cui fratello Napoleone Vittorio (1862-1926) era dal 1891 il pretendente imperiale al trono di Francia e trascorreva lunghi soggiorni al castello di Moncalieri, residenza di Letizia. Il 30 marzo 1902, il duca divenne tenente generale e fu nominato comandante della divisione militare di Torino. Nel frattempo aveva avuto due figli: Amedeo (v. la voce in questo Dizionario) e Aimone, duca di Spoleto (1900-1948). Il 15 luglio 1902, a testimonianza degli ottimi rapporti del duca con la Corona Britannica, fu creato da Edoardo VII cavaliere della Giarrettiera (un suo ritratto in tale veste, realizzato da Vittorio Cavalleri, era un tempo al Palazzo Reale di Londra).
Il 5 aprile 1905 il duca fu promosso comandante di corpo d’armata e destinato al 10° corpo, di stanza a Napoli. I duchi lasciarono, quindi, Torino il 23 giugno 1905 e si trasferirono a Napoli, dove arrivarono il 2 luglio, stabilendosi alla Reggia di Capodimonte. Insieme a loro, lasciò Torino l’intera corte dei Savoia Aosta (la sola scuderia comprendeva 30 persone e 40 cavalli), segno che non si trattava di un trasferimento momentaneo, ma di un vero e proprio cambio di residenza. In effetti, a Capodimonte i duchi aprirono una corte che, per un decennio circa, si segnalò per sfarzo e cerimonie (il duca, in questo sollecitato dalla duchessa, avrebbe voluto introdurvi anche la pratica del baciamano d’onore, ma ricevette il divieto del re, essendo tale rituale tradizionalmente riservato ai sovrani), divenendo un punto importante di sociabilità per le nobiltà meridionali.
La designazione il 31 agosto 1910 a comandante d’armata in guerra pareva rispondere al desiderio del duca di scendere finalmente in campo, ma ancora una volta il governo non volle inviarlo in Africa per la guerra di Libia (1911). Il tanto agognato battesimo del fuoco arrivò nel 1915, quando l’Italia entrò nella prima guerra mondiale. Allora, infatti, il duca fu nominato capo della 3ª armata, distaccata sul Carso orientale, il cui obiettivo era la conquista di Gorizia e Trieste. Suo capo di stato maggiore era il generale Giuseppe Vaccari (1866-1937), che del duca fu principale collaboratore e ascoltato consigliere. La 3ª armata ottenne il suo più importante successo poco più di un anno dopo, l’8-9 agosto 1916, con la conquista di Gorizia. Il duca, al suo esordio militare, diede prova di fermezza e coraggio; vicino ai soldati, il suo rapporto con la truppa si rilevò determinante nell’evitare lo sbandamento dell’armata dopo Caporetto. Anzi, allora la 3ª armata non solo non si dissolse, ma restò compatta sotto il comando del duca, ritirandosi ordinatamente sul Piave e qui offrendo una resistenza tale da evitare un ulteriore sfondamento nel Veneto dell’esercito austro-ungarico. Si creò allora il mito del duca ‘invitto’ che nel decennio successivo determinò il suo grande prestigio nelle Forze armate e non solo. Il 17 novembre 1918 il duca entrò a Trieste, dove restò sino al 22 luglio 1919. Promosso generale d’esercito, per merito di guerra, sin dall’aprile di quello stesso anno, il 27 luglio fu nominato ispettore generale dell’arma di fanteria, incarico di cui si servì per mantenere stretti contatti con le truppe.
Negli ultimi mesi della sua presenza a Trieste il duca aveva apertamente appoggiato le pretese italiane su Fiume, ponendosi così in urto con il governo di Francesco Saverio Nitti, impegnato nelle difficili trattative di pace. Nei mesi successivi, il duca, da Torino, dove si era stabilito, si recò più volte al confine tenendo discorsi contrari alla linea del governo. La duchessa, poi, il 4 novembre 1919 andò a Fiume per partecipare, in abito di dama della Croce rossa, ai funerali di un legionario ucciso da una pattuglia di frontiera. In tale occasione essa visitò Gabriele D’Annunzio ed espresse parole di plauso alla sua azione. Ciò determinò la dura reazione del re e del governo. Nitti fece in modo che la stampa non desse grande spazio alla vicenda e stigmatizzò duramente con il sovrano l’azione dei duchi. Il re, a sua volta, riportando la notizia sul suo diario, commentò icasticamente: «vergogna!» (Artieri, 1978, p. 205), e ordinò ai duchi di compiere un lungo viaggio all’estero. La partenza del duca per il Belgio fu comunque vista dalla stampa italiana come un effetto della paura per la popolarità che egli aveva riscosso fra le truppe. Nel luglio del 1920 la carica d’ispettore generale dell’arma di fanteria fu soppressa, fra le proteste del duca stesso, che lo riteneva un attacco personale nei suoi confronti.
Negli anni successivi, i duchi d’Aosta si mostrarono sempre più aperti sostenitori di Benito Mussolini. Di particolare importanza fu il comportamento del duca in occasione della marcia su Roma. Già in settembre si erano diffuse voci che lo dicevano coinvolto nei preparativi dell’impresa (si diceva, per esempio, che egli avesse passato in rivista le squadre fasciste in diverse località). Ad allarmare di più il re e il presidente del Consiglio Luigi Facta fu la notizia che, quando i fascisti avevano posto il loro quartier generale a Perugia, il duca si trovasse in una villa che gli Orléans possedevano a Bevagna, vicino al capoluogo umbro. In diversi riferirono allora al re che il duca fosse pronto ad appoggiare i fascisti, giungendo al punto di accettare di farsi da loro sostituire al legittimo sovrano se questi si fosse rifiutato di conferire la presidenza del Consiglio a Mussolini. In realtà, non esistono prove certe che vi fossero state intese fra questi e il duca. Ciò che si conosce sono per lo più voci raccolte da terzi, come nel caso di Emilio Lussu, che raccontava di aver saputo da un aiutante di campo del re, suo amico, che il duca aveva informato il sovrano di esser pronto a detronizzarlo pur di salvare la monarchia (E. Lussu, Marcia su Roma e dintorni, Torino 1945, pp. 109 s.). Ma il re lo temeva. Celebre in questo senso la scena raccontata anni dopo da Facta alla figlia, in cui il re si sarebbe agitato disperato, ripetendo: «Viene il duca d’Aosta, viene il duca d’Aosta» (Répaci, 1972, pp. 585, 940). Se da una parte è arduo credere che il duca, educato e fedele al più ligio lealismo dinastico, sarebbe stato disposto ad accettare l’estromissione del cugino, dall’altra è vero, invece, che i fascisti si servirono abilmente, fomentandola, della paura che il re nutriva verso il duca d’Aosta. Tale paura non fu, del resto, la meno importante delle ragioni che convinsero il sovrano, il 28 ottobre 1922, a mutare la decisione assunta in precedenza revocando lo stato d’assedio.
Nel gennaio del 1923 Emanuele Filiberto fu chiamato a fare parte dell’allora istituito Consiglio dell’esercito. Alla fine di quello stesso anno si ammalò gravemente di polmonite, tanto che Vittorio Emanuele III si recò a Torino l’11 dicembre, temendolo in pericolo di vita. Il fascismo, dopo la presa del potere, lo onorò, ma non gli conferì cariche di reale potere. Il 23 giugno 1925 divenne presidente dell’Opera del dopolavoro, carica che tenne per poco più di due anni, dimettendosene nell’aprile 1927. Nominato maresciallo d’Italia il 26 luglio 1926, il duca era riconosciuto come il principale simbolo dei soldati italiani nella Grande Guerra, per cui rivestì numerosi incarichi di rappresentanza della Corona, fra cui va ricordata almeno la presidenza delle celebrazioni torinesi del 1928 per il decennale della vittoria e i quattro secoli dalla nascita del duca Emanuele Filiberto. Fra le cariche che gli furono allora conferite, vi furono quelle di presidente dell’Ordine militare di Savoia e di presidente della commissione per le Promozioni per merito di guerra degli ufficiali delle colonie.
Nel giugno 1931 il duca si ammalò nuovamente di polmonite. Dopo aver ricevuto un’ultima visita del re, il 29 giugno, morì il 4 luglio a Torino, nel suo palazzo Cisterna. Al funerale, tenutosi a Torino il 7 luglio 1931, parteciparono i sovrani e i principi di Piemonte. Il corpo fu portato al Sacrario di Redipuglia perché riposasse accanto ai soldati della 3ª armata.
Elena d’Orléans si risposò segretamente nell’ottobre 1936 con il colonnello Otto Campini (1892-1974), un ufficiale piemontese (di Brusasco) che faceva parte della sua corte. Continuò ad abitare a Capodimonte anche dopo la fine della monarchia, lasciandola solo nel 1949, quando si trasferì a Castellamare di Stabia, dove morì il 21 gennaio 1951. I funerali furono celebrati nel duomo di Napoli e il corpo fu tumulato nella chiesa della basilica di Capodimonte. Entrambi i figli le erano premorti. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[6] Gaetano Giardino. Maresciallo d’Italia (Montemagno, Alessandria, 1864 – Torino 1935). Sottocapo di Stato Maggiore (1911) del comando del corpo di occupazione della Tripolitania, durante la prima guerra mondiale assunse (ag. 1916) il comando della 48a divisione con la quale partecipò alla battaglia di Gorizia; promosso ten. generale per merito di guerra (1917) comandò il I e poi il XXV corpo d’armata; nominato ministro della Guerra fu poi (febbr. 1918) membro del Comitato consultivo interalleato di Versailles: nell’apr. dello stesso anno assunse il comando dell’armata del Grappa che guidò durante le battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. Senatore dal 1917, nel sett. 1923 fu nominato governatore militare di Fiume e nel 1926 maresciallo d’Italia. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)
[7] Guglielmo Pècori Giraldi. Generale (Firenze 1856 – ivi 1941). Comandante delle truppe in Eritrea (1903), tornato in Italia (1907) fu comandante di brigata, e quindi di divisione (1911). Comandante della prima armata (1916), contenne validamente gli Austriaci durante l’offensiva degli Altipiani; ai primi del nov. 1918 mosse con la sua armata su Trento, spingendosi fino alla linea d’armistizio; fu governatore della Venezia Tridentina dall’armistizio al 31 luglio 1919, senatore (1919), maresciallo d’Italia (1926); collare della Ss. Annunziata (1929). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[8] Antonio Salandra. Uomo politico (Troia 1853 – Roma 1931). Presidente del Consiglio (1914), su posizioni conservatrici, allo scoppio della Prima guerra mondiale passò da neutralismo a interventismo e promosse i negoziati segreti preliminari al patto di Londra. Dimessosi (1915) per l’opposizione dei neutralisti, fu riconfermato al governo (fino al 1916); fu infine delegato alla Conferenza di Parigi (1919). Avvocato, prof. nell’univ. di Roma dapprima (1879-80) di legislazione economico-finanziaria, poi (1880-1902) di scienza dell’amministrazione, infine (dal 1902) di diritto amministrativo. In questi anni svolse la sua maggiore attività scientifica, che abbracciò argomenti assai vari (Il divorzio in Italia; Dei metodi e criteri per calcolare la ricchezza nazionale in Italia; Gli interessi della terra e la loro rappresentanza; La giustizia amministrativa nei governi liberi, 1904, che è la sua opera maggiore) e che gli valse la nomina a socio nazionale (1907) dei Lincei. In seguito si dedicò sempre più intensamente all’attività politica, iniziata nel 1886 come deputato della Camera, dove aveva sostenuto il rafforzamento del governo di fronte al parlamento manifestando tendenze espansionistiche all’estero e conservatrici all’interno. Sottosegretario alle Finanze (1891-92), di nuovo alle Finanze e poi al Tesoro (1893-96), fu quindi ministro dell’Agricoltura (1899-1900) con L. Pelloux, del Tesoro (1906) e delle Finanze (1909-10) con S. Sonnino. Presidente del Consiglio (1914), dovette affrontare i gravissimi problemi determinati dallo scoppio della guerra europea. Decisa dapprima la neutralità, si orientò presto verso la persuasione che l’Italia dovesse agire. Intavolò pertanto trattative con l’Austria per la cessione delle terre irredente sotto il suo dominio; di fronte alla resistenza incontrata si volse verso l’intervento con l’Intesa, avviando i negoziati segreti che condussero al patto di Londra e alla denuncia della Triplice. Le correnti neutraliste parlamentari costrinsero nel maggio 1915 S. alle dimissioni: ma le violente dimostrazioni interventiste nel paese e la fiducia del re lo riconfermarono al governo. Dichiarata la guerra, rimase al potere fino all’offensiva austriaca nel Trentino (10 giugno 1916). Dopo la fine del conflitto fu delegato alla Conferenza di Parigi e rappresentò quindi l’Italia a Ginevra. In un primo tempo fiancheggiatore del fascismo, nel 1925 si ritirò dalla vita pubblica. Nel 1928 fu nominato senatore. Pubblicò: La neutralità italiana, 1914: ricordi e pensieri (1928) e L’intervento, 1915: ricordi e pensieri (1930).© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[9] Sidney Costantino Sonnino. Uomo politico italiano (Pisa 1847 – Roma 1922). Deputato della destra, ministro delle Finanze e del Tesoro, risanò il bilancio statale. Dopo avere rivestito la carica di presidente del Consiglio (1906 e 1909-10), come ministro degli Esteri fu il firmatario del Patto di Londra (1915), che strenuamente difese al termine del primo conflitto mondiale nel corso della Conferenza della pace.
Laureatosi in giurisprudenza (1865), abbandonò la professione forense per intraprendere la carriera diplomatica (1867-73). Tornato agli studî, si occupò in particolare di problemi agrarî, portando a termine, insieme a L. Franchetti, un’inchiesta su La Sicilia nel 1876 (1877), in cui venivano evidenziati gli aspetti negativi del latifondo e si criticava l’assenteismo dei proprietarî terrieri del Mezzogiorno. Fondatore, sempre con Franchetti, della rivista Rassegna settimanale (1878-82), nel 1880 fu eletto deputato e si schierò con la destra moderata. Ministro delle Finanze (1893-94) e del Tesoro (1893-94 ad interim; 1894-96), S. fece fronte alla crisi economico-finanziaria del paese e risanò il bilancio dello stato mediante l’aumento dei dazî, l’imposizione di nuove tasse e un maggiore controllo della circolazione monetaria, attuato tramite il rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia. Capo dell’opposizione costituzionale dopo il definitivo ritiro di F. Crispi, nel celebre articolo Torniamo allo Statuto! (1897) sostenne che per salvare lo stato liberale dal duplice pericolo socialista e clericale fosse necessario tornare a una rigida interpretazione dello Statuto albertino, con una piena restaurazione dei poteri del sovrano e una riaffermazione della responsabilità dei ministri unicamente nei confronti del re. Dopo aver guidato l’opposizione liberal-conservatrice ai governi presieduti da G. Zanardelli (1901-03) e G. Giolitti (1903-05), fu presidente del Consiglio per due brevi periodi (febbr. – maggio 1906; dic. 1909 – marzo 1910). Ministro degli Esteri dall’ott. 1914, dopo aver inutilmente negoziato con l’Austria-Ungheria, in base all’art. 7 della Triplice Alleanza, per ottenere compensi nelle terre irredente, portò l’Italia in guerra a fianco dell’Intesa con la firma del Patto di Londra (26 apr. 1915): con tale accordo S. mirò a completare il processo di unificazione dell’Italia, garantendole la sicurezza strategica, a nord come nell’Adriatico, mentre con una politica di moderazione verso il Mediterraneo orientale puntò a mantenervi l’equilibrio con le altre grandi potenze. Durante la guerra, appresa l’esistenza degli accordi fra le potenze dell’Intesa per la spartizione dell’Impero ottomano, affinché l’Italia non ne rimanesse esclusa ingaggiò una lunga battaglia diplomatica, che si concluse con il convegno di Saint-Jean-de-Maurienne. Al termine della guerra condusse, alla Conferenza della pace, una rigida difesa delle disposizioni del Patto di Londra, scontrandosi con l’opposizione del presidente statunitense Th. W. Wilson e degli Alleati. Lasciato il ministero degli Esteri con la caduta del gabinetto Orlando (giugno 1919), si oppose nello stesso anno all’introduzione del sistema elettorale proporzionale, ritirandosi poi dalla vita politica, nonostante nel 1920 fosse stato nominato senatore. Di S. sono stati pubblicati: Discorsi parlamentari (3 voll., 1965) e Opera omnia (Diario, 1866-1922, 3 voll., 1972; Scritti e discorsi extraparlamentari, 1870-1920, 2 voll., 1972; Carteggio, 1914-1922, 2 voll., 1974-75). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[10] César-Joseph-Jacques Joffre . Generale (Rivesaltes, Pirenei, 1852 – Parigi 1931). Partecipò alla guerra del 1870 e in seguito prestò servizio nel Tonchino e nel Madagascar; nel 1911 era vicepresidente del Consiglio superiore di guerra, e subito dopo capo di stato maggiore generale. All’inizio della prima guerra mondiale, fu nominato comandante in capo delle forze armate francesi del nord e del nord-est. Nell’agosto 1914, conformemente al piano da lui ideato, ispirato alle tendenze dottrinarie degli ufficiali della jeune école, volle prendere dovunque l’offensiva, ma l’insuccesso fu generale. J. fece allora prevalere piani più cauti, personali, coordinando la ritirata manovrata delle fanterie a sud della Marna, da cui derivò la vittoria della Marna, le successive manovre dell’Aisne, di Piccardia, Artois e Fiandre. Dall’ottobre 1914, J. diresse le operazioni di logoramento (fino al 1915); dopo l’insuccesso della grande offensiva anglo-francese della Somme (1916) cessò dal comando attivo delle armate francesi. Maresciallo di Francia (1916), pubblicò fra l’altro: La préparation de la guerre et la conduite des opérations (1920). Postumi apparvero i suoi Mémoires (2 voll., 1932). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[11] Ferdinand Foch. Maresciallo di Francia (Tarbes 1851 – Parigi 1929). Insegnò tattica alla Scuola di guerra dal 1896 al 1901; allo scoppio della prima guerra mondiale era comandante di corpo d’armata, ma la battaglia della Marna lo vedeva già comandante d’armata. Diresse con successo le offensive dell’Artois e della Champagne, quindi comandò il gruppo delle armate del nord (1916). L’anno seguente passò a presiedere il Consiglio supremo di guerra interalleato, e nel marzo 1918 fu chiamato ad assumere la direzione del fronte occidentale. Gli inizî non furono fortunati: F. fu sorpreso dall’attacco tedesco del 27 maggio allo Chemin des Dames e subì un grave scacco. Clemenceau lo salvò a stento dalle ire del parlamento di Parigi e di Lloyd George, che lo volevano esonerare dal comando. F. rispose però in pieno al suo compito nel preparare e dirigere la battaglia di Francia (18 luglio – 11 nov. 1918). Fu uomo di grande dottrina, di mente lucida e di temperamento energico; si distinse più come stratega che come tattico, e soprattutto più nella difensiva tenace che nella creazione di nuove forme d’attacco. Lasciò importanti scritti, quali Des principes de la guerre (1903) e De la conduite de la guerre (1904). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[12] Armando Diaz. Maresciallo d’Italia (Napoli 1861 – Roma 1928); nel 1912 durante la guerra libica, comandante di un reggimento, si distinse a Zanzur; rimpatriato, fu segretario del gen. A. Pollio, capo diS. M. dell’esercito, e tale rimase con L. Cadorna dopo la morte del Pollio (1914). Scoppiata la prima guerra mondiale, fu capo del reparto operazioni presso il comando supremo. Nel 1917 diresse con perizia il 33º corpo d’armata sul Carso; l’8 nov. 1917, dopo la battaglia di Caporetto e il ripiegamento italiano, sostituì il Cadorna nell’ufficio di capo di S. M. e superò con successo la prima e più critica fase, quella della stabilizzazione, sulla linea Grappa-Piave. Seppe rinsaldare l’esercito che poté prima affrontare vittoriosamente l’urto offensivo austriaco nel giugno 1918 e quindi dar vita all’offensiva finale italiana del 24 ott.-3 nov. 1918. Senatore dal febbr. 1918, collare dell’Annunziata il 4 nov. dello stesso anno, socio onorario dei Lincei il 9 marzo 1919, duca della Vittoria nel dicembre 1921, ministro della Guerra nel primo gabinetto Mussolini (dal 1922 al 1924), maresciallo d’Italia nel 1924. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[13] Luigi Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco di Savoia, I duca degli Abruzzi (Madrid, 29 gennaio 1873 – Villaggio Duca degli Abruzzi, 18 marzo 1933), è stato un nobile, ammiraglio, esploratore e alpinista italiano. Uno dei più celebri membri della famiglia reale italiana, nel giro di poco più di un decennio, tra il 1897 e il 1909, ha compiuto le spedizioni che lo hanno reso internazionalmente celebre: nel 1897 la prima ascensione del Monte Saint Elias, in Alaska; nel 1900 la spedizione al Polo nord (a bordo della nave Stella Polare) che raggiunse la latitudine Nord più avanzata dell’epoca; nel 1906 l’esplorazione del massiccio africano del Ruwenzori e l’ascesa delle sue cime maggiori; nel 1909 la spedizione nel Karakorum, con il fallito tentativo di ascesa del K2 e il nuovo record mondiale di altitudine.
Durante la prima guerra mondiale è stato al comando della flotta alleata. In seguito si è dedicato fino alla sua morte a un innovativo progetto di sperimentazioni agricole e di cooperazione con popolazioni locali in Somalia.(fonte)
[14] Paolo Thaon di Revel. Ammiraglio (Torino 1859 – Roma 1948). Uscito dalla scuola di marina di Genova con il grado di guardiamarina (1877), fu capitano di vascello (1904), contrammiraglio (1910), ispettore delle siluranti (1912) e capo di Stato Maggiore della marina (1913). Comandante delle forze navali dell’alto Adriatico durante la prima guerra mondiale, nel 1918 fu nominato ammiraglio e nel 1922, all’avvento del fascismo, assunse la carica di ministro della Marina, che mantenne fino al 1925. Duca (1923), Grande ammiraglio (1924), una volta ritirato dalla vita politica attiva fu tra i collaboratori di corte di Vittorio Emanuele III.© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)
[15] Stefania Turr. Nata a Roma dal politico e militare ungherese eroe del Risorgimento István Türr, nel 1916 fonda l’associazione Madri italiane a tutela degli orfani di guerra e il mensile La Madre Italiana. Rivista mensile pro orfani di guerra., il mensile verrà chiuso nel 1919. Poco dopo decide di partire da Milano per Udine e infine per il fronte come corrispondente di guerra nonostante all’epoca avesse un figlio di 11 anni, dopo molti tentativi respinti dall’Alto Comando. Al fronte incontrò sia il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna, sia il generale Carlo Porro e il re Vittorio Emanuele III. Nel dopoguerra si avvicinò al fascismo e pubblicò la biografia di suo padre per la Tipografia fascista di Firenze e cercò di richiedere la parità dei diritti tra uomo e donna come scrisse nel 1918: «Che cosa sarebbe avvenuto della grande Italia se le donne per animo debole o per non sicura coscienza della gravità del momento che attraversava la patria, non avessero saputo dar prova di così squisita coscienza nazionale? […] Oggi il bilancio morale e materiale degli anni di guerra è tutto a favore di noi donne e possiamo perciò presentarci a fronte alta dinanzi agli uomini e domandar loro: e ora? Nei giorni del lavoro febbrile, nei giorni della trepidazione e del dolore voi ci avete chiamate, noi siamo accorse e vi abbiamo dato l’aiuto necessario e proficuo, oggi che la nostra opera è compiuta atten- diamo il nostro premio. Noi non possiamo più essere assenti dalla vita politica delle nazioni e voi dovete provvedere.» Morì a Firenze nel 1940, a 55 anni.(fonte)
[16] Luigi Albertini. Giornalista e uomo politico (Ancona 1871 – Roma 1941). Studioso di problemi sociali, amministratore (1898) e quindi direttore (1900) del Corriere della sera, ne fece uno dei più diffusi e autorevoli giornali d’Europa, nonché, per lunghi periodi, la principale forza di opposizione costituzionale alla politica del governo italiano. Liberale su posizioni di conservatorismo illuminato, l’A. impresse al giornale da lui diretto una linea politica fondata sull’antigiolittismo (vide nel Giolitti mancanza di idealità politiche e morali e assenza di senso dello stato) e sul liberismo economico. Nel 1915 portò un contributo forse decisivo alla causa dell’interventismo; favorevole agli accordi con la Iugoslavia dopo la prima guerra mondiale, fu – dopo essergli stato favorevole agli inizî – avversario intransigente del fascismo, che combatté anche in senato (dove era entrato nel 1914). Estromesso dal Corriere della sera nel 1925, si dedicò a studî storici e alla bonifica di terre presso Roma. Le sue opere principali sono: Le origini della guerra del 1914 (1943); In difesa della libertà (1947); Venti anni di vita politica (5 voll., 1950-1953).© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)
[17] Benito Amilcare Andrea Mussolini. Uomo politico (Dovia di Predappio 1883 – Giulino di Mezzegra, Dongo, 1945). Socialista, si andò staccando dal partito, fino a fondare i Fasci da combattimento (1919). Figura emergente nell’ambito del neoformato Partito nazionale fascista, subito dopo la “marcia su Roma” (1922) venne incaricato dal re della formazione del governo, instaurando nel giro di pochi anni un regime dittatoriale. In politica internazionale M. affrontò l’esperienza coloniale in Etiopia, si fece coinvolgere dai buoni rapporti con la Germania di Hitler nella persecuzione degli Ebrei, fino poi alla partecipazione al conflitto mondiale. I pessimi risultati bellici portarono il Gran Consiglio a votare la mozione Grandi presentata contro di lui (1943). Arrestato, fu liberato dai Tedeschi e assunse le cariche di capo dello Stato e del governo nella neonata Repubblica sociale. Alla fine della guerra fu catturato e fucilato dai partigiani per ordine del Comitato di liberazione nazionale. Dominò la storia italiana per oltre un ventennio, divenendo negli anni del suo potere una delle figure centrali della politica mondiale e incarnando uno dei modelli dittatoriali fra le due guerre. Di estrazione popolare (il padre, Alessandro, era fabbro, e la madre, Rosa Maltoni, maestra), dotato di una personalità ribelle e intemperante, aderì giovanissimo alle idee socialiste e rivoluzionarie professate dal padre. Nel 1901, al termine di un disordinato corso di studi, conseguì il diploma magistrale e, iscritto al partito socialista, iniziò a collaborare alla Giustizia di C. Prampolini, specie con articoli antimilitaristi. Espatriato in Svizzera (1902-04) per sottrarsi alla leva, si sostenne facendo vari mestieri e si segnalò come acceso propagandista soprattutto sul versante anticlericale, mentre alcune letture soreliane contribuirono forse a indirizzarlo verso il sindacalismo rivoluzionario. Condannato per diserzione e poi amnistiato, rientrò a Predappio nel gennaio 1905, espletò gli obblighi di leva e si impiegò come maestro. Riprese quindi l’attività giornalistica e nel 1908 fu arrestato a seguito di uno sciopero bracciantile. Nel febbraio 1909, chiamatovi da C. Battisti, assunse la segreteria della camera del lavoro di Trento e la direzione dell’Avvenire del lavoratore. Espulso dai territori asburgici (settembre 1909), divenne dirigente della federazione socialista di Forlì e direttore del settimanale Lotta di classe. In questo periodo si unì con Rachele Guidi, che avrebbe sposato nel 1915, dalla quale ebbe i figli Edda, Vittorio, Bruno, Anna Maria e Romano. Nel 1911 subì una nuova condanna per aver guidato, con il repubblicano P. Nenni, le manifestazioni contro l’intervento in Libia, ma stava ormai emergendo come il più noto oratore e giornalista socialista, per cui, allorché i massimalisti prevalsero sui riformisti (congresso socialista di Reggio Emilia, luglio 1912), fu acclamato tra i maggiori dirigenti del partito e gli venne affidata, nel dicembre, la direzione dell’Avanti!. Si trasferì a Milano, dove aveva sede il quotidiano, che sotto la sua direzione acquistò molto in diffusione e influenza, perseguendo una linea classista e rivoluzionaria che in alcune occasioni (per es., allorché intese estendere lo sciopero generale scaturito dalla sollevazione di Ancona nel 1914) attirò la sconfessione di F. Turati e del gruppo parlamentare socialista. Nel dibattito sulla guerra M. sostenne per vari mesi una posizione rigidamente neutralista, anche in contrasto con i molti che avevano fatto un percorso politico analogo al suo e che ora andavano orientandosi in favore dell’intervento, finché il 18 ottobre 1914, con una svolta improvvisa, pubblicò un proprio editoriale interventista. Il partito reagì immediatamente sottraendogli la direzione dell’Avanti! ed espellendolo, ma già il 14 novembre usciva il primo numero del Popolo d’Italia, quotidiano interventista da lui diretto. Consumata la rottura con il PSI, non era ancora consumato il rapporto con il movimento socialista, nel quale M. avrebbe continuato ad avere un qualche seguito. Richiamato alle armi nel settembre 1915, nel febbraio 1917 venne ferito in un’esercitazione e tornò alla direzione del giornale. Nelle tensioni del dopoguerra M. operò dapprima un cauto avvicinamento alle posizioni nazionaliste con la fondazione dei Fasci di combattimento (Milano, 23 marzo 1919), costituiti da un centinaio di ex combattenti (tra questi sindacalisti, arditi, ex socialisti, repubblicani, futuristi), il cui programma manteneva visibili impronte socialiste; quindi, anche alla ricerca di una base di massa per il suo movimento, intessé un confronto con i dannunziani, che avevano motivazioni largamente analoghe alle sue, e fece propria la parola d’ordine della vittoria mutilata; ma soprattutto cercò di unificare in un’unica tendenza i movimenti antiliberali e antigiolittiani, di destra come di sinistra, senza peraltro conseguire un successo nelle elezioni politiche del novembre 1919. Dopo l’occupazione delle fabbriche (autunno 1920) e la sconfitta del movimento operaio, nel corso di una crisi politica che vedeva declinante l’iniziativa socialista e in sempre maggior difficoltà la classe dirigente liberale, M., operando una visibile svolta, tese a presentarsi come capo di una forza capace di rappresentare le tendenze antiliberali della piccola e media borghesia spaventata dall'”ondata bolscevica”, nonché il bisogno di ristabilire l’ordine gerarchico dell’organizzazione economico-produttiva scosso dalle lotte proletarie. Nell’aprile 1921 il movimento elesse oltre trenta parlamentari, tra i quali M., in liste comuni con i giolittiani, e nel novembre successivo l’ingrossarsi delle sue file consigliò la costituzione del Partito nazionale fascista. Gli agrari e ampi settori della borghesia industriale sostennero e incoraggiarono l’opera di smantellamento sistematico delle roccaforti del potere proletario (giornali, sezioni di partito, cooperative, sindacati, ecc.) attuato dai fascisti con violenza, mentre alcuni settori dell’apparato statale (magistrati, prefetti, responsabili della sicurezza ecc.) garantirono agli squadristi, quando non il sostegno, l’impunità. In questa fase M., che appariva figura emergente in grado di raccogliere una massiccia forza d’urto per dare la scalata al potere, seppe abilmente alternare intimidazioni brutali e rassicurazioni di legalità, fino alla prova di forza che si ebbe con la mobilitazione fascista del 22 ottobre 1922 (la “marcia su Roma”) a seguito della quale cadde il governo Facta e il re lo incaricò di formare il governo. M. sarebbe rimasto ininterrottamente a capo del governo dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 (dal 24 dicembre 1925 con il titolo di primo ministro e segretario di stato), tenendo altresì per vari periodi i ministeri degli Esteri (1922-29, 1932-36, 1943), degli Interni (1922-24, 1926-43), delle Colonie, della Marina, delle Corporazioni e altri; egli fu cioè il supremo esponente dell’Italia fascista. Gli anni tra il 1922 e il 1924 videro un governo di coalizione cui partecipavano liberali, nazionalisti, popolari, governo che perseguì una politica genericamente di destra e si servì di norma di mezzi legali per la repressione dell’antifascismo. Ma il problema di M. era conciliare l’anima “rivoluzionaria” del movimento fascista, che largamente gli sfuggiva e rischiava di coalizzare le opposizioni, con la necessità di consolidare i nuovi equilibri politici governativi. Con la costituzione del Gran Consiglio del fascismo (dic. 1922), presieduto dallo stesso M., e l’istituzione della Milizia volontaria per la difesa dello stato (genn. 1923), che legalizzava e imbrigliava lo squadrismo, M. tentò una prima soluzione del problematico rapporto movimento-governo, apprestandosi a divenire garante di ciascuno nei confronti dell’altro, mentre la confluenza dei nazionalisti nel PNF e la legge elettorale Acerbo (luglio 1923), che assicurava un forte premio di maggioranza alla lista vincitrice, ne rafforzavano la posizione. A interrompere il consolidarsi del connubio tra fascismo e stato intervenne la crisi dell’Aventino, a seguito dell’assassinio da parte di alcuni sicari fascisti del leader socialista G. Matteotti (giugno 1924), fase che poteva segnare la fine del governo di coalizione ma che si concluse con il discorso di M. alla Camera del 3 gennaio 1925, nel quale era rivendicata la continuità tra il movimento fascista e il governo in carica. Sconfitta con il concorso della Corona l’opposizione aventiniana, e con essa l’antifascismo tutto, per M. si apriva la strada dell’edificazione del regime, cui il governo (ormai completamente composto da fascisti) diede mano varando una serie di leggi che tra il 1925 e il 1929 modificarono sostanzialmente l’assetto costituzionale. Il partito unico, la soppressione delle libertà di associazione e di stampa, l’istituzione del Tribunale speciale, il rafforzamento dell’esecutivo e dei poteri del capo del governo, l’attribuzione di funzioni costituzionali al Gran Consiglio del fascismo e, in breve, l’insieme della legislazione di questi anni, abolivano la divisione costituzionale dei poteri e posero M. nella posizione di un esercizio del potere sostanzialmente illimitato, regolatore unico dell’intero ingranaggio amministrativo, istituzionale ed economico della nazione; a questa funzione si accompagnava una gigantesca macchina propagandistica esaltatrice delle virtù nazionali e guerriere del “duce” – figura carismatica destinata a riprodursi in altri contesti politici totalitari, attorno a cui si consolidò il consenso -, mentre si diffondevano come cultura di massa i simboli, il linguaggio, i riti collettivi, gli istituti del regime. Il regime mussoliniano in senso stretto durò dunque dalla fine degli anni Venti al 1943, perfezionando col tempo l’integrazione totalitaria di partito, società e stato; pertanto, specie in questo periodo, la vita e le scelte di M. costituiscono gran parte della politica interna ed estera dell’Italia. Se l’apice del prestigio, non solo all’interno, venne toccato alla metà degli anni Trenta, è nello stesso periodo che inizia a delinearsi un quadro internazionale che, con la guerra, avrebbe portato la rovina di M. e del fascismo, oltre la sconfitta dell’Italia. La politica estera del fascismo fu sostanzialmente prudente e in linea con la politica estera liberale fino all’ascesa al potere di A. Hitler e alla revisione dell’equilibrio politico europeo che questa comportava. Dopo aver preso posizione contro la minaccia di un’annessione dell’Austria da parte della Germania e aver promosso il convegno di Stresa con Francia e Gran Bretagna (1935) che parve creare un fronte antitedesco, M., per prevalenti motivi di prestigio interno e internazionale, volle la conquista dell’Etiopia, che gli confermò il consenso degli italiani ma depauperò l’economia nazionale, costretta a provvedere all’Impero, e provocò l’urto con la Gran Bretagna e la Società delle Nazioni. Inoltre i legami di solidarietà con la Germania, nella tensione internazionale causata anche dall’intervento nella guerra civile spagnola, trasformatisi presto in una rigida complementarità, portarono M. all’accettazione (1938) dell’Anschluss e alla persecuzione degli Ebrei. Alla vigilia del conflitto mondiale, M. parve svolgere a Monaco (1938) un ruolo di efficace moderatore; si trattò in effetti di una dilazione dell’attacco a fondo che Hitler stava per sferrare. Scoppiata la guerra, che a lungo aveva minacciato, giungendovi peraltro militarmente impreparato, M., dopo un periodo di incertezza dissimulata dalla formula della “non belligeranza”, decise l’intervento ritenendo imminente la vittoria tedesca. Gli insuccessi della sua opera di comandante supremo – carica che nel maggio del 1940 gli era stata ceduta dal re -, la constatazione che egli aveva perso ogni controllo della situazione, che andava precipitando dopo le spedizioni in Grecia e in Russia e l’occupazione alleata di parte del territorio italiano, offrirono la possibilità al Gran Consiglio del fascismo di approvare (24 luglio 1943) un ordine del giorno, presentato da D. Grandi, contro di lui, cui seguì da parte del re l’immediata revoca del mandato governativo. Crollato il regime, M. fu trasferito in stato di fermo prima a Ponza, poi alla Maddalena, quindi al Gran Sasso; di qui venne liberato dai tedeschi con un colpo di mano e portato in volo in Germania all’indomani dell’8 settembre. Tornò in Italia per raccogliere quel che restava dello sfacelo fascista nella Repubblica sociale italiana, nella quale esercitò le funzioni di capo dello Stato e capo del governo. Installato a Gargnano (sul Lago di Garda), seguì le vicende belliche apparendo raramente in pubblico. Dichiarò come obiettivo la riconciliazione degli italiani e la socializzazione, ma la crisi militare dell’Asse, gli scioperi operai del 1943-44 e il movimento di Resistenza ne evidenziarono la funzione di puntello dell’occupazione tedesca. Al crollo della “linea gotica” si trasferì a Milano (17 apr. 1945) e tentò di contrattare la propria incolumità con il Comitato di liberazione nazionale. In fuga verso Como, in divisa da soldato tedesco, fu arrestato dai partigiani e passato per le armi per ordine del CLN il 28 aprile 1945. Il suo cadavere (insieme a quelli di Claretta Petacci, la donna cui era legato dal 1936, e di altri gerarchi fucilati) fu esposto dai partigiani a Milano in piazzale Loreto, a simbolo della fine del fascismo. L’edizione dell’Opera omnia è curata da E. e D. Susmel, 36 voll., 1951-63. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[18] Luigi Federzoni. Uomo politico, nato a Bologna il 27 settembre 1878. Laureatosi in lettere nell’università di Bologna, entrò nel giornalismo, e prima nel Resto del Carlino, poi nel Giornale d’Italia scrisse, sotto lo pseudonimo anagrammatico di Giulio de Frenzi, d’arte, di letteratura e di politica. Andato a Roma nel 1906, fu, nel 1910, tra i fondatori del movimento nazionalista e, l’anno dopo (insieme con F. Coppola, E. Corradini, R. Forges Davanzati e M. Meraviglia), dell’Idea Nazionale, organo ed espressione del nuovo movimento (v. nazionalismo). L’azione intrapresa dal F. e dai suoi amici ebbe una notevole ripercussione. Il primo risultato fu il movimento d’opinione pubblica per la conquista della Libia. Durante la guerra italo-turca, come corrispondente del Giornale d’Italia da Tripoli e da Rodi, il F. affrontò i problemi attinenti all’occupazione dei territorî, propugnando la campagna a fondo in Libia e l’annessione definitiva delle Isole Egee. Nel 1913 impegnò contro la massoneria un’insistente campagna di stampa e di comizî, che esercitò profonda influenza sullo spirito nazionale. In quello stesso anno, per dissenso d’idee col liberale Giornale d’Italia ne uscì. Candidato nazionalista per il primo collegio di Roma durante le elezioni per la XXIV legislatura, ebbe il sopravvento, dopo una vivace campagna elettorale, sul suo avversario, il deputato socialista Campanozzi, e fu eletto deputato il 2 novembre 1913. Alla Camera il F. sedette all’estrema destra, segnalandosi come uno tra i più attivi e battaglieri parlamentari. Nei numerosi discorsi da lui tenuti alla Camera in tema di politica interna ed estera, affermò esser possibile una giustizia sociale e un regime di popolo solo con uno stato forte, autoritario, fedele alle istituzioni tradizionali, e tuttavia profondamente rinnovato nello spirito. Scoppiata la guerra mondiale, propugnò col suo gruppo l’intervento dell’Italia a fianco dell’Intesa. Volontario in guerra, come sottotenente del 5° artiglieria e poi tenente dei bombardieri, meritb una medaglia d’argento sul Carso e due croci di guerra al valor militare sul Piave.
Nel dopoguerra difese in parlamento il programma delle aspirazioni italiane per l’Adriatico e per le colonie e fu apertamente solidale, specie dopo l’eccidio di Bologna (1920), coi deputati fascisti. Dall’opposizione di destra (fascisti, nazionalisti, liberali nazionali) fu portato alla carica di vice-presidente della Camera per la minoranza. Frattanto aveva ripreso il suo posto nel giornalismo, come direttore dell’Idea Nazionale, alla quale impresse un indirizzo sempre più vigoroso di attacco al regime liberale-democratico, d’accordo con l’azione fascista. Avvenuta la Marcia su Roma, alla quale doveva indi a poco seguire la fusione dei nazionalisti col partito fascista, il F. fu chiamato a dirigere il Ministero delle colonie, ufficio che egli tenne fino al 16 giugno 1924, per passare al dicastero dell’Interno, donde tornò a quello delle Colonie il 6 novembre 1926, restandovi, poi, fino al 18 dicembre 1928. Le colonie italiane hanno ricevuto dall’azione del F. un impulso vigoroso di rinnovamento, in armonia con l’indirizzo generale della politica fascista. Nel primo periodo (1922-24) si devono a tale impulso: in Tripolitania, la riconquista di Misurata, della Gefara e della Ghibla, fino all’antemurale predesertico costituito dalla linea Gadames-Misda-Beni Ulid; in Cirenaica, la denuncia degli accordi con la Senussia, lo scioglimento dei campi misti italo-senussiti e l’occupazione di Agedabia; in Eritrea e in Somalia, la rinascita economica accompagnata da un più intenso avvicinamento politico e commerciale all’Arabia meridionale e all’Etiopia. Nel secondo periodo (1926-1928) si compirono le operazioni militari per la sutura territoriale delle due colonie libiche e per l’occupazione della regione sirtica fino alla catena delle oasi insistenti sul 29° parallelo N.; inoltre, la ripresa dell’attività repressiva contro la guerriglia senussita nell’altipiano cirenaico; infine, lo sviluppo della colonizzazione in tutte le terre africane d’Italia e la trasformazione organica di tutta la legislazione coloniale in base ai principî fondamentali del fascismo. Sotto il suo ministero dell’Interno furono adottati molti provvedimenti legislativi, fra i quali la creazione dell’Opera nazionale per la maternità e l’infanzia e quella dell’Opera Nazionale Balilla; l’istituzione del podestà e della consulta in luogo delle amministrazioni comunali elettive; l’istituzione del governatorato di Roma e dell’alto commissariato di Napoli; l’ampliamento e il rinvigorimento delle attribuzioni dei prefetti; la repressione della mafia siciliana; la regolamentazione della stampa periodica; la nuova legge di pubblica sicurezza; numerose leggi dirette alla difesa e al miglioramento dell’igiene pubblica. Soprattutto è da ricordare l’azione con la quale, accanto a Benito Mussolini, negli anni 1924-26 il F. fronteggiò il tentativo di rovesciamento del regime da parte delle forze sovversive e socialdemocratiche. Nominato senatore il 22 novembre 1928, è, dal 30 aprile 1929, presidente del Senato. Dal 1° giugno 1931 ha la direzione della Nuova Antologia. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[19] Angelo Gatti. Generale. Nato a Capua il 9 gennaio 1875. Ufficiale di Stato maggiore, professore di storia alla Scuola di guerra di Torino, fu addetto nel 1915 al comando della 1ª armata. Nel gennaio 1917 fu chiamato al Comando supremo. Seguì il Cadorna durante la ritirata di Caporetto come segretario particolare e fu con lui a Versailles al congresso militare interalleato (dicembre 1917). Scrittore di storia e critico militare, ha pubblicato numerosi volumi (L’Italia in armi, 1915; Le presenti condizioni della Germania, 1916; Uomini e folle di guerra, 1921; Nel tempo della tormenta, 1923; Uomini e folle rappresentative, 1925; La parte dell’Italia, 1926, ecc.) e un romanzo: Ilia ed Alberto (Milano 1930). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[20] Vittorio Emanuele Orlando. Giurista e uomo politico italiano (Palermo 1860 – Roma 1952). Insigne giurista e politico italiano, ha insegnato diritto costituzionale e diritto amministrativo nelle univ. di Messina, di Modena, di Palermo, e di Roma. Fu il fondatore della scuola italiana di diritto pubblico ed ha iniziato a partecipare attivamente alla vita politica dal 1897: ministro della pubblica istruzione (1903-05), di grazia e giustizia (1907-09; 1914-16) e dell’interno (1916-17); presidente del consiglio (1917-19) e della camera (1919-20); assunse l’incarico di presidente della commissione degli affari esteri e della commissione speciale per l’esame delle modifiche al d.lgs. lgt. n 151/1944, relativo alla «scelta delle forme istituzionali»; fu eletto deputato all’assemblea costituente (1946-47) e divenne senatore di diritto durante la prima legislatura repubblicana. Fondò a Palermo l’Archivio di diritto pubblico che successivamente fu chiamata Rivista di diritto pubblico.
Ha dato contributi profondamente innovativi alla scienza giuridica; curò la stesura del Primo trattato completo di diritto amministrativo (1897-1925), in cui furono inclusi i contributi degli autori più autorevoli della materia. In particolare, nell’opera è esposto il cosiddetto «metodo descrittivo» che indica i principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa ed esamina le finalità dell’amministrazione.
Tra le sue opere principali, si segnalano: Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (1887); Teoria giuridica delle guarentigie della libertà (1888); I criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico (1889); Principi di diritto costituzionale (1889, 1931); Principi di diritto amministrativo (1890; 1952); La giustizia amministrativa, (1901); Lezioni di diritto costituzionale (1928); Diritto pubblico generale; scritti vari coordinati in sistema (1940). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[21] Francesco Saverio Nitti. Uomo politico italiano (Melfi 1868 – Roma 1953). Liberale, giornalista, economista e meridionalista di orientamento democratico, come capo del governo affrontò la riforma elettorale, la questione fiumana e le trattative di pace di Parigi. Esule sotto il fascismo, nel dopoguerra fu promotore dell’Unione democratica italiana, membro della Costituente e senatore.
Di modeste condizioni economiche, si laureò in giurisprudenza nel 1890 e iniziò a collaborare con La Scuola positiva e Il Mattino. Liberale e sostenitore di una politica radicaldemocratica in direzione dell’espansione produttiva, diresse dal 1894 La Riforma sociale. Fu prof. di materie economiche alla Scuola superiore di Portici (1895) e all’univ. di Napoli (1899) e si occupò in particolare di rapporti tra Nord e Sud, divenendo tra i più ascoltati studiosi della questione meridionale. Nel 1907 fu eletto deputato e indirizzò la sua azione, anche in polemica con i provvedimenti particolaristici del governo Giolitti, verso interventi strutturali e di lungo periodo. Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio del governo Giolitti (marzo 1911 – marzo 1914), N. contribuì alla creazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni e sostenne la modernizzazione produttiva del Mezzogiorno attraverso l’espansione delle società di elettricità. Fu poi ministro del Tesoro nel governo Orlando (ott. 1917 – genn. 1919), impegnandosi nello sforzo bellico e nella ripresa economica. Dal giugno 1919 al giugno 1920 fu capo del governo, alle prese con la riforma elettorale, con la questione fiumana (che riuscì solo in parte a comporre sul piano internazionale), con i tentativi di riformare i trattati di Versailles e, soprattutto, con i problemi economici e sociali del dopoguerra. Rieletto alla Camera nel 1921 ma politicamente isolato e bersaglio delle violenze fasciste (fenomeno del quale non valutò appieno la portata), nel maggio 1924 emigrò in Svizzera e dal 1926 visse in Francia. Nell’ag. 1943, a Tolosa, fu arrestato dalle SS e deportato nel Tirolo. Fu liberato nel maggio 1945, tornò in Italia e costituì con B. Croce, V. E. Orlando e I. Bonomi l’Unione democratica italiana. Eletto alla Costituente e poi senatore di diritto. Le opere sono state pubblicate in edizione nazionale, 16 voll., 1958-68.© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[22] Luigi Facta.Uomo politico italiano (Pinerolo 1861 – ivi 1930). Deputato giolittiano dal 1892, fu sottosegretario alla Giustizia, poi all’Interno (1903) e ministro delle Finanze (1913) con Giolitti, ministro della Giustizia con Orlando (1919) e nuovamente delle Finanze con Giolitti (1921). Caduto il 16 febbr. 1922 il Gabinetto Bonomi, il 26 febbraio F. costituì un suo Gabinetto; battuto alla Camera il 19 luglio da una maggioranza antifascista, dopo una lunga crisi senza sbocco, F. ricostituì il ministero (1º agosto), che si trovò ad affrontare la marcia su Roma, deliberando solo alla vigilia della marcia lo stato d’assedio, che non ebbe peraltro l’avallo del re. Ritiratosi dalla vita politica attiva, F. fu nominato senatore (1924)..© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[23] Maffeo Pantaleoni. Nacque il 2 luglio 1857 a Frascati, primo dei tre figli di Diomede – medico, politico e senatore del Regno – e di Jane Isabella Massy Dawson. Aveva cinque anni quando il padre, suo primo maestro, fu costretto all’esilio nizzardo. Dal 1868 Pantaleoni fu in collegio a Saint Germain-en-Laye (nell’Ile de France) e dal 1870 a Potsdam (nel Brandeburgo), dove conseguì la maturità il 22 gennaio 1877. Tornato a Roma per gli studi di giurisprudenza, ebbe come compagno di studi Antonio De Viti De Marco. Con l’amico condivise quell’esperienza, la lettura fuori programma della Theory of political economy (London 1871) di W. Stanley Jevons, che iniziò entrambi al mestiere di economista. Relatore un giovane Antonio Salandra, si laureò il 30 giugno 1880 con la tesi Teoria della traslazione dei tributi (Roma 1882), problema fino allora considerato analiticamente non riducibile. Poco dopo si servì della formidabile cultura filologica impartitagli a Potsdam dal precettore Albert Hamann per smontare la tesi dell’eminente giurista scozzese Henry J. Sumner Maine secondo cui il diritto di età omerica si sarebbe fondato sull’arbitrio occasionale del giudice e non su un costume giudiziale (Saggio intorno ad una questione di diritto preistorico: la teoria delle θέμιστες, in Rassegna nazionale, 1881; Studi storici di economia, 1936).
Nella primavera del 1882 ottenne presso la Libera Università di Camerino (Macerata) il suo primo contratto di docenza. Rifiutando l’aiuto paterno, tenne anche lezioni di greco e latino nel locale liceo e alcuni patrocini legali, lavorando nel frattempo all’opera prima dell’illustre tradizione italiana in scienza delle finanze, il Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche (1883; Studi di finanza e statistica, 1938), saggio rivelatore della natura economica del fenomeno finanziario.
Il Contributo si basa sulla teoria del valore come utilità marginale, mera «applicazione ad una particolare scienza» della teoria logica generale esposta nelle «ricerche di Daniele Bernoulli [1738] sulla “mensura sortis” e di Pierre Simon Laplace [1848] sulla “espérance morale”» (1883; Studi di finanza e statistica, 1938, p. 6). L’analisi della portata applicativa di questa teoria, rispetto a una decisione così complessa come quella di finanza pubblica, lo portò a dare rilievo a quelle pratiche «che si raggruppano sotto il titolo di preparazione del bilancio» (p. 28) e che aiutano a evitare quelle riduzioni nella «libertà di disposizione» dovute a quegli «errori che non si possono evitare» (p. 37). Le parole di Jevons in epigrafe – «It is curious to observe how frequently men are engaged in solving mathematical problems without being aware of the fact» – rivelano la filosofia del Contributo e dell’intera vicenda teorica di Pantaleoni, incardinata sulla questione dell’incertezza (rischio non misurabile, distinto dalla mensura sortis) resa classica una generazione dopo da Frank H. Knight e J. Maynard Keynes.
Dal matrimonio nel 1882 con la romana Emma Ravogli (nata nel 1863) nacquero Diomede (1883), Adelchi (1884), Massimo (1888), Goffredo (1889) e i gemelli Alexis e Marcella (1898).
Nel dicembre 1883 ottenne un contratto di docenza alla Regia Università di Macerata, dove conobbe Alberto Zorli. Indagando i modi di ricavare diagnosi economiche da sintomi statistici, introdusse in Italia il metodo del totalizzatore (Dell’ammontare probabile della ricchezza privata in Italia, Roma 1884). Nel 1885 ebbe la sua prima cattedra, quella di economia alla Scuola superiore di commercio di Venezia diretta da Francesco Ferrara. Allorché Zorli rilevò il Giornale degli economisti, gli affidò la rubrica Rassegna finanziaria, sulla quale Pantaleoni sviluppò un’analisi comparata delle finanze di vari Paesi, propedeutica alla Teoria della pressione tributaria (Roma 1887). Tenne la rubrica fino a tutto il 1886, quando passò a dirigere la Regia Scuola di commercio di Bari, appena fondata. Nell’agosto 1888 si accordò con l’editore Barbera per la pubblicazione di un manuale di economia politica basato sul suo materiale didattico.
In poco tempo videro la luce i Principii di economia pura (Firenze 1889): la teoria era ‘pura’ entro l’ipotesi di assenza di incertezza. E, all’interno di tale perimetro, mostrò come le diverse scuole di pensiero economico poggiassero su quelle stesse basi assiomatiche che, per primo (Caruso, 2012), condensò nella dizione homo oeconomicus. I Principii gli valsero la stima di Léon Walras al quale, d’accordo con De Viti De Marco e Ugo Mazzola, offrì la direzione onoraria della rivista internazionale che avevano in progetto di fondare. L’indisponibilità di Walras li spinse ad acquistare da Zorli il 75% del Giornale degli economisti. Vilfredo Pareto divenne un loro stabile collaboratore e Pantaleoni si congedò per cinque anni dalla didattica.
L’impegno profuso nel Giornale va capito come reazione alla svolta politica determinata dalla Sinistra storica. Nel 1887 il nuovo primo ministro Francesco Crispi si trovò a dover gestire il rinnovo della tariffa doganale con la Francia, principale partner commerciale e finanziario dell’Italia. Avendo il suo predecessore, Agostino Depretis, appena rinnovato la Triplice alleanza, Crispi si scontrò con la tattica dilatoria dei francesi che sfidò con una svolta protezionista basata su un rafforzamento dei rapporti con la Germania.
La pubblicistica anticrispina del Giornale gli costò, nell’aprile 1892, la direzione della scuola di Bari. Pantaleoni tentò di resistere ma, non trovando né un legale disposto a tutelarlo né un ateneo disposto ad accoglierlo e scartata l’ipotesi di candidarsi a deputato di Macerata alle elezioni di novembre, accettò la nomina a direttore della società Cirio offertagli da Giacinto Frascara, direttore della Società generale di credito mobiliare che alla Cirio aveva concesso un prestito condizionato alla facoltà di tale nomina. Poco dopo la morte di Giuseppe Giacomo Alvisi (novembre 1892), libero da ogni vincolo morale, Pantaleoni consegnò al neodeputato Napoleone Colajanni copia della relazione Alvisi-Biagini: fu così che il 20 dicembre 1892 furono resi noti i risultati della commissione parlamentare d’inchiesta sugli istituti di emissione, facendo esplodere quello ‘scandalo della Banca Romana’ che investì l’Italia crispina e il primo governo Giolitti.
Quanto alla ricerca teorica, dopo aver considerato i limiti diagnostici dei metodi statistici (Osservazioni sulla semiologia economica, in Revue d’economie politique, 1892; Studi di finanza e statistica, 1938), tentò di stabilire il rischio non misurabile all’interno della teoria economica: nei Cenni sul concetto di massimi edonistici individuali e collettivi (con A. Bertolini, in Giornale degli economisti, s. 2, III (1892), pp. 285-323; Erotemi di economia, 1925), spostò l’attenzione dai primi ai secondi, relativi o a una collettività di individui o a un individuo lungo una collettività di periodi, e in tal senso regolati dall’edonismo di specie, non più da quello individuale. Giunse a esiti analoghi a quelli smithiani della Theory of moral sentiments: entro l’edonismo di specie l’individuo avrebbe considerato se stesso come una terza persona. Come in Adam Smith la questione aveva una matrice giuridico-politica, essendo i mezzi della teoria pura insufficienti alla produzione di «norme felicitanti» (Erotemi di economia, II, 1925, p. 7).
Nel 1893 la circolazione fiduciaria fuori controllo non era l’unico problema dell’Italia bancaria, orfana della sua principale banca d’investimento, la già ricordata Società generale di credito mobiliare di Frascara. «Non sarebbe stata possibile una grande impresa in Italia senza il concorso del Mobiliare e molto meno che capitale estero intervenisse in Italia, senza essersi assicurata la cooperazione del Mobiliare» (La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano, 1895, poi in Studi storici di economia, 1936, p. 219). Il ritiro dei capitali d’oltralpe in ritorsione alle scelte di Depretis e Crispi costrinse il Mobiliare ad accettare provviste a breve termine e con ciò ad accumulare quel consistente rischio di liquidità che, non appena si materializzò, portò a «la sparizione della banca italiana in Italia» (p. 403). Quel vuoto fu presto coperto da un consorzio di sole banche straniere, a prevalenza tedesca, che fondò la Banca commerciale italiana. La nomina di Pantaleoni nel 1894 a commissario liquidatore del Mobiliare lo mise in condizione di comprendere a pieno la portata storica di questa vicenda che costituì il tema del suo capolavoro, La caduta della Società generale di credito mobiliare italiano (1895), e della sua storia politica.
Il 31 ottobre 1895 vinse il concorso per la cattedra di economia politica a Napoli, rimasta vacante per oltre un anno a causa di una protesta, da lui stesso organizzata, contro i tentativi di eludere la procedura concorsuale e assegnarla per nomina a Francesco Saverio Nitti. I crispini lo attirarono in accuse imprudenti contro Crispi e Umberto I per l’occultamento dei documenti della resa di Makallé (Il Secolo, 28 marzo 1896). Emanuele Gianturco, suo collega a Napoli e ministro della Pubblica Istruzione, poté così deferirlo al Consiglio superiore dell’Istruzione pubblica per violazione dell’art. 106 della legge Casati (avere, con l’insegnamento o con gli scritti, impugnate le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e morale).
La moglie, non più in grado di sostenere tensioni così forti, fu accolta da Pareto in Svizzera dove già erano in collegio i figli Diomede e Adelchi. Pantaleoni rimase a Roma, aiutato dalla madre, con i piccoli Goffredo e Massimo. Deciso a resistere, rifiutò un’importante offerta da Chicago e tentò qualche fortuna imprenditoriale. Alla fine del 1896 Pareto gli procurò un’offerta dall’Università di Ginevra; benché la soddisfazione delle sue pretese economiche avesse costretto l’ateneo a una modifica della legge, Pantaleoni non chiuse l’accordo. Tentò infatti di trasformare la sua partenza in una questione politica, forte dell’essere diventato l’idolo della protesta studentesca poi repressa con la chiusura degli atenei di Roma e Napoli.
Con i suoi insistenti richiami alla prudenza, Pareto lo convinse a partire per Ginevra nell’ottobre 1897. Tormentato dalla nostalgia, incitò i moti popolari e aiutò gli esuli socialisti, convinto che solo un popolo capace di alzare la testa potesse contenere l’autorità pubblica nella sfera delle funzioni necessarie, quelle fuori della portata della responsabilità individuale. Sarà il ricordo della violenta repressione della ‘protesta del pane’ di Milano (maggio 1898), culminata con la medaglia di Umberto I al generale Fiorenzo Bava Beccaris, a fargli rifiutare l’invito a una commemorazione del re, definendo «avvertimento» il gesto del regicida Gaetano Bresci (Pareto, 1960, II, p. 331).
Dieci anni di lotta anticrispina gli valsero il sostegno di radicali, socialisti e repubblicani maceratesi alle elezioni suppletive del marzo 1900. La sua elezione fu strumentalmente contestata dal governo, ma si confermò alle elezioni generali di giugno con oltre il 90% delle preferenze.
Considerando la società individualista come più produttiva di innovazioni, e dunque meglio attrezzata a promuovere quella crescita sufficiente a garantirsi i mezzi per proteggersi da «le tenebre che ricoprono l’avvenire» (Erotemi di economia, I, 1925, p. 264), prevedeva per il socialismo un’evoluzione liberista. Per dirla con Keynes, non vedeva alcuna urgenza nell’antisocialismo per via delle «dark forces of time and ignorance which envelop our future».
Da a-socialista sedette tra le fila radicali. Convinto che la democrazia non dovesse essere «una aristocrazia di nuove clientele», sostenne posizioni liberaldemocratiche e federaliste, liberiste e anticorporative, antimilitariste e anticlassiste. Nel gennaio 1901, dopo oltre un anno di attesa della ratifica governativa, fu nominato professore ordinario a Pavia succedendo a Mazzola, prematuramente scomparso. Le sue intuizioni dinamiche erano basate sul presupposto che fossero di tipo economico solo i rapporti sociali caratterizzati da rapporti di forza incerti (An attempt to analyse the concepts of ‘strong and weak’ in their economic connection, in Economic journal, 1899). Su queste basi introdusse il corso pavese puntualizzando che, nell’analisi dei processi, la determinazione di una posizione iniziale richiedesse un riferimento sia all’informazione disponibile sia ai costi del passaggio da questa a date posizioni finali (Caratteri delle posizioni iniziali e influenza che esercitano sulle terminali, in Giornale degli economisti, 1901).
Nell’aprile 1901 la facoltà giuridica romana, con Salandra e De Viti De Marco, lo chiamò a succedere ad Angelo Messedaglia sulla più prestigiosa cattedra italiana di economia. Nel maggio 1902 perse, per una malattia, il fratello Raoul e, per il dolore, la madre. La sua opposizione a ogni forma di «legislazione di classe» gli valse un isolamento politico di cui ben presto risentì le conseguenze.
L’obiettivo di liberare l’Italia dall’egemonia bancaria tedesca lo portò ad assumere con Giovanni Poli, ex presidente della Cirio anch’egli deputato, compiti di vigilanza su un progetto franco-italiano volto a fondare una banca mista. Le occulte irregolarità della cordata piemontese scaraventarono Pantaleoni al centro di uno scandalo bancario, agostano in tutti i sensi (Lo scandalo bancario di Torino, I-II, Torino 1902-1903). Sebbene dalle inchieste politiche e giudiziarie uscì estraneo persino come testimone, la violenza della stampa giolittiana lese per sempre l’equilibrio del suo rapporto con la politica e quello psicologico della moglie. Pressato da difficoltà familiari, nel giugno 1904 si dimise da deputato per concentrarsi su lavoro e famiglia.
Quanto alla ricerca, approfondì quella sugli strumenti dell’analisi dinamica. La disavventura torinese ispirò il saggio Attribuzioni di valori in assenza di formazione dei prezzi di mercato (in Erotemi di economia, II, 1925) nel quale, rovesciando il tema del Contributo del 1883, mise in rilievo la natura finanziaria del fenomeno economico e aprì la strada italiana agli studi di economia aziendale.
Al congresso della Sips (Società Italiana Progresso Scientifico) del 1907, trattando della separazione tra teoria dell’equilibrio e problema pratico-politico (Una visione cinematografica del progresso della scienza economica, 1870-1907, in Erotemi di economia, I, 1925), propose una concezione (hayekiana prima di Friedrich A. von Hayek) della concorrenza come innovazione nel comportamento di mercato. Poiché ogni innovazione suscita, rispetto alla routine, un aumento temporaneo delle spese correnti, trattò più volte il tema del riparto tra spese specifiche e generali. Al congresso Sips del dicembre 1909 lesse una memoria (Di alcuni fenomeni di dinamica economica, ibid., II, 1925) cui l’American economic association dedicò una sessione del proprio congresso annuale: dopo aver rilevato il carattere statico dell’analisi delle condizioni di equilibrio, propose di distinguere due generi di analisi dinamica, uno relativo ai processi di stabilizzazione a un equilibrio (caso limite dei passaggi a costo zero), l’altro a una sequenza di passaggi dall’una all’altra posizione di non-equilibrio (caso generale dei passaggi costosi).
Nel corso del 1911-12 (Legislazione del credito e delle operazioni di borsa, Roma 1912, pp. 196-198) chiarì come il commercio di titoli con strategie di breve termine costituisse fattore d’instabilità dei mercati finanziari.
«In tutti i suoi lavori Pantaleoni riassume un’epoca e ne inizia un’altra: è il maestro che associa idee disparate, che suscita dubbi, che scopre nuovi orizzonti […] L’opera sua è animata da una passione così profonda di uomo, di cittadino, di maestro, da assicurargli l’ammirazione delle generazioni che verranno anche là dove potranno avvertire la natura inconsistente o caduca di certe sue invettive politiche, specie di quelle posteriori al 1914, a cui si contrappone il valore duraturo dei suoi magistrali contributi scientifici» (Fubini, cit. in Zanni, 1978, p. 9).
Con lo scoppio della Grande Guerra l’opinione pubblica si polarizzò tra neutralismo socialista e interventismo nazionalista. Pantaleoni organizzò una strategia di propaganda interventista che si riverberò ben oltre il dibattito contemporaneo. Rassegnato all’idea che le categorie politiche fossero meri miti funzionali alla gestione mentale di un complesso di elementi concreti (Idea nazionale, 5 novembre 1914), e abbastanza disilluso da non vagheggiare una tale funzionalità per il mito liberista, introdusse nel dibattito politico italiano l’accusa di disfattismo, ispirandosi alle invettive di Urbain Gohier contro il leader socialista Jean Jaurès. Oltre che come occasione di recupero del «deficit morale» alimentato da agitazioni e statolatria impartita al Paese da giolittiani e socialisti (Giornale d’Italia, 21 aprile 1914), interpretò la guerra come lotta di indipendenza dalla Germania che, per tramite di giolittiani e socialisti, avrebbe tenuto in pugno banca, stampa e parlamento (Idea nazionale, 15 maggio 1915). Quanto più il protrarsi della guerra alimentava i timori di una sconfitta (e dunque di un’affermazione socialista in Italia), con tanta più veemenza accusava i socialisti di disfattismo.
Altrettanto notevole fu una teoria generale delle crisi (Annali di economia, 1925), centrata sul tema della radicale incertezza della prognosi economica e premessa a una relazione giudiziaria del 1912.
L’interesse per le indeterminatezze dell’analisi dinamica gli fece declinare le insistenti richieste di un nuovo manuale didattico.
Con la morte della moglie, nel 1910, erano maturati i tempi per un ritorno sulla scena politica. Nel 1912 tenne la Cronaca del Giornale degli economisti. Incitò alla vittoria della guerra italo-turca, «necessaria» sia per argomentate ragioni di politica internazionale, sia per tacite ragioni nazionali se non anche personali: così come i timori dell’Italia bancaria di una crisi innescata da un insuccesso bellico spinsero la Corona e la stampa ad alimentare la retorica nazionalista, così quelli di Pantaleoni per le allora buone sorti di una sua impresa di laterizi possono conciliare i toni xenofobi delle sue cronache (in particolare quella del gennaio 1912) con la sua caustica quanto lapidaria valutazione dei nazionalisti (in Salucci, 1913, p. 181).
Dal 1920, dopo una breve e sterile collaborazione con Gabriele D’Annunzio a Fiume (dove diresse le finanze della Reggenza italiana del Carnaro), interpretò la ‘vittoria mutilata’ come esito di una congiura ebraica volta al dominio delle nazioni con le armi della propaganda bolscevica e della finanza internazionale. Suo principale alleato nella reazione ai ‘socialisti del Kaiser’ fu Giovanni Preziosi.
Alla base dei suoi interventi (raccolti in Note in margine della guerra, 1917; Tra le incognite…, 1917; Politica…, 1918; La fine provvisoria…, 1919; Bolscevismo italiano, 1922) la convinzione che la rivoluzione russa e la conferenza di Parigi avessero messo l’ordine economico mondiale su un crinale favorevole ai socialisti: la sostituzione di un regime interno e internazionale di prezzi economici con uno di prezzi politici avrebbe eroso le premesse economiche della civiltà ottocentesca, riportando l’orologio del progresso sociale all’ora medievale. L’unico mito in grado di sostenere una reazione liberista e conservatrice dei valori risorgimentali gli apparve quello nazionalista, poi assorbito in quello fascista.
Il 1° marzo 1923 fu nominato senatore da Vittorio Emanuele III. Ricoprì diversi incarichi e con Alberto De’ Stefani, ministro delle Finanze e suo ex allievo, cercò di portare il governo Mussolini su posizioni liberiste. Al Senato si fece assistere, senza mai rivelargli le condizioni dell’angina pectoris che lo tormentava, dal teatino Umberto Ricci, professore a Macerata e suo successore alla cattedra romana.
Ricci fu uno dei tre lincei che nel 1933 si dimise dall’Accademia per non accettare il giuramento imposto dal fascismo; De Viti, l’amico di sempre, fu tra i sette che si rifiutarono a testa alta.
Pantaleoni difese il governo anche dopo l’omicidio Matteotti (1924). Quando lo vide raccogliere le redini della protezione bancaria capì però che i suoi sforzi si sarebbero rivelati vani. Non per questo smise di riproporre il grande tema della sua vita politica: come l’ignoranza della tecnica bancaria generasse conflitti d’interesse che minano la stabilità del sistema finanziario. L’ultima volta fu quando, invitato al Congresso internazionale delle Casse di risparmio, partì per Milano nonostante la salute precaria. «Vi pronunziò [in francese] un discorso mirabile, durato 50 minuti. Man mano che parlava, la sua voce si affievoliva: appena ebbe terminato il discorso, cadde a terra» (Ricci, 1939, p. 20).
Fu così che, il 29 ottobre 1924 a Milano, «Italy lost the prince of her economists» (Sraffa, 1924, p. 648).
«Alla pari del padre […] fu uomo di studio e d’azione nel senso più comprensivo ed elevato dell’espressione. Coltissimo e geniale, sfugge, per la molteplicità degli interessi spirituali, per la vivacità dei contrasti intimi, per l’originalità possente, ad ogni tentativo accademico di incasellamento, da cui egli, per primo, rifugge costantemente con orrore. La sua vita è divisa tra le cure domestiche, la vita degli affari, l’attività politica e la meditazione: le svariate occupazioni gli lasciano poco tempo per l’attività scientifica, qual è comunemente concepita; eppure egli si rivela non solo scienziato, ma scienziato di tempra superiore. Maestro dei maestri, guida la propria generazione, [Vilfredo] Pareto e [Enrico] Barone compresi, negli studi economici e sociali» (Fubini, cit. in Zanni, 1978, p. 5).
Sarebbe stata questa l’introduzione alla voce dell’Enciclopedia Italiana dedicata al ‘principe degli economisti italiani’ se, nel 1934, De’ Stefani e Giovanni Preziosi non avessero imposto a Gustavo Del Vecchio, direttore della sezione economia e statistica, la rinuncia al testo di Renzo Fubini in cui erano messi in cattiva luce l’impegno di Pantaleoni a favore del fascismo e più in generale la sua attività politica dopo la Grande Guerra.
Opere. Si segnalano: Scritti varii di economia, I, Palermo 1904, II, Palermo 1909, III, Roma 1910; Note in margine della guerra, Bari 1917; Tra le incognite. Problemi suggeriti dalla guerra, Bari 1917; Politica. Criteri ed eventi, Bari 1918; La fine provvisoria di un’epopea, Bari 1919; Bolscevismo italiano, Bari 1922; Temi, tesi e problemi di economia politica teorica e applicata, Bari 1923 (con R. Broglio D’Ajano); Erotemi di economia, I-II, Bari 1925; La crisi del 1905-1907, in Annali di economia, I (1925), 2, pp. 301-542; Studi storici di economia, Bologna 1936; Studi di finanza e statistica, Bologna 1938. Fonti e Bibl.: Le importanti lettere a Vilfredo Pareto sono andate distrutte a causa di una troppo ligia esecuzione delle volontà del destinatario. I materiali di interesse archivistico sono sparsi in diverse sedi. La collezione più importante è costituita dalla sua biblioteca personale conservata presso la Biblioteca comunale Mozzi Borgetti di Macerata. Riccardo Pantaleoni è il prezioso custode della memoria familiare. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[24] Cesare Rossi. Giornalista (Pescia 1887 – Roma 1967). Redattore (1905-15) di varî giornali socialisti e direttore della Voce Proletaria, passò al Popolo d’Italia (1915-24) e aderì al fascismo; capo dell’ufficio stampa della presidenza del Consiglio (1923-24), fu costretto alle dimissioni in seguito al delitto Matteotti, accusato di aver stretto rapporti, da lui stesso mai chiariti, con A. Dumini, responsabile materiale del rapimento e dell’assassinio di Matteotti. Redasse un Memoriale (circolato fin dal giugno 1924, e pubblicato dal Mondo di G. Amendola il 27 dic.), in cui la responsabilità del delitto veniva attribuita a Mussolini. Riparato in Francia nel 1926, fu arrestato dalla polizia italiana a Campione nel 1928 e condannato nel 1929 dal tribunale speciale a 30 anni di reclusione. Riprese l’attività pubblicistica nel 1946 (Mussolini com’era, 1947; L’assalto alla Banca di sconto, 1949; Il tribunale speciale, 1952; Il delitto Matteotti, 1955).© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[25] Giacomo Matteotti. Nacque a Fratta Polesine, presso Rovigo, il 22 maggio 1885, da Girolamo e da Elisabetta Garzarolo.
Il padre, originario di Comasine in Val di Pejo, a venti anni s’era stabilito a Fratta, dov’era riuscito a mettere insieme una discreta fortuna. Morì nel 1902 e a sostituirlo nell’attività commerciale fu la moglie Elisabetta, una donna energica che riuscì ad accrescere il già cospicuo patrimonio familiare.
Secondo di tre figli, il M., dopo aver conseguito la maturità a Rovigo, frequentò la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna, dove si laureò nel 1907 con una tesi sulla recidiva.
Influenzato da Matteo, il fratello maggiore, il M. s’iscrisse al Partito socialista italiano (PSI) intorno al 1900. I primi segni della sua presenza in seno a esso si ebbero dal 1904, quando ne La Lotta, il periodico socialista di Rovigo, venne indicato come l’elemento di riferimento del PSI per la zona di Fratta. Sino al 1908 le testimonianze di un suo impegno politico furono alcuni articoletti apparsi nelle colonne de La Lotta, nel cui comitato di redazione entrò nel maggio 1908. L’anno successivo s’impegnò attivamente nella campagna elettorale per le elezioni politiche a favore della candidatura di I. Bonomi.
Tra il 1909 e il 1910 i suoi due fratelli, Matteo e Silvio, morirono per tisi. La tragedia familiare gli provocò un’acuta crisi, che lo indusse a ritirare la sua candidatura alle elezioni provinciali suppletive del luglio 1910. Seguì un lungo viaggio di studio in Inghilterra, da dove il M. rese nota ai compagni di partito la sua rinuncia a occupare la carica di consigliere provinciale per il mandamento di Occhiobello, dov’era riuscito eletto malgrado non avesse condotto la campagna elettorale. La crisi non dovette durare a lungo, poiché già nell’ultimo scorcio del 1910 fu tra i protagonisti della vita politica di Rovigo.
Avvalendosi della legge elettorale, che consentiva di presentare la candidatura in ogni Comune dove si possedevano terre, il M. ricoprì contemporaneamente la carica di sindaco di Villamarzana e di consigliere di diversi altri Comuni della zona.
Fu tra i più risoluti avversari della guerra libica, tanto che al congresso nazionale del PSI tenutosi a Reggio Emilia nel luglio 1912 prese le distanze dall’ala socialriformista turatiana, esitante nel condannare l’impresa libica, per unirsi ai massimalisti.
Alle elezioni provinciali del febbraio 1915 è legata una sua clamorosa gaffe, che comportò la sua decadenza dalla carica di consigliere provinciale. Si discutevano in Consiglio i ricorsi dei socialisti contro tre consiglieri del blocco cattolico-liberale, la cui elezione era ritenuta incompatibile con le cariche che costoro ricoprivano nella esazione dei tributi comunali nella provincia di Rovigo. L’arringa del M. era stata particolarmente severa. Senonché il consigliere cattolico U. Merlin rivelò come il M. si trovasse nella stessa condizione dei tre inquisiti, poiché risultava fideiussore della Banca del Polesine per il servizio di esazione dei tributi del Comune di Badia Polesine. La vicenda si concluse male per il M.: nell’agosto del 1916, quando ormai era stato chiamato alle armi, venne dichiarato decaduto dal Consiglio provinciale.
Al congresso socialista di Ancona del 1914 il M. si trovò per la prima volta ad affrontare B. Mussolini. Entrambi avevano presentato due distinte mozioni che sanzionavano l’incompatibilità della doppia iscrizione al PSI e alla massoneria. Ma mentre quella di Mussolini imponeva l’espulsione di chi non si fosse conformato alle deliberazioni congressuali, quella del M. si limitava ad auspicare il volontario abbandono della doppia iscrizione da parte dei socialisti massoni. Tale posizione, conciliante nei confronti dei compagni massoni, ha indotto alcuni studiosi ad avanzare l’ipotesi, tuttavia mai documentata, dell’appartenenza del M. alla massoneria. Occorre anzi ricordare al riguardo un suo articolo antimassonico, Per la conquista del Comune e della Provincia di Rovigo (in La Lotta, 20 giugno 1914), con cui si schierava contro il blocco composto da radicali, repubblicani e socialisti riformisti, «amalgamati – scriveva il M. – dal cemento della solidarietà fratellevole delle logge».
Il M. fu un coerente antimilitarista. Allo scoppio della guerra si schierò senza esitazioni contro le posizioni interventiste di Mussolini. La sua intransigenza lo condusse al conflitto con i leader della sua stessa frazione, C. Treves e F. Turati, prudentemente comprensivi sulle ragioni della guerra, e a scavalcare a sinistra anche le posizioni degli esponenti dell’ala più estremista del PSI. Mentre questi si battevano per lo sciopero generale contro l’eventualità di un ingresso in guerra dell’Italia, il M. sostenne con decisione l’ipotesi dell’insurrezione popolare.
La sua fedeltà alla linea antimilitarista gli attirò molte accuse di simpatie per l’Austria. Durante le sedute del Consiglio provinciale venne più volte tacciato di «austriacante», ma a chi lo invitava ironicamente ad andarsene in Austria, replicava sferzante che lì almeno non si moriva di pellagra. In un burrascoso intervento al Consiglio provinciale del 5 giugno 1916, arrivò a opporsi alla proposta di un’erogazione straordinaria per i profughi della provincia di Vicenza che, incalzati dalla Strafexpedition di F. Conrad von Hötzendorf, si erano riversati in quella limitrofa di Rovigo. L’incidente al Consiglio provinciale gli valse una denuncia e la condanna a un mese di carcere, annullata in Cassazione. In effetti un suo criptotriplicismo si coglie in alcuni passaggi di una lettera del settembre 1914 a Velia Titta, sorella del baritono Titta Ruffo, in cui considerava legittimo da parte del PSI il ricorso all’insurrezione «se si volesse domani con assai poca lealtà lanciarci in una guerra contro l’Austria» (Lettere a Velia, pp. 68 s.). Nel gennaio del 1916 sposò Velia (1890-1938), dalla quale ebbe tre figli: Giancarlo (1918-2006), che fu deputato dal 1946 al 1963, Gian Matteo (1921-2000), che fu deputato e più volte ministro della Repubblica, e Isabella (1922-1994). Le origini trentine del padre e alcuni legami familiari della moglie contribuivano ad alimentare le sue simpatie per l’Austria-Ungheria. Due sorelle della moglie, Fosca e Settima, avevano sposato due fratelli di nazionalità boema, Emerich e Guglielmo Steiner. In Italia viveva inoltre un terzo Steiner, Max, il quale, allo scoppio della guerra, era stato internato in Sardegna. Infine, gli Steiner avevano altri due fratelli, ufficiali dell’esercito austro-ungarico, che stavano combattendo sul fronte italiano. Quando fu richiamato alle armi, il M. venne assegnato a un reggimento di artiglieria di campagna di stanza a Verona, ma, ritenuto «un pervicace, violento agitatore, capace di nuocere in ogni occasione agli interessi nazionali» (Roma, Arch. centr. dello Stato, Casellario politico centrale, b. 3157, f. Matteotti Giacomo), fu internato a Campo Inglese, una sperduta località della Sicilia orientale.
Congedato nel marzo del 1919, il M. riprese il suo posto nelle file del movimento socialista. Nell’ottobre del 1919 intervenne al congresso di Bologna, rappresentando la corrente dei massimalisti elezionisti che si presentava divisa. Da una parte v’erano quelli che, suggestionati dalla rivoluzione bolscevica, teorizzavano l’uso della violenza come unico mezzo per impadronirsi del potere, dall’altra v’era chi, come C. Lazzari e F. Maffi, sosteneva, contro le suggestioni del modello sovietico, che qualunque progetto rivoluzionario dovesse tener conto delle tradizioni italiane e del suo proletariato. Il M., pur schierandosi con questi ultimi, ispirò tuttavia il suo intervento congressuale a un forte richiamo all’unità del PSI, in cui, a suo avviso, dovevano avere diritto di cittadinanza «tutti coloro che vogliono sostituire il regime socialista al regime capitalista» (Il Partito socialista italiano nei suoi congressi, pp. 67 s.). Egli vedeva messa in pericolo tale unità dal dibattito dei teorici. Perciò, in polemica sia con i massimalisti serratiani, «che vogliono la insurrezione come fine e non come mezzo», sia con i turatiani, «che vogliono la riforma come fine non come mezzo» (ibid.), egli, molto pragmaticamente, rivendicava il primato delle organizzazioni sindacali di classe sulla sovrastruttura partitica, e quello della lotta contro le strutture economiche del potere borghese. Al partito, libero dal mito della conquista violenta del potere politico, affidava il ruolo d’indirizzare le lotte economiche «verso il fine del socialismo». Il M. considerava quindi le leghe e le organizzazioni sindacali gli elementi dinamici e primigeni su cui far leva per la costruzione della società socialista.
Le sue erano le posizioni di un riformismo coerente, ben distinte da quelle del socialriformismo turatiano ormai dimentico, a suo dire, degli obiettivi socialistici per i quali erano nate le organizzazioni della classe operaia. Una posizione, quella del M., che ha indotto qualcuno a coniare per lui il termine, solo apparentemente antidiadico, di riformista-rivoluzionario. Se si aggiunge al primato che il M. attribuiva alle lotte sindacali l’accento da lui costantemente posto sul volontarismo e sulla preminenza dell’azione nella lotta politica, è difficile negare l’ipotesi d’una sua originale rielaborazione di alcuni capisaldi del pensiero di G. Sorel e di H. Bergson, del resto già rilevati da P. Gobetti. Il rapporto del M. con Sorel non era tanto da cogliere su un terreno immediatamente politico, quanto piuttosto su un piano intellettuale «più generale e perciò anche più profondo, che dalla comune matrice antipositivistica e volontaristica passava ora attraverso la comune avversione alla guerra e alla “borghesia patriottica”» (Carini, p. 75). Una presenza ispiratrice, quella soreliana, che spiega sia la sua mai del tutto sopita diffidenza per il latente opportunismo presente nelle posizioni turatiane, sia la sua convergenza, espressa in più occasioni, con ben definiti settori del massimalismo socialista.
Il M. era considerato dal gruppo dirigente socialista uno dei più preparati tra i leader emergenti. Erano apprezzate le sue capacità di amministratore: perciò venne chiamato, sin dal gennaio del 1916, a far parte della segreteria della Lega dei Comuni socialisti. Nelle elezioni politiche del novembre 1919 fu eletto per la prima volta deputato, per il collegio di Rovigo e Ferrara, riportando il maggior numero di preferenze rispetto agli altri cinque candidati socialisti eletti con lui.
Il biennio rosso vide il M. impegnato a dirigere le lotte bracciantili e contadine per il rinnovo dei patti agrari e a fronteggiare, dall’inizio del 1921, il nascente squadrismo fascista padano particolarmente rozzo e violento. Presente alla prima giornata del congresso del PSI del 1921 a Livorno, dove si consumò la scissione che dette origine al Partito comunista d’Italia (PCd’I), egli tuttavia lasciò anzitempo l’assise livornese per raggiungere Ferrara, dove, a seguito dei sanguinosi fatti di Castello Estense, era stato arrestato il gruppo dirigente della federazione socialista.
Sulla incombente scissione il M. aveva già espresso la sua opinione con un articolo (La Lotta, 18 dic. 1920), in cui auspicava che le divisioni dei gruppi dirigenti del partito risparmiassero almeno le organizzazioni sindacali. Aveva poi ricordato ai congressisti, con un telegramma spedito da Ferrara, le loro responsabilità sui pericoli che sovrastavano l’unità dei lavoratori. Riaffiorava la sua antica diffidenza per le dispute dottrinarie, fonti di divisioni, mentre solo l’azione e le lotte economiche rappresentavano un terreno d’intesa e di ricomposizione unitaria delle classi lavoratrici.
Il M. non tardò a comprendere il pericolo che per le organizzazioni operaie rappresentava il nascente movimento fascista. Tuttavia tendeva a spiegare l’affermarsi del fascismo come reazione alle importanti conquiste ottenute attraverso le grandi lotte contadine del 1919 e del 1920. Il fascismo era quindi la risposta violenta della borghesia agraria ai propri interessi lesi dai nuovi patti agrari. Anche se si tratta di un’analisi riduttiva del fascismo, che risente del particolare punto di osservazione da cui veniva analizzato il fenomeno, cioè il Polesine, dove in effetti l’iniziativa del fascismo appariva funzionale agli interessi degli agrari, tuttavia v’era in essa implicita la convinzione del sostegno ai valori della democrazia, contro l’illegalismo fascista, di ampi settori della borghesia, soprattutto nei ceti medi urbani. Perciò una lotta coerentemente condotta dal proletariato, svincolato dallo slogan della dittatura del proletariato, in difesa delle istituzioni democratiche, avrebbe potuto rappresentare, a suo avviso, il collante di un’alleanza tra movimento socialista e settori non trascurabili dei ceti medi e della borghesia democratica.
La lotta al fascismo favorì la maturazione politica del Matteotti. Le sue frequenti e coraggiose denunce delle violenze squadristiche lo resero un dirigente popolare, consegnandolo nel contempo all’odio del radicalismo fascista. Il 12 marzo 1921 subì una gravissima violenza dai fascisti di Castelguglielmo. Il M. tuttavia, sebbene messo al bando dalle organizzazioni fasciste polesane, partecipò attivamente alla campagna per le elezioni politiche del maggio 1921, dove riuscì eletto nel collegio Padova-Rovigo.
Ma intanto la crisi del regime liberale andava precipitando. Al governo Bonomi, caduto nel febbraio del 1922, subentrava il debolissimo governo Facta, e ciò rese più baldanzoso lo squadrismo fascista. Dalle spedizioni punitive contro i militanti socialisti o le sedi di organizzazioni operaie, si passò all’occupazione dei capoluoghi di provincia, come nel caso di Ferrara e Rovigo, invase, nel maggio del 1922, dalle squadre di I. Balbo. L’offensiva fascista accelerò la crisi interna del PSI, che non s’era sopita nemmeno con l’uscita dei comunisti.
Al congresso di Milano dell’ottobre 1921 il PSI si presentò ancora diviso. A fronteggiarsi erano la componente concentrazionista di Turati e G. Baldesi e quella favorevole all’adesione alla III Internazionale. Il M., pur dichiarando che «avrebbe voluto rappresentare la tendenza che ponesse fine alle tendenze, ammettendo tutti quei metodi che fossero compatibili con la lotta di classe» (Il PSI nei suoi congressi, pp. 190-192), alla fine aderì alla frazione concentrazionista, non tanto per una conversione al riformismo turatiano quanto piuttosto per il suo rifiuto del comunismo e del modello rivoluzionario bolscevico. Il M. cercò invano di attirare l’attenzione del congresso sulle questioni strategiche che l’ascesa del fascismo poneva al movimento operaio. Tentò di convincere una distratta maggioranza che i temi all’ordine del giorno non erano certo né l’adesione alla III Internazionale né la conquista violenta del potere, ma piuttosto la battaglia contro l’offensiva fascista, e che il fascismo non era un fenomeno transitorio da combattere con l’attendismo di Turati, ma un’emergenza da affrontare in modo deciso e organizzato.
Al congresso di Roma dell’ottobre 1922 la corrente riformista abbandonò il PSI e dette vita al Partito socialista unitario (PSU). Il M. venne chiamato a ricoprire il ruolo di segretario.
Nella sua nuova carica condusse una lotta su due fronti: verso l’esterno contro il fascismo, e verso l’interno contro le tendenze collaborazioniste manifestate nei confronti del governo Mussolini da alcuni settori del PSU. Il M. le considerava due momenti di una stessa strategia: era infatti convinto che quanto più fosse riuscito a far risaltare il carattere reazionario e antioperaio del fascismo tanto più difficile sarebbe risultata la manovra dei collaborazionisti di aggancio al ministero Mussolini.
Il periodo che va dagli inizi del 1923 fino alla sua tragica morte è quello più drammatico della vita politica del Matteotti. Frenare le spinte di Baldesi, E. Colombino, L. D’Aragona per il compromesso ministeriale significò impegnarsi in una logorante iniziativa politica per far risaltare l’antitesi inconciliabile tra fascismo e forze democratiche, per far affiorare, da dietro la facciata rispettabile del fascismo moderato e mussoliniano, la vocazione reazionaria e totalitaria del fascismo della provincia, rozzo e intransigente, fin quasi a sollecitarne le manifestazioni più torbide e violente, consapevole di esporsi personalmente alle inevitabili rappresaglie. Scaturì proprio da tali esigenze l’idea di scrivere Un anno di dominazione fascista (Roma 1924), un opuscolo con cui il M. intendeva porre in risalto il carattere sostanzialmente antiproletario dei primi provvedimenti del governo fascista. La voglia di collaborazionismo non si limitava tuttavia alla componente di destra della Confederazione generale del lavoro (CGdL). Baldesi poteva contare su un tacito avallo dello stesso Turati, il quale più volte rimproverò al M. la sua «ostilità preconcetta» nei confronti del dirigente sindacale. Quando Baldesi, all’indomani della marcia su Roma, incontrò Mussolini e G. D’Annunzio, allo scopo di esplorare l’ipotesi di una riunificazione sindacale sotto gli auspici del capo del fascismo, Turati, in una intervista a Il Mondo, garantì la copertura politica all’iniziativa di Baldesi.
Il M. non poté far altro che indirizzare al vecchio leader una lettera molto dura di protesta. Egli non si faceva illusioni sulle false aperture operate da Mussolini nei confronti delle organizzazioni proletarie: il fascismo era il vero nemico della classe operaia e per combatterlo occorreva, a suo avviso, ritrovare rapidamente l’unità del movimento socialista. Fece più volte intendere d’essere tornato a riesaminare, proprio alla luce dell’affermazione del fascismo, le ragioni che avevano condotto i riformisti alla scissione e di essere giunto a valutare le passate divergenze «tutte astratte e proiettate nel più lontano futuro», tali perciò da non autorizzare il mantenere «divisa la classe lavoratrice italiana e toglierle tutto quel lievito di speranze, di ardimenti, di consensi che soli possono permettere un’azione efficace, entusiastica e concorde nel momento attuale» (Filippo Turati attraverso le lettere di corrispondenti (1880-1925), Bari 1947, p. 2790). La sua intransigenza verso il fascismo, se da una parte aveva contribuito ad accrescere la sua autorità morale, aveva tuttavia finito per rendere politicamente precaria la sua carica alla segreteria del partito, poiché gli aveva inimicato ampi settori di esso, urtando personaggi, come gli organizzatori sindacali, tutti collaborazionisti, che godevano d’un indiscusso potere.
Quanto più il M. si rese conto dell’isolamento di cui soffriva in seno al PSU, tanto più egli raddoppiò gli sforzi per collegare la sua lotta al movimento socialista internazionale, quasi a sollecitare quel sostegno che sentiva mancare nel suo partito. Tra il 1923 e i primi mesi del 1924, mentre intensificava gli sforzi per mantenere il PSU unito all’opposizione, più frequenti si fecero i suoi viaggi all’estero.
Nel febbraio del 1923 si recò a Lilla, al congresso dei socialisti francesi, e il mese successivo a Parigi e a Berlino per incontrare alcuni esponenti della socialdemocrazia tedesca. Dopo quel viaggio il governo fascista gli ritirò il passaporto e vani furono tutti i suoi tentativi di riottenerlo.
Prima che s’inaugurasse la nuova legislatura, nel periodo di chiusura del Parlamento, il M. riprese a recarsi all’estero. Privo com’era del passaporto, si vide costretto a varcare la frontiera clandestinamente. Nell’aprile del 1924 si recò a Bruxelles per partecipare al congresso del partito operaio. Tra il 21 e il 22 aprile raggiunse in gran segreto l’Inghilterra e a Londra ebbe una serie di incontri con i dirigenti del partito laburista e con alcuni membri del governo di R. MacDonald. Il viaggio inglese doveva rimanere segreto e difatti il massimo riserbo circondò la presenza del M. in Inghilterra. Qualcosa del viaggio si conobbe solo dopo la sua morte. Il M. rimase a Londra sino al 26 aprile e tra l’altro prese accordi per la pubblicazione in lingua inglese di Un anno di dominazione fascista. Quel poco che si sa sul contenuto dei colloqui londinesi lo si deve a uno scarno appunto del M. di recente pubblicazione proveniente dagli archivi laburisti, il quale rivela che egli discusse con i dirigenti laburisti anche di due questioni che erano da tempo all’attenzione del governo fascista: la legalizzazione delle case da gioco e la convenzione con la compagnia petrolifera americana Sinclair Oil, segnalando ai dirigenti laburisti «le vicende scandalistiche dei petroli e delle bische» come la dimostrazione della «mentalità affaristica del regime» (G. Bianco, M. a Londra, in G. M. a sessant’anni dalla morte, p. 125). Il M. era convinto che la firma della «convenzione Sinclair», cioè l’accordo stipulato tra fine marzo e i primi giorni di aprile del 1924, dopo lunghe trattative, tra il governo fascista e la compagnia petrolifera americana, con cui veniva concesso a quest’ultima il monopolio della ricerca petrolifera nel sottosuolo italiano, fosse stata accompagnata da opera di corruzione nei confronti di uomini del governo fascista. Lo affermò esplicitamente in un articolo che apparve postumo, nel luglio 1924, sulla rivista English Life, in cui si lasciava andare a un’affermazione gravida di significati. «Noi siamo già a conoscenza – scriveva – di molte gravi irregolarità riguardanti questa concessione. Alti funzionari possono essere accusati di ignobile corruzione e del più vergognoso peculato» (p. 87).
Il M. rientrò in Italia il 30 apr. 1924. Era ormai imminente l’apertura della XXVII legislatura che per l’opposizione si presentava particolarmente difficile. Al M. era stato affidato l’incarico d’illustrare le posizioni del gruppo parlamentare del PSU nella seduta del 30 maggio, in cui si sarebbero discusse la verifica dei poteri e le proposte della giunta delle elezioni. Le elezioni politiche del 6 apr. 1924 avevano premiato la posizione intransigente fatta assumere al PSU dal giovane segretario. Il partito aveva ottenuto una lusinghiera affermazione, giungendo in alcune importanti città, come Milano, addirittura primo fra tutti i partiti di opposizione. Pur avendo segnato un importante punto a suo favore, il M. tuttavia era ben consapevole che la destra collaborazionista del PSU era ancora lontana dal considerarsi definitivamente battuta. Anzi era facile prevedere che essa sarebbe tornata alla carica, soprattutto in considerazione del successo ottenuto dal «listone» governativo. Per rintuzzare i tentativi trasformistici occorreva perciò, a suo avviso, alzare ancora di più il livello dello scontro con il governo fascista.
Un momento di grande tensione vi fu il 30 maggio. La giunta delle elezioni aveva proposto la convalida in blocco degli eletti della maggioranza. Su tale proposta intervenne il M., che, dopo aver manifestato il suo dissenso per una prassi del tutto inusuale nella storia parlamentare, richiese, al contrario, l’invalidazione in blocco degli eletti, motivandola con l’irregolarità dello svolgimento delle elezioni costellato dalle violenze dello squadrismo fascista ai danni dei candidati dell’opposizione. Il suo discorso venne continuamente interrotto dalle urla provenienti dai settori della maggioranza. Fu in tale circostanza che, uscendo dalla Camera, al deputato unitario G. Cosattini che lo accompagnava, il M. disse: «Ora preparatevi a fare la mia commemorazione» (Arch. di Stato di Roma, Tribunale civile e penale di Roma, Corte d’Assise, Processo Matteotti, Testimonianza di G. Cosattini). Mussolini definì l’intervento del deputato socialista «mostruosamente provocatorio che avrebbe meritato qualcosa di più tangibile dell’epiteto di “masnada” lanciato dall’on. Giunta» (in Il Popolo d’Italia, 1° giugno 1924). Inoltre il 3 giugno si radunarono davanti alla Camera alcune migliaia di fascisti romani, che, all’uscita dei deputati, si abbandonarono a una sorta di caccia all’uomo per le vie adiacenti il Parlamento. Fedele al suo programma di non dare respiro al governo fascista, il M., il 5 giugno, portò la sua offensiva in seno alla giunta generale del Bilancio. Si doveva discutere il disegno di legge che autorizzava il governo all’esercizio provvisorio del bilancio. L’analisi delle cifre, anticipate dal presidente della giunta, consentì al M. di concludere che il bilancio ufficiale presentato dal governo alcuni giorni prima al Parlamento e al sovrano, e che prevedeva il pareggio, fosse falso, mentre il bilancio vero faceva registrare un disavanzo di due miliardi.
Sin dal suo ritorno da Londra, il M. aveva fatto richiesta del passaporto per partecipare a Vienna all’esecutivo della II Internazionale, che apriva i suoi lavori il 5 giugno, e che si sarebbe protratto per alcuni giorni. Il M., che sino ad allora s’era visto negare il rilascio, si dovette certo stupire non poco quando si vide concedere il passaporto, seppure limitato alla sola Austria. Tuttavia il M. aveva già deciso di non partire per Vienna, poiché l’11 giugno, mercoledì, alla riapertura della Camera, si sarebbe discusso l’esercizio provvisorio, e le sue competenze economico-finanziarie sarebbero risultate senza dubbio preziose al suo gruppo parlamentare.
A partire dall’8 giugno i quotidiani avevano iniziato a pubblicare la lista dei deputati che s’erano iscritti a parlare sull’esercizio provvisorio, e il M. era segnalato tra questi. Il discorso venne preparato con grande impegno. Chiunque lo cercasse in quei giorni era certo di poterlo trovare in una sala riservata della biblioteca della Camera, davanti a documenti, libri e ritagli di giornale. Le sue giornate erano scandite da lunghe permanenze alla biblioteca, che il M. raggiungeva nel primo pomeriggio e che lasciava verso sera per rientrare a casa. S’era fatta quindi strada in alcuni dei suoi colleghi l’idea che egli stesse preparando un discorso molto forte.
Il 22 maggio era giunto a Roma da Milano un gruppetto di arditi fascisti milanesi capeggiati da Amerigo Dumini e da Albino Volpi. Gli altri componenti erano Giuseppe Viola, Amleto Poveromo, Filippo Panzeri e Aldo Putato. A essi si unirono più tardi lo chauffeur Augusto Malacria e l’austriaco Otto Thiershald. Sin dal loro arrivo, costoro presero a pedinare il Matteotti. Il 10 giugno 1924 alle 16.30 il gruppetto degli arditi attese il M. sul lungotevere Arnaldo da Brescia, e dopo averlo tramortito lo caricò a forza su una Lancia avuta in prestito dal direttore del Corriere italiano, F. Filippelli, che venne lanciata a folle velocità verso ponte Milvio. Sicuramente egli trovò la morte durante la colluttazione seguita al sequestro, colpito a morte da un oggetto acuminato. Il cadavere venne rinvenuto due mesi dopo, il 16 agosto, lungo la via Flaminia, in località Quartarella, in una fossa scavata in una fitta boscaglia. I cinque responsabili materiali del delitto, Dumini, Volpi, Malacria, Poveromo e Viola, erano stati arrestati già nei giorni successivi al sequestro. Il ritrovamento dell’auto, il cui interno era cosparso di enormi macchie di sangue, aveva lasciato poche speranze di ritrovare il M. in vita. Il 20 agosto le spoglie del giovane deputato socialista vennero trasportate via ferrovia a Fratta Polesine, accompagnate lungo il percorso da un impressionante tributo popolare.
L’uccisione del M. e il fatto che l’identità degli assassini riconducesse direttamente a Mussolini provocarono una crisi gravissima nel governo fascista. Essa fu superata solo grazie all’abilità di Mussolini, alle divisioni dell’opposizione e alla corrività del re, che non volle «dimissionare» il presidente del Consiglio per paura del «salto nel buio».
L’istruttoria a carico degli assassini attraversò due fasi. La prima, da giugno a dicembre del 1924, condotta da due magistrati abili e determinati, M. Del Giudice e U.G. Tancredi, si svolse attorno all’ipotesi del delitto volontario e ottenne vistosi successi, che comportarono l’arresto, oltre che degli esecutori materiali del delitto, dei secondi mandanti, alti gerarchi del Partito nazionale fascista (PNF), C. Rossi e G. Marinelli, rispettivamente capo dell’ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del PNF. Merito dell’istruttoria fu l’accertamento dell’esistenza di una organizzazione criminale, una sorta di polizia segreta, la cosiddetta Ceka fascista, che rispondeva direttamente alla presidenza del Consiglio. L’istruttoria riuscì a far chiarezza su molti dei crimini di cui s’era macchiata la Ceka prima dell’omicidio del Matteotti. Ma le esitazioni dell’opposizione e la conseguente ripresa dell’iniziativa da parte di Mussolini dettero coraggio al movimento fascista e allo stesso governo, che riuscì a sottrarre l’inchiesta ai due magistrati per affidarla in mani più sicure, cioè ai magistrati N. Del Vasto e A. Albertini, i quali lavorarono a una ipotesi diametralmente opposta, cioè il delitto preterintenzionale o involontario. Il discorso di Mussolini del 3 gennaio, quasi una sfida alle opposizioni, e la successiva ripresa dello squadrismo fascista fecero il resto. Mussolini, ormai di nuovo in sella, preparò il salvataggio degli arrestati, esecutori e mandanti, promulgando il 31 luglio 1925 un decreto legge di amnistia per i reati politici, indirizzato al salvataggio degli assassini del Matteotti. La sentenza istruttoria del 1° dic. 1925, fondata sulla preterintenzionalità del delitto, consentì la scarcerazione di Rossi, Marinelli, Filippelli, Putato, Panzeri e Thiershald. Il processo celebrato a Chieti nel marzo 1926 si concluse con l’assoluzione di Malacria e Viola e la condanna di Volpi, Dumini e Poveromo a 5 anni, 11 mesi e 20 giorni, dei quali 1 anno e 9 mesi già scontati in attesa della sentenza. I tre avrebbero dunque dovuto scontare ancora 4 anni e 2 mesi di carcere, ma l’amnistia, che prevedeva, nel caso di omicidio, un condono fino a quattro anni della pena, consentì a Dumini e compagni di riacquistare la libertà di lì a due mesi. Per l’omicidio del deputato socialista essi avevano scontato in totale meno di due anni di carcere.
Sul movente del delitto la ricerca storica si sta confrontando da decenni. Alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che si sia trattato di una «lezione» finita tragicamente; vi è poi una versione che in realtà è un corollario della precedente ipotesi, cioè che il crimine trovi una spiegazione nella volontà di vendetta di Mussolini per il discorso del M. del 30 maggio. Vi è infine una più recente ipotesi che spiega il crimine con la necessità di Mussolini di «tappare la bocca» al M. perché convinto che il giorno 11 giugno, il deputato socialista avrebbe rivelato gravi casi di corruzione di cui si sarebbero resi responsabili Mussolini stesso e alcuni gerarchi del partito. In particolare Mussolini avrebbe concesso il monopolio dello sfruttamento del sottosuolo italiano alla compagnia petrolifera Sinclair Oil in cambio di alcune tangenti necessarie per finanziare il suo giornale e il partito fascista. Il M. sarebbe venuto a conoscenza di questa corruzione (del resto aveva cominciato a rivelare qualcosa al riguardo con l’articolo apparso postumo in English Life) e avrebbe avuto intenzione di denunciarla col suo discorso previsto per l’apertura della Camera, cioè l’11 giugno. Documenti pubblicati di recente provano che il governo si aspettava un attacco proprio sulla «convenzione Sinclair». I sicari di Mussolini sarebbero quindi entrati in azione per impedirlo.
Altri scritti del M.: La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici, Torino 1910; La riforma tributaria, Milano 1919; La finanza italiana nel 1921 e alcune note economiche, ibid. 1922; Il disavanzo del bilancio italiano: le imposte dirette e la imposta sui terreni, Roma 1922; Il fascismo della prima ora, ibid. 1924; Discorsi parlamentari, I-III, ibid. 1970. A cura di S. Caretti sono, inoltre, le seguenti raccolte di scritti: Scritti sul fascismo, Pisa 1983; Sulla scuola, ibid. 1990; Sul riformismo, ibid. 1992; Scritti giuridici, ibid. 2003; La questione tributaria, Manduria-Bari-Roma 2006.© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[26]Carlo Felice Nicolis conte di Robilant. Militare, diplomatico e politico (Torino 1826 – Londra 1888). Esponente di una ricca famiglia nobile fu avviato giovanissimo alla carriera militare. Partecipò alla prima guerra di indipendenza segnalandosi per atti di valore a Sommacampagna e a Novara, dove perse un braccio e si guadagnò una medaglia al valore. Prese poi parte alla campagna del 1860, fino alla resa di Gaeta, e alla guerra del 1866, durante la quale fu capo di stato maggiore del terzo corpo d’armata. Promosso generale, fu messo a capo della brigata granatieri di Sardegna e subito dopo destinato a dirigere la Scuola superiore di guerra. Nel 1870 fu inviato a Ravenna come prefetto per reprimere disordini repubblicani e nel 1871 fu mandato a Vienna per sostituire Minghetti come inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la corte austro-ungherese. Rimase a capo di quell’ambasciata fino all’ottobre del 1885. Sebbene favorevole a un’intesa con gli Imperi centrali, consigliò al governo una linea prudente nelle trattative per la stipulazione della Triplice alleanza di cui, nel 1882, fu uno dei firmatari insieme al ministro degli Esteri austriaco e all’ambasciatore tedesco. Nominato senatore del Regno nel 1883, due anni più tardi fu chiamato a dirigere il ministero degli Esteri. Approfittando della mutata situazione europea, nel febbraio 1887 Robilant riuscì a rinnovare il trattato della Triplice alleanza facendo aggiungere in due trattati separati, italo-austriaco e italo-tedesco, clausole a favore dell’Italia per la quale erano ora previsti compensi territoriali in caso di espansione austriaca nei Balcani e l’appoggio tedesco in caso di un conflitto con la Francia su Marocco e Tripolitania. Sempre nel febbraio di quell’anno, per allargare la sfera d’azione dell’Italia e tutelare ulteriormente i suoi interessi nel Mediterraneo, Robilant procedette a stipulare anche un accordo con la Gran Bretagna che impegnava, tra l’altro, i paesi a collaborare per mantenere lo status quo in Africa settentrionale. Costretto a dimettersi in seguito alla sconfitta di Dogali nel 1887, nella quale peraltro non aveva alcuna responsabilità, fu nominato ambasciatore a Londra, dove morì l’anno dopo.© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[27] Mario Maria Martini (1880 – 1953) è stato uno scrittore italiano. Fu attivo a Genova nella prima metà del XX secolo.
Seguace di Gabriele D’Annunzio, partecipò all’impresa di Fiume, esperienza che lo portò a scrivere “La passione di Fiume”, in cui raccolse documenti raccontò i fatti e gli eventi vissuti in loco dal Martini stesso, che venne edito dalla Sonzogno nel 1919.
A Fiume conobbe Giovanni Comisso, che spinse a trasferirsi a Genova nei primi anni ’20 per farlo collaborare alla rivista che aveva intenzione di fondare.
Collaborò con diversi quotidiani genovesi, in particolar modo con “Il Caffaro” (1903-1929) e “Il Giornale di Genova” (1930-1943).
Fondò e diresse tre periodici: “Il Convito” (1902), “La Rassegna Latina” (1907-1908), “Le Opere e i Giorni” (1922-1938), che videro la collaborazione di numerosi intellettuali, tra i quali si possono ricordare Luigi Pirandello, Guido Gozzano, Carlo Vallini, Eugenio Montale e Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Fu inoltre amico dello sportivo e pioniere del volo Giovanni Balbi di Robecco, di cui battezzò lo sperimentale velivolo, completato nel 1910, “Issione”, traendo il nome dall’omonimo personaggio mitologico che concupì una nuvola mutata in donna da Zeus.
Venne scelto per comporre le epigrafi commemorative dei caduti genovesi della prima guerra mondiale sull’Arco della Vittoria, inaugurato a Genova il 31 maggio 1931.(fonte)
[28] Pietro Badòglio. Generale italiano (Grazzano Monferrato 1871 – ivi 1956). Capo di S. M. generale sin dal 1925, condusse la vittoriosa campagna in Etiopia (1935-36). Si dimise durante la seconda guerra mondiale dopo l’insuccesso in Grecia. Chiamato dal re a sostituire B. Mussolini (25 luglio 1943), concluse con gli Alleati l’armistizio (3 sett. 1943). Dopo la liberazione di Roma lasciò il governo a I. Bonomi (10 giugno 1944).
Capitano di S. M. durante la guerra libica, ten. col. all’inizio della guerra italo-austriaca, dopo la ritirata del nov. 1917 fu chiamato dal comando del 27º corpo d’armata alla carica di sottocapo dello Stato Maggiore generale. Capo di S. M. dell’esercito nel 1919, fu poi (1924-25) ambasciatore in Brasile; quindi (1925) capo di S. M. generale e (1926) maresc. d’Italia. Governatore della Libia dal 1929 al 1933, nel 1935-36 condusse rapidamente a termine, in qualità di Alto Commissario per le colonie dell’Africa Orientale, la campagna contro l’Etiopia. Riassunte nel 1936 le funzioni di capo di S. M. generale, che giuridicamente non aveva mai lasciate, si dimise durante la seconda guerra mondiale quando, espresso parere contrario alla guerra contro la Grecia, fu incolpato in seguito dell’insuccesso. Dal 1937 al 1941 fu presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Ritornò sulla scena politica il 25 luglio 1943, allorché venne chiamato dal re a sostituire Mussolini. Costituito un ministero di funzionari, concluse con gli Alleati l’armistizio di Cassibile (3 sett. 1943) e – reso noto questo dagli Alleati l’8 sett. – abbandonò la capitale trasferendosi col re e le più alte autorità militari a Brindisi. Osteggiato per il suo passato e per la sua politica ambigua dalle forze antifasciste non monarchiche, costretto ad accettare il 29 sett. il “lungo armistizio”, ostile all’abdicazione del re, il B. dovette proseguire nel sistema di un ministero tecnico (rimaneggiamento del 16 nov. 1943; gabinetto dell’11 febbr. 1944), finché il ritorno di P. Togliatti dalla Russia e l’atteggiamento da questo assunto gli permisero il 22 apr. 1944 di costituire – accordatisi i partiti sulla luogotenenza del principe Umberto – un nuovo gabinetto su più larga base, durato fino alla liberazione di Roma e alla costituzione del ministero Bonomi (10 giugno 1944). Si ritirò allora a vita privata. Senatore del regno dal 1919, fu dichiarato decaduto nel 1946, ma il provvedimento fu annullato dalla Cassazione nel 1948. A una parente scrittrice, V. Vailati, B. confidò alcuni ricordi (Badoglio racconta, 1955), poi integrati da un volume di V. Vailati e G. Gigli, Badoglio risponde (1958).© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[29] Giovanni Bongiovanni. Nato a Reggio Emilia l’8 dic. 1866 da Giuseppe e da Carolina Bigliardi, studiò all’Accademia militare di Torino e nel 1886 fu nominato sottotenente di artiglieria, entrando poi nel Corpo di Stato Maggiore Dal 1901 al 1905 fu in Giappone con la missione militare italiana; dal 1911 al 1914 fu in Cirenaica come capo di Stato Maggiore prima della 2adivisione speciale e poi del Corpo di occupazione della Cirenaica, conseguendo una medaglia di argento al valore nello sbarco di Bengasi (19 ott. 1911) e la promozione a tenente colonnello per merito di guerra nel novembre 1912, acquistando fama di ufficiale esperto ed energico. Nel 1914-15 fu addetto militare a Berlino durante il delicato periodo della neutralità italiana. Assai apprezzato dalle autorità militari germaniche, poté nei suoi rapporti a Roma dare un quadro fedele dell’atteggiamento degli ufficiali tedeschi dinnanzi alla guerra di posizione. Nel 1915 il B., promosso colonnello, entrò in campagna come capo di Stato Maggiore del VI e poi del II corpo di armata; nel maggio 1916 assunse il comando della brigata Ancona, distinguendosi nella difesa del saliente trentino e ottenendo la croce di cavaliere dell’Ordine militare di Savoia nel combattimento di Monte Novegno (12-13 giugno 1916) e la medaglia d’argento per i combattimenti in Vallarsa (25 giugno-12 luglio 1916). Nell’agosto 1916 passò al comando della brigata Firenze, nel settore di Plava, e fu promosso maggior generale; nel maggio 1917 salì al comando della 3a divisione, con la quale partecipò alle battaglie del Kuk-Vodice e della Bainsizza. Il 7 ott. 1917 il B. fu posto a capo del VII corpo d’armata, che poco dopo venne destinato a schierarsi in seconda linea nella zona di Caporetto per assicurare la saldatura tra il IV corpo del generale Cavaciocchi, a cavallo del massiccio del Monte Nero, e il XXVII del generale Badoglio, che fronteggiava Tolmino. Alla vigilia dell’offensiva austro-tedesca, il VII corpo non aveva ancora completato il suo schieramento sulle alture della destra dell’Isonzo con le divisioni appena assegnategli (3a e 62a ); insufficienti erano inoltre i collegamenti con i comandi di Badoglio e Cavaciocchi e non definiti i rispettivi settori. Il 24 ottobre le truppe austro-tedesche, superate rapidamente le linee di Badoglio, ebbero ragione delle truppe del B. con relativa facilità, approfittando della sorpresa tattica e del terreno favorevole; il VII corpo fu travolto reparto per reparto e cessò praticamente di esistere come grande unità il giorno seguente, malgrado il tentativo del B. di contromanovrare con le scarse riserve. Il 29 ottobre i superstiti passarono il Tagliamento a Piniano; il VII corpo d’armata fu sciolto a fine novembre e il B. fu destinato al comando della 69a divisione, che tenne fino al febbraio seguente. Tuttavia l’inchiesta sulla disfatta non censurò l’operato del B. a Caporetto, ritenendolo vittima della sorpresa alla stessa stregua di Badoglio. Nel marzo 1918 il B. assunse il comando dell’aeronautica italiana, alle dipendenze dirette del Comando supremo, rivelando nel nuovo incarico notevoli doti di organizzatore e legando il suo nome al momento di maggior fortuna dell’aviazione italiana; pur propugnando sempre l’impiego in massa degli aerei, favorì anche imprese spettacolari come il volo su Vienna di D’Annunzio (9 sett. 1918), con il quale era legato. da amicizia (v. L. B., G. D’Annunzio. aviatore in guerra, in Nuova antol., 16 marzo 1939). Sotto il comando del B. fu curato particolarmente l’addestramento dei piloti (il numero delle scuole salì da 17 nel 1917 a 30 ne 1918) e del personale di terra. Per sfruttare meglio le possibilità operative del bombardamento e della caccia, il B. propugnò e ottenne la costituzione della massa da bombardamento e di quella da caccia. Fu intensificato il servizio di esplorazione in campo strategico e soprattutto tattico: è di quell’anno la costituzione del Gruppo I. (Gruppo Informazioni), adibito all’esplorazione del territorio nemico per più di 300 km di profondità, alla fotografia (ogni 15 giorni si fotografavano gli aeroporti nemici) e alla propaganda mediante il lancio di manifestini.
Lasciato il comando dell’aeronautica nel marzo 1919, il B., promosso nel frattempo tenente generale, fu per breve tempo comandante superiore delle forze italiane nel Mediterraneo orientale, con sede a Rodi. Nel 1920 abbandonò il servizio attivo, ma nel dicembre 1922 fu richiamato in servizio e nominato governatore della Cirenaica (7 genn. 1923) col compito di realizzare la riconquista della regione. In Cirenaica, dove il controllo italiano era limitato a una ristretta fascia costiera, e dove il parlamento locale di Bengasi era sotto la presidenza del senusso Safī ad Dīn, che cercava di ottenere un’autonomia più vasta di quella che il trattato di er-Regima aveva riconosciuto alla regione, egli dette pratica attuazione alla nuova politica perseguita da Federzoni con la denuncia dei patti. Proclamò subito lo stato di assedio e, al rifiuto del senusso di rispettare i precedenti accordi di Bū Mariam (30 ott. 1921), dette inizio alle operazioni militari, rioccupando il Sud bengasino fino ad Agedabia (21 apr. 1923). Dichiarò quindi decaduti gli accordi con la Senussia, continuando le operazioni militari. Nel 1924 un incidente di volo costrinse il B. a lasciare il governatorato (24 maggio 1924); collocato a riposo, venne nominato membro (e dal 1927 presidente di sezione) del Consiglio superiore delle Colonie. Senatore nel 1929, r. commissario dell’Istituto agronomico per l’Africa italiana nel periodo 1930-35, continuò a occuparsi di problemi coloniali e militari, collaborando anche a varie riviste. Morì a Roma il 4 apr. 1941. Fra i suoi discorsi al Senato si possono ricordare quello sulla legge Baistrocchi (1934), che il B. lodò come “il solo mezzo… per giungere al definitivo risanamento… dei quadri”; quelli del 13 e 21 maggio 1937 su problemi coloniali (Suiservizi tecnici dell’Impero il primo e Sulbilancio del ministero dell’Africa Italiana ilsecondo, in cui il B. lodava l’operato delle autorità); infine quello del 29 marzo 1938 in cui sosteneva la necessità di un adeguato addestramento delle truppe coloniali per vincere la guerriglia. Tra le sue collaborazioni, una delle più assidue fu quella alla Nuova antologia; si ricordano gli articoli: Bombardamenti dal cielo (16 febbr. 1932); La “Marna“: giudizi in contrasto (16 genn. 1934); Problemi dell’Etiopia italiana (1º giugno 1936). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[30] Alberto Cavaciocchi. Generale italiano (Torino 1862 – ivi 1925). Studioso di storia militare, fu capo dell’Ufficio storico dell’esercito (1906-10) e come tale provvide a pubblicare alcuni importanti volumi di storia risorgimentale. Nella prima guerra mondiale, fu capo di S. M. della 3º armata, poi (dal luglio 1915) comandante della 5º divisione, con la quale operò sull’Adamello (primavera 1916), del XXVI corpo d’armata e infine del IV corpo d’armata, che fu travolto nella giornata di Caporetto; fatto oggetto di gravissime accuse, fu collocato a riposo (1919). © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[31] Luigi Attilio Capello. Generale italiano (Intra 1859 – Roma 1941). Nel 1916, al comando del 6º corpo d’armata, conquistò Gorizia e nel 1917, al comando della 2a armata, ebbe parte decisiva nella presa della Bansizza. Ma, coinvolto nella responsabilità del disastro di Caporetto, fu collocato a riposo. Aderì poi al fascismo, per staccarsene però dopo il delitto Matteotti, partecipando con T. Zaniboni a un complotto contro Mussolini (1925). Condannato a 30 anni di reclusione (aprile 1927), gli fu concesso dopo dieci anni, per la tarda età, di rientrare in famiglia. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata(fonte)
[32] Henri-Philippe-Omer Pétain. Maresciallo di Francia e uomo politico (Cauchy-à-la-Tour, Pas-de-Calais, 1856 – Port-Joinville, isola di Yeu, 1951). Già comandante in capo dell’esercito nella Prima guerra mondiale, nel giugno 1940, come presidente del Consiglio, firmò l’armistizio con la Germania. Fissò la sede del governo a Vichy, nella zona non occupata dai tedeschi, diventando capo dello Stato e instaurando un regime collaborazionista. La condanna a morte comminatagli nell’agosto 1945 fu commutata nella detenzione perpetua.
Ufficiale di fanteria, insegnò alla scuola superiore di guerra. Colonnello all’inizio della prima guerra mondiale, si distinse in Belgio e nella regione di Guise; promosso generale di divisione e quindi di corpo d’armata, nel settembre 1915, prese parte alla battaglia della Champagne. Nel febbr. 1916 P. fu incaricato di arrestare l’offensiva tedesca su Verdun; la tenace difesa della piazzaforte gli valse un’immensa popolarità e la nomina (maggio 1916) a comandante delle armate del centro. Dopo la disastrosa offensiva ordinata da R. G. Nivelle, P. sostituì quest’ultimo come comandante in capo delle truppe francesi (maggio 1917), riuscendo a contenere il fenomeno degli ammutinamenti nei reggimenti di prima linea e a ristabilire il morale e la disciplina tra i soldati, in parte ricorrendo alla repressione, e in parte cercando di migliorarne le condizioni di vita al fronte. Al termine del primo conflitto mondiale, P. fu nominato maresciallo di Francia (19 nov. 1918); inviato in Marocco per reprimere la ribellione di ῾Abd el-Krīm (1925-26), fu chiamato al ministero della Guerra nel febbr. 1934 da G. Doumergue. Nel marzo 1939 E. Daladier lo volle ambasciatore a Madrid per riallacciare le relazioni diplomatiche con la Spagna di F. Franco, da dove, scoppiata la Seconda guerra mondiale, P. tornò per assumere l’incarico di vicepresidente del gabinetto presieduto da P. Reynaud (18 maggio 1940). Profilandosi la disfatta francese di fronte all’attacco tedesco, P. e il comandante supremo, M. Weygand, costrinsero alle dimissioni Reynaud, favorevole a proseguire la lotta nelle colonie. Incaricato della formazione di un nuovo esecutivo (16 giugno 1940), P. concluse rapidamente un armistizio con i Tedeschi, fissando la sede del governo a Vichy, dove il 10 luglio ricevette dall’Assemblea nazionale la nomina a capo dello stato e i pieni poteri, di cui si servì per instaurare, in quella parte del territorio francese non occupata dai nazisti, un regime autoritario, paternalistico e corporativo, il cui motto fu «lavoro, famiglia e patria». P. osteggiò inizialmente la politica di assoluta collaborazione con i Tedeschi propugnata dal suo primo ministro, P. Laval, fatto arrestare nel dic. 1940 e sostituito con l’ammiraglio F. Darlan. Rivelatasi illusoria ogni ipotesi di neutralità e indipendenza, P. dovette acconsentire a una maggiore collaborazione con i nazisti, culminata con il richiamo al governo di Laval (apr. 1942) e proseguita anche dopo lo sbarco alleato nelle colonie dell’Africa del Nord e la completa occupazione del suolo francese da parte tedesca (nov. 1942). Trasferito il governo a Belfort, quindi a Sigmaringen, in Germania (sett. 1944), quando seppe che stava per iniziare a Parigi il processo a suo carico per tradimento, il 24 apr. 1945 P. si costituì volontariamente prigioniero alla frontiera svizzera. Dopo un lungo processo, in cui larga facoltà difensiva gli fu concessa, ma nel quale P. assunse la posizione di non riconoscere l’autorità dell’Alta Corte di giustizia, fu condannato a morte il 5 agosto. Commutata la pena nella detenzione perpetua, fu internato nell’isola di Yeu. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)
[33] Alberto Emanuele Lumbróso. Pubblicista italiano (Torino 1872 – Santa Margherita Ligure 1942), figlio di Giacomo. Partecipò alla guerra del 1915-18 come volontario, e dal 1916 al 1918 fu addetto militare aggiunto in Grecia. Bibliofilo e letterato, donò alla Biblioteca Nazionale di Torino, dopo l’incendio del 1904, tutta la sua biblioteca, particolarmente cospicua per la parte napoleonica. Diresse dal 1903 la Revue napoléonienne, poi la Rivista di Roma. I suoi studî di storia più noti, oltre quelli relativi alla guerra mondiale, riguardano appunto l’età napoleonica. © Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Riproduzione riservata (fonte)